-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
libri_interviste Lo sboom (silvana editoriale 2009)
Libri ed editoria
È recentemente uscito il nuovo libro della collana Fabbricanti di universi. L'Economia del simbolico, diretta da Pier Luigi Sacco per Silvana Editoriale. Ne abbiamo parlato con l’autrice, Adriana Polveroni...
chiedo sugli obiettivi che si pone il tuo libro, il quale in qualche misura
sembra ripercorrere le tappe essenziali della folle corsa dell’arte
contemporanea negli ultimi anni: dal boom allo sboom. Perché questa storia è
importante?
Perché ci ha coinvolto tutti,
ciascuno nel proprio ruolo; perché la folle corsa ha significato anche una
eccezionale popolarità che l’arte non aveva mai conosciuto prima (complice
anche l’aumento dei media che la registrano), fatto che ha contribuito a
cambiarne in parte la natura, trasformandola a sua volta in una merce da
consumare nell’agenda dello shopping. L’obiettivo del libro è minimale:
stimolare una discussione, un po’ come volevo accadesse con This is
contemporary!. Ma
in realtà è un obiettivo ambizioso, data la scarsa propensione all’esercizio
critico che caratterizza il nostro mondo dell’arte, che è piuttosto
conformista.
La crisi economica globale ha
colpito duramente soprattutto i musei degli Usa. Nel libro parli del caso Los
Angeles e di quella specie di lottizzazione del Lacma e del Moca compiuta dal
collezionista Eli Broad. Non ti pare che il tanto celebrato sistema museale
americano stia mostrando dei limiti e una deriva preoccupanti?
Penso di sì, almeno in parte. Un
fenomeno come Eli Broad in America è possibile perché, in assenza della mano
pubblica, i privati hanno una discreta possibilità d’azione e per l’idea
radicata in quel Paese per cui chi ha avuto restituisce parte delle sue
fortune. Da noi, e in Europa, un fenomeno del genere è impensabile. Certo il
grande spazio che i privati hanno in America vincola la produzione culturale:
quando i soldi diminuiscono o non ci sono più, i musei chiudono e le donazioni,
che comunque significano sgravio fiscale, diminuiscono.  Detto ciò, è vero che
Detto ciò, è vero che
negli Usa c’è stata una preoccupante sovrapposizione tra mercato e musei, con
collezionisti che hanno fatto le loro mostre nei musei e poi hanno rivenduto
parte della loro collezione. È successo anche con Charles Saatchi all’epoca di Sensation e i suoi tour espositivi fra la
Royal Academy di Londra e il Brooklyn Museum di New York. Ma forse, in modo
meno arrogante, qualcosa del genere sta accadendo anche oggi, nella piccola
Italia e nelle vetrine internazionali: come giudichi il fatto che Pinault metta
in mostra, a Palazzo Grassi, così tanti brutti pezzi della sua collezione? Si
tratta forse di consigli per gli acquisti a prezzi più elevati dopo il giro
espositivo?
Il nostro è il tempo di un’arte
spettacolarizzata che, scrivi, “non esita a mercificare l’aura”. Archistar costruiscono
megacontenitori, packaging oversize che “assorbono” valore simbolico. L’arte masscult è un fallimento per l’arte?
Non mi sento di rispondere in
maniera netta a questa domanda. Avrei una tentazione un po’ snobistica e direi
che, dopo anni in cui si è affermato il contrario, oggi i risultati deludenti
della cultura di massa sono sotto gli occhi di tutti. Guarda il turismo come ha
snaturato le nostre città d’arte, sebbene, prima di liquidarlo tout court, bisognerebbe chiedersi come
potrebbero produrre economia le nostre città d‘arte. D’altra parte, tornare al
passato penso sia improponibile e neanche troppo sano.
Si tratta allora di
cercare delle modalità di convivenza con la cultura di massa, le più indolori
possibili e le più intelligenti, che magari riescano a fare quel miracolo per
cui la stessa masscult è nata e cioè una crescita diffusa che miri al miglioramento delle
condizioni di vita e, direi, del pensiero. In questo l’arte continua a giocare
un ruolo importante, perché traccia un orizzonte di senso che dev’essere
lasciato libero da finalità produttive e quindi massificanti.
Usi il termine “artenteinment” per spiegare l’arte declinata
in merce. E parli della perdita di senso. Mi pare un passaggio fondamentale…
Per certi versi l’arte ha sempre
avuto un’anima mercantile, è sempre stata collezionata, comprata, ha sempre
prodotto economia, almeno da quando con questo termine intendiamo grosso modo
quello che intendiamo oggi e da quando l’artista si è affrancato dal ruolo di
artigiano. E penso che anche in quest’aspetto risieda parte della sua forza,
che è ambigua e quindi fertile. Se l’arte non avesse a che fare con il denaro,
sarebbe meno attraente. Il problema, come spesso accade, sta nelle proporzioni
e nella relazione che “l’anima mercantile” intrattiene, e negozia, con “l’anima
culturale”. Direi, come sostiene anche Pier Luigi Sacco nella sua lucida
postfazione, che oggi l’elemento mercantile ha avuto il sopravvento, agendo
alle origini di quello che simbolicamente l’arte esprime. 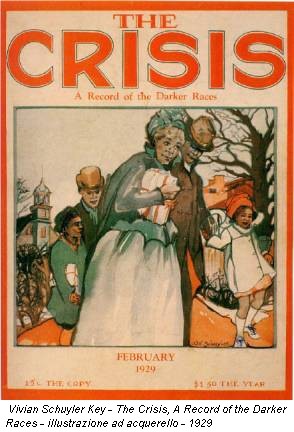 È banale ripeterlo,
È banale ripeterlo,
ma per anni non si è comprata l’opera, ma il nome dell’artista, addirittura la
sua quotazione di mercato. Penso che sia questo comportamento e una sorta di
“idea unica” dell’arte come merce ad aver cannibalizzato il pensiero critico. Dopodiché, trovo che il senso, quello di cui oggi in molti andiamo alla
ricerca, si sia consumato nei tanti riti inutili in cui abbiamo vissuto l’arte:
troppe fiere, troppe mostre, troppe biennali. Non perché dobbiamo fare
penitenza e quindi privarci di un po’ di queste occasioni più che altro
mondane, ma perché tutta questa roba ha poco a che fare con l’arte come
ricerca, come apertura di un orizzonte altro da quello che ordinariamente è
dato.
Gallerie e fiere, ti dico la
mia: credo che molte delle gallerie nate negli ultimi 10-15 anni, a cui è
deputata la promozione di nuovi talenti, siano un prodotto delle fiere, ovvero
dipendano da esse in modo determinante. Sono gallerie naturalmente nomadi, con
un collezionismo non fidelizzato. Com’è cambiato l’istituto della galleria con
il boom?
Anzitutto in termini quantitativi:
sono nate moltissime gallerie che hanno approfittato, come fanno i mitili sugli
scogli, cioè in maniera parassitaria, del successo mediatico e commerciale
dell’arte. Abbiamo vissuto un periodo in cui tutti, artisti e galleristi,
vendevano qualunque cosa. Va da sé che nel mucchio ci sono anche nuove gallerie
che tentano un approccio serio di ricerca. Penso che la pulizia, il “clima
penitenziale” spesso evocato, debba partire da qui: selezione per qualità.
Quindi, la penitenza non c’entra niente.
Dedichi spazio alla figura del
curatore, vero protagonista del boom. Il critico d’arte è letteralmente sparito
dalla circolazione, sostituito da questa figura controversa, che tu definisci
come curatore “multitasking” e “pervasivo”. Tempo fa il noto critico americano Jerry
Saltz li etichettò come public relator, “buttadentro” o poco più. Ma allora il
curatore serve all’arte o viceversa? E ancora: sempre più spesso in giro si
sente parlare dell’atto curatoriale come opera d’arte in sé. Mi interessa una
tua opinione anche su questo…
Mi sembra che oggi la figura del
curatore, di cui molto si parla e che gode di grandi favori, sia più corretto
ribattezzarla in termini di “ideatore”. Spesso il curatore è colui che pensa
una mostra, il concept, e per esempio in questo senso ritengo che Francesco
Bonami sia un eccellente “annusatore” delle tendenze in atto nella nostra
epoca, e penso anche che lavorare concettualmente su un bel tema, chiedere
aiuto all’arte per sviluppare un’emergenza del nostro tempo sia un gesto
avvicinabile (forse non equiparabile) a un’opera d’arte. Ma poi “l’ideatore”
non fa il lavoro curatoriale: seguire l’artista e condividere con lui scelte,
ipotesi di lavoro, in genere lo fa qualcun altro. Se non fosse così i curatori
non potrebbero curare tutto quello che curano a livello globale. E questo è un
aspetto. 
Poi c’è il lato politico della faccenda: da questo punto di vista, e
sposando il linguaggio un po’ crudo ma sempre efficace di Jerry Saltz, direi
che sì, il curatore è un “buttadentro”, nel senso che, rispetto a musei e
biennali, è il garante di una fetta del sistema dell’arte, quella che riguarda
gli artisti e le loro gallerie, quindi una fetta importante, perché tra questo
mondo qui e il curatore s’instaura una sorta di patto di garanzia: l’uno tutela
e garantisce l’altro, e spesso il sistema si chiude. A suggellare questo patto
sono gli sponsor che “si fidano” del tal curatore e del lavoro che gli artisti
scelti da lui fanno. Succede anche con alcune gallerie, le cui iniziative a
latere sono appoggiate da sponsor perché questi “si fidano” degli artisti che
la tal galleria propone, in genere saltando la mediazione del curatore.
Che
dire? Forse bisognerebbe rivedere un po’ di cose, ma non mi pare che ci sia
grande intenzione di farlo. Specie tra i giovani che purtroppo, e mi piacerebbe
tanto essere smentita, sperano di replicare l’exploit di Massimiliano Gioni. È
un’osservazione di Cecilia Casorati che condivido parecchio.
Conformismo, mode, estetica di
maniera compongono quello che è ritenuto il cosiddetto “gusto internazionale”.
C’è ancora spazio per il genio e l’innovazione nell’arte?
Per il genio non lo so, me lo
auguro! Per l’innovazione non ho dubbi: non sarà così diffusa com’è stata in
altri periodi storici, ma mi sembra che, forse in maniera più rapsodica e
isolata, sia presente nel nostro tempo. Il problema mi pare un altro: alcuni
artisti, penso anche ad alcuni italiani, spesso giovani, quando hanno successo
spesso si fermano. Cominciano a ripetersi, mandando all’aria ogni idea
d’innovazione. Sembra paradossale, ma a volte il successo fa male. Induce al
manierismo di se stessi, all’esercizio formale, e che ciò accada a trent’anni è
un po’ triste.
Parliamo dell’Italia, visto che
la Biennale è ancora svolgimento. Nel nostro Paese quanto c’entra la politica
nell’arte? Mai come quest’anno, per le vicende del Padiglione Italia, s’è
parlato di arte di destra e arte di sinistra…
Purtroppo la politica con l’arte
c’entra, ma è vero anche il contrario. Nel senso che c’entra quando si accorge
che può convenirle, non in termini di voti, ma di attenzione mediatica. A parte
questo, alla politica dell’arte gliene frega ben poco, e dovrebbe avere il
coraggio e l’onestà di delegare, non ai soliti amici di amici, ma a chi ne sa.
Per quanto riguarda il Padiglione Italia, dopo averlo visto due volte, posso
dire che è brutto al di là di ogni aspettativa. Non perché, come dice Luca
Beatrice, la puzza sotto il naso della “sinistra” impedisce di trovare un
artista decente fra i venti esposti.
Il problema, come già detto, è che quei
venti fanno a cazzotti gli uni con gli altri per via di un allestimento che non
ha tracciato un percorso di lettura e che non si è impegnato a scegliere il
meglio degli artisti e quindi, secondo me, si è impegnato poco a difenderli
dalle critiche. Ha riempito lo spazio e basta, e purtroppo oggi la grande
disponibilità degli spazi può essere un boomerang. E a proposito di sinistra,
si è pure caduti nel tranello politico. Quando Luca Beatrice, che certo non è
sciocco né impreparato, dice che fa un’arte di destra, sa di buttare un amo a
cui i vari pesci critico-giornalistici abboccheranno con tutte le scarpe. E
così si fa finta di parlare di politica – che vuol dire oggi un’arte di destra?
Un’arte assertiva, muscolare? Boh! – e Beatrice dice che si è tornati a
discutere. Io direi invece a litigare, senza entrare nel merito delle scelte
sue e di Beatrice Buscaroli.
C’è una certa tendenza in
Italia a parlare sempre di tagli alla cultura. È fuori luogo che i governi
avvicendatisi, di destra o di sinistra, non abbiano mai creduto molto nelle
potenzialità economiche derivanti dall’investimento culturale nel nostro Paese.
Ma secondo te non è forse vero che i pochi soldi a disposizione siano anche
usati spesso male? Come ti spieghi che nell’ambito della cultura non si parli
mai di sprechi, alla stregua di altri settori come la sanità o la pubblica
amministrazione?
Hai perfettamente ragione. Penso
che i pochi soldi della cultura siano spesi molto male, che spesso siano
sprecati in mille iniziative modeste, inutili se non addirittura dannose. Non
se ne può più di andare in qualunque angolo d’Italia e trovare la mostra
dell’amico dell’assessore di cui non frega niente a nessuno tranne che
all’assessore, e che confonde ulteriormente le idee, già confuse, sull’arte. O
di andare all’estero e trovare, nei nostri istituti di cultura, le mostre degli
amici degli amici, che in Italia non sono rappresentativi se non di se stessi.
Penso che gli sprechi in fondo siano funzionali a mantenere uno status quo, a
non cambiare niente.
È spiacevole dirlo e forse impopolare, ma penso che
sarebbe meglio concentrare le risorse e l’impegno in vista di obiettivi, magari
territorialmente meno diffusi, ma più qualificati. E, a proposito di sprechi,
vorrei ricordare la facilità con cui in Italia si aprono e si chiudono centri
d’arte contemporanea, tutta roba che costa.
Parliamo di musei: che effetto ti ha fatto l’essere
arrivati a un passo dall’apertura del Maxxi?
Un effetto molto forte. Finalmente
l’Italia ha un museo prestigioso, che può competere con le grandi istituzioni
internazionali. Anche se i problemi rimangono: i finanziamenti, ancora poco
chiari e, purtroppo, presumibilmente scarsi. La struttura: difficilissima da
gestire, che mi ricorda molto l’esordio sulla scena del Guggenheim di Wright,
criticato dagli artisti. Il tutto, insomma, richiede eccellenti risorse
gestionali, finanziarie e curatoriali. Ma penso anche che il Maxxi possa
resettare lo scenario dell’arte italiana. L’impegno dovrebbe essere agire il
geroglifico architettonico di Zaha Hadid, che magari altrove è superato come
concezione: troppo protagonista, troppo star, ma da noi può avere ancora un
senso.
Nel convegno che ha preparato l’inaugurazione “vuota” del Maxxi ho
sentito molte aspettative. E dopo la travagliata mission impossibile – sia pure durata dieci anni –
della realizzazione, ora siamo di fronte a una sfida ancor più decisiva: farlo
funzionare non come un museo qualsiasi, ma come il primo, vero museo d’arte
contemporanea statale.
Insomma, a conti fatti come
sarà l’arte del dopo sboom? Migliore o peggiore?
Forse non potrà che essere
migliore, ma è quasi banale dirlo. Non perché sarà meno costosa, meno modaiola
e tutto il resto: questi sono aspetti di superficie che, periodicamente, hanno
sempre avuto a che fare con l’arte. Penso che sarà migliore se si sarà capaci
di intervenire all’origine di certe distorsioni, laddove si fa l’arte, si
produce senso, ma si fa anche il mercato, qualcosa come l’incipit di questo. È
una costellazione molto forte, aggrovigliata e per certi versi molto attraente,
che Sacco, nella sua Postfazione, sbroglia molto meglio di me.
a cura di alfredo sigolo
*articolo
pubblicato parzialmente su Exibart.onpaper n. 60. Te l’eri perso? Abbonati!
19 novembre 2009
ore 18.30
Adriana
Polveroni – Lo sboom. Come e perché si è sgonfiata la bolla dell’arte
contemporanea
Fondazione Arnaldo
Pomodoro
Via Solari, 35 (zona Tortona) – 20144 Milano
Ingresso libero
Info: tel. +39 0289075394; info@fondazionearnaldopomodoro.it;
www.fondazionearnaldopomodoro.it
[exibart]








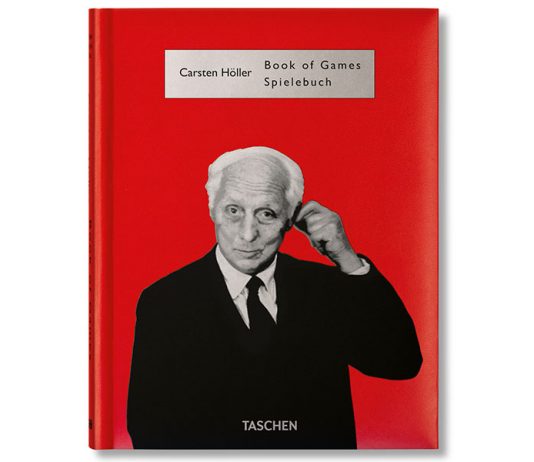


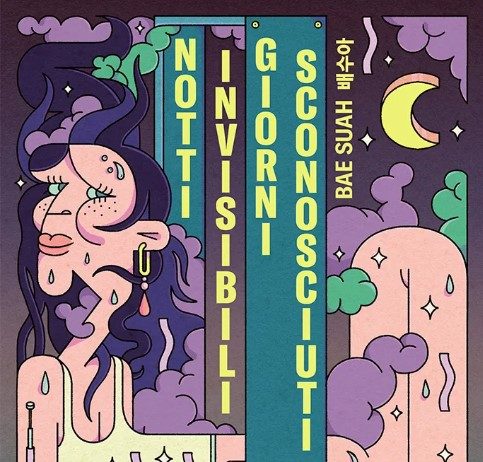

















Ohhh. Mi sembra molto fertile e interessante questo libro, almeno nelle premesse. Un punto centrale, a mio parere, è la capacità dei giovani (ad ogni livello del sistema) di avere coraggio e osare. Di fallire anche tremendamente. Abbiamo questa idea di operatore dell’arte “usa e getta” che deve dire subito qualcosa di compiacente e accettato. E’ ovvio che questo porta al compiacimento, alla rassicurazione della platea,alla stagnazione. La sfida è tradurre questi tempi precari in opportunità. Per farlo bisogna essere indipendenti ma ,allo stesso tempo, coinvolti. Quindi è chiaro che la “professsionalizzzzazzione precoce” che investe i vari trevisani,tadiello,vascellari..ma anche wolfson e compagnia bella, li rende tutti statue di sale sulla sogla delle loro scuole d’arte. Questo vale anche per curatori,galleristi e pubblico.
Il collezionismo dovrebbe poi interrogarsi sul cosa vuole fare: continuare a comprare in una sorta di grande Ikea evoluta e raffinata, o occuparsi di arte? Perchè allora è meglio l’ikea originale che offre soluzioni formalmente e concettualmente meno pretenziose e più “utili”.
Brava Adriana!
Ottima analisi ,scritto in maniera fruibile a tutti ,sia del settore che solo interessati.
Letto tutto di un fiato !
purtroppo il libro della Polveroni è di una banalità sconcertante e si intuisce scritto in velocità… inoltre, e questa è la sua peggior pecca in quanto giornalista, illustra una situazione del sistema di per se già superata