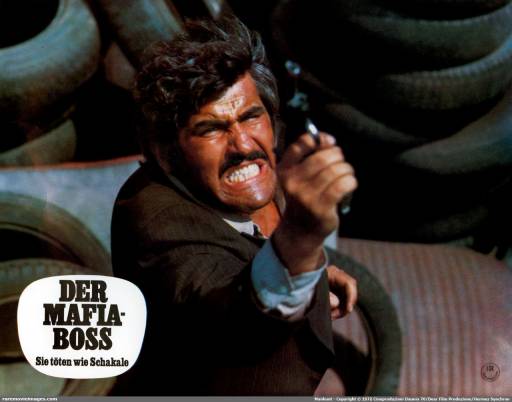Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
26
febbraio 2010
essai_opinioni Cinema dell’irrealtà
essai
Torniamo dopo alcuni anni a parlare di grande schermo e realtà virtuale. Due film diversissimi ma paragonabili permettono di discutere di narrazione, tecnica, tecnologia, 3D. Un’analisi di questi temi attraverso i lungometraggi Avatar e District 9...
Mentre Avatar di James Cameron si avvia a diventare il film che ha incassato di più
nella storia (il record precedente spettava del resto al medesimo regista, con
l’arcinoto Titanic),
succede che un altro tassello si è aggiunto nell’avanzata dell’irrealtà.
Qualche tempo fa avevamo avviato una riflessione sulla
natura degli effetti digitali contemporanei, e sulla loro influenza riguardo
alla percezione generale del mondo da parte degli spettatori-consumatori. È
forse questo il momento giusto per aggiornare il discorso, alla luce dello
spettacolo offerto dall’ultimo ritrovato in termini di “opera d’arte totale” (è
appena il caso di ricordare che il 3D, croce e delizia di Hollywood ai tempi
della crisi, risale in effetti agli anni ‘50, l’età dell’oro della fantascienza
cinematografica, in cui addirittura i sedili sussultavano e si sperimentavano
avveniristiche immissioni di odori per attrarre ancor più le schiere di
teenager, appena individuati come target di consumo…).
Per scandagliare un po’ le caratteristiche di questa
nuova, avvolgente meraviglia, ci viene in aiuto un altro recente film “di
alieni”, che può essere benissimo comparato con la summa di Cameron: District
9 del sudafricano
Neill Blomkamp,
prodotto da Peter Jackson. Sebbene infatti le due opere trattino un soggetto
analogo, l’approccio non potrebbe essere più diverso; e, cosa più interessante,
l’uso della tecnologia traduce fedelmente il differente impianto concettuale.
Se il mondo di Avatar rappresenta davvero “un nuovo paradiso, sia
cosmico che cinematografico” (New York Times), allora il pianeta Pandora è il corrispettivo
immaginario del corpo Na’vi che il soldato Jake Scully (Sam Worthington) usa
come protesi. E dell’intero dispositivo di rappresentazione creato da Cameron:
“Con la mia Reality Camera System il digitale sembra reale e viceversa”. È per questo che il suo film –
generato per quasi due terzi al computer – è stato subito individuato come una
riconfigurazione paradigmatica delle modalità narrative al cinema, paragonabile
all’introduzione del suono e del colore.

Come spiega Dave Kehr, il tentativo è quello di integrare
sempre più la spettacolarità del 3D (per sua natura una formidabile fonte di
distrazione) nella linea del racconto. La chiave, come accade del resto sin
dagli albori del cinema, sta nell’identificazione. Per eliminare la sensazione di
artificialità ed estraneità, gli spettatori vengono indotti con un espediente
narrativo a “capovolgere” il meccanismo standard: “Entriamo nel film
identificandoci con le figure umane; verso la fine, abbiamo trasferito la
nostra fedeltà ai personaggi animati, accettando gli effetti stereoscopici come
parte del loro mondo, piuttosto che come intrusioni nel nostro. Un simile
processo di normalizzazione deve avvenire prima che la stereoscopia prenda il suo posto
accanto al colore, al suono e ai processi wide-screen nella strumentazione del regista. Il ricco
spettacolo di ‘Avatar’ non rappresenta l’arrivo di
una transizione tecnologica, ma piuttosto la sua piattaforma di lancio” (New York
Times, 6 gennaio 2010).
Siamo dalle parti di un barocco rivisto, in cui il
concetto di evasione la fa da padrone, mentre dietro l’anti-imperialismo di
facciata, con tanto di storia d’amore inter-specie, si nasconde con ogni
probabilità un atteggiamento incorreggibilmente paternalistico. Ma, appunto, si
tratta di una partenza, di un avvio potenziale, che prelude (forse) a una nuova
maturità. E questa, che aspetto potrebbe presentare? Prendiamo District 9. Lì avevamo il film più costoso
della storia; qui una produzione indipendente, basata sul precedente
cortometraggio Alive in Joburg (2005) e realizzata con un budget di 30 milioni di
dollari.

Ciò che salta subito all’occhio è la “sporcizia” evidente
di questi effetti, di questi alieni, che ne aumenta esponenzialmente la credibilità.
I “gamberoni” non hanno bisogno del complicato e graduale processo
d’identificazione (umano-ibrido-alieno) di Avatar: si integrano in maniera brutale
nella realtà proiettata e percepita, nel momento stesso in cui ne vengono
socialmente esclusi, espulsi. Confliggono – come elementi narrativi e come
figure simboliche – con gli umani, con noi stessi, veicolando attraverso un
sanissimo shock culturale l’idea dell’alieno, del diverso da sé.
Certo, siamo ancora ben lontani dalla concettualizzazione
problematica dell’Altro che troviamo, per restare solo in ambito
fantascientifico, in un testo come La mano sinistra delle tenebre (1969) di Ursula K. Le Guin.
Tuttavia, in District 9 non c’è quasi nulla di consolatorio. La comunicazione difficile tra
umani e gamberoni passa infatti per una continua codificazione e traduzione dei
messaggi e delle emozioni, e per il parallelo sviluppo di un pensiero critico
(proprio da parte di un protagonista, inizialmente antipatico e sconcertante
nella sua ottusità, come Wikus van de Merwe). In una parola: realismo.
C’è da augurarsi che l’imminente età “adulta” degli effetti speciali acceda anche a questa dimensione,
oltrepassando quella degli urletti di ammirazione in sala (senza
necessariamente escluderla).
nella storia (il record precedente spettava del resto al medesimo regista, con
l’arcinoto Titanic),
succede che un altro tassello si è aggiunto nell’avanzata dell’irrealtà.
Qualche tempo fa avevamo avviato una riflessione sulla
natura degli effetti digitali contemporanei, e sulla loro influenza riguardo
alla percezione generale del mondo da parte degli spettatori-consumatori. È
forse questo il momento giusto per aggiornare il discorso, alla luce dello
spettacolo offerto dall’ultimo ritrovato in termini di “opera d’arte totale” (è
appena il caso di ricordare che il 3D, croce e delizia di Hollywood ai tempi
della crisi, risale in effetti agli anni ‘50, l’età dell’oro della fantascienza
cinematografica, in cui addirittura i sedili sussultavano e si sperimentavano
avveniristiche immissioni di odori per attrarre ancor più le schiere di
teenager, appena individuati come target di consumo…).
Per scandagliare un po’ le caratteristiche di questa
nuova, avvolgente meraviglia, ci viene in aiuto un altro recente film “di
alieni”, che può essere benissimo comparato con la summa di Cameron: District
9 del sudafricano
Neill Blomkamp,
prodotto da Peter Jackson. Sebbene infatti le due opere trattino un soggetto
analogo, l’approccio non potrebbe essere più diverso; e, cosa più interessante,
l’uso della tecnologia traduce fedelmente il differente impianto concettuale.
Se il mondo di Avatar rappresenta davvero “un nuovo paradiso, sia
cosmico che cinematografico” (New York Times), allora il pianeta Pandora è il corrispettivo
immaginario del corpo Na’vi che il soldato Jake Scully (Sam Worthington) usa
come protesi. E dell’intero dispositivo di rappresentazione creato da Cameron:
“Con la mia Reality Camera System il digitale sembra reale e viceversa”. È per questo che il suo film –
generato per quasi due terzi al computer – è stato subito individuato come una
riconfigurazione paradigmatica delle modalità narrative al cinema, paragonabile
all’introduzione del suono e del colore.

Come spiega Dave Kehr, il tentativo è quello di integrare
sempre più la spettacolarità del 3D (per sua natura una formidabile fonte di
distrazione) nella linea del racconto. La chiave, come accade del resto sin
dagli albori del cinema, sta nell’identificazione. Per eliminare la sensazione di
artificialità ed estraneità, gli spettatori vengono indotti con un espediente
narrativo a “capovolgere” il meccanismo standard: “Entriamo nel film
identificandoci con le figure umane; verso la fine, abbiamo trasferito la
nostra fedeltà ai personaggi animati, accettando gli effetti stereoscopici come
parte del loro mondo, piuttosto che come intrusioni nel nostro. Un simile
processo di normalizzazione deve avvenire prima che la stereoscopia prenda il suo posto
accanto al colore, al suono e ai processi wide-screen nella strumentazione del regista. Il ricco
spettacolo di ‘Avatar’ non rappresenta l’arrivo di
una transizione tecnologica, ma piuttosto la sua piattaforma di lancio” (New York
Times, 6 gennaio 2010).
Siamo dalle parti di un barocco rivisto, in cui il
concetto di evasione la fa da padrone, mentre dietro l’anti-imperialismo di
facciata, con tanto di storia d’amore inter-specie, si nasconde con ogni
probabilità un atteggiamento incorreggibilmente paternalistico. Ma, appunto, si
tratta di una partenza, di un avvio potenziale, che prelude (forse) a una nuova
maturità. E questa, che aspetto potrebbe presentare? Prendiamo District 9. Lì avevamo il film più costoso
della storia; qui una produzione indipendente, basata sul precedente
cortometraggio Alive in Joburg (2005) e realizzata con un budget di 30 milioni di
dollari.

Ciò che salta subito all’occhio è la “sporcizia” evidente
di questi effetti, di questi alieni, che ne aumenta esponenzialmente la credibilità.
I “gamberoni” non hanno bisogno del complicato e graduale processo
d’identificazione (umano-ibrido-alieno) di Avatar: si integrano in maniera brutale
nella realtà proiettata e percepita, nel momento stesso in cui ne vengono
socialmente esclusi, espulsi. Confliggono – come elementi narrativi e come
figure simboliche – con gli umani, con noi stessi, veicolando attraverso un
sanissimo shock culturale l’idea dell’alieno, del diverso da sé.
Certo, siamo ancora ben lontani dalla concettualizzazione
problematica dell’Altro che troviamo, per restare solo in ambito
fantascientifico, in un testo come La mano sinistra delle tenebre (1969) di Ursula K. Le Guin.
Tuttavia, in District 9 non c’è quasi nulla di consolatorio. La comunicazione difficile tra
umani e gamberoni passa infatti per una continua codificazione e traduzione dei
messaggi e delle emozioni, e per il parallelo sviluppo di un pensiero critico
(proprio da parte di un protagonista, inizialmente antipatico e sconcertante
nella sua ottusità, come Wikus van de Merwe). In una parola: realismo.
C’è da augurarsi che l’imminente età “adulta” degli effetti speciali acceda anche a questa dimensione,
oltrepassando quella degli urletti di ammirazione in sala (senza
necessariamente escluderla).
articoli correlati
Cinema
dell’irrealtà nel 2007
christian caliandro
*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n.
63. Te l’eri perso? Abbonati!
[exibart]