Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
06
giugno 2015
ALLONS ENFANT/12
rubrica curatori
Dodicesimo appuntamento con la rubrica dedicata ai giovani italiani. Serena Vestrucci risponde alle domande di Andrea Bruciati
Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, per accrescere i bisogni dell’uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l’uomo occupato anche quando egli suppone di essere libero. “Passare il tempo” dinanzi al video o assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è uno svago, ossia un modo di divagare dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il tempo non si può senza riempirlo di occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con fermo ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve appena ad anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi.
Eugenio Montale, Ammazzare il tempo (da Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, Milano 1966)
Quanto è importante il fattore temporale nel tuo lavoro?
«Penso all’arte come all’attività umana che più di tutte le altre chiede di occupare il proprio tempo libero. Quando si ha a che fare con l’arte tutto è tempo libero o, meglio, nessun tempo lo è più. Mi sono sempre chiesta che cosa significhi lavorare per un artista: penso all’importanza di un tempo perso, e ad una attività che si rivela giorno per giorno, lentamente, quasi nascesse nei momenti di pausa, in quei momenti in cui si è sdraiati sotto gli alberi in un mattino d’agosto e ci si sente comunque costretti a pensare. Allora mi rendo conto che il tempo che non passo a lavorare diventa il mio vero lavoro».

Però non avverti un senso di fallimento in questa dispersione di tempo? Sbaglio o ritorna nel tuo lavoro?
«Quando penso al fallimento, mi chiedo per prima cosa che cos’è. È una caduta? Esiste un modo per cadere senza essere fallimentare? Esiste il fallimento perfetto? L’idea stessa di perfezione è fallimentare, perché non lascia spazio ad altre possibilità all’infuori del canone di perfezione stabilito: è fallimentare nel suo vincolo alla soluzione unica. Paradossalmente la caduta perfetta è il puro fallimento, in quanto caduta e in quanto perfetta. Mi viene in mente quello che Beckett scrive del fallimento: “Tutto solito. Nient’altro mai. Mai tentato. Mai fallito. Fa niente. Tentare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire meglio. Ma mai tanto fallito. Peggio fallito. Con cura mai peggio fallito”. Beckett mi aiuta a ricordare che pensare all’arte significa cercare di uscire dall’idea di lavoro. Mi domando spesso quando si esce dal lavoro. E quando si entra nel lavoro. La dispersione di tempo di cui abbiamo parlato credo non sia altro che la ricerca dell’essere in quello che si sta facendo. (Samuel Beckett, In nessun modo ancora, 2008, Einaudi, Torino, pp. 66.67)».
Quale funzione ha il colore, inteso come scala cromatica ma anche nella sua fisicità come pigmento o materia?
«Per me è importante utilizzare il colore affinché sia funzionale al lavoro, non per una questione decorativa o compositiva. Se seleziono alcune gamme di toni di ombretto con cui realizzare Trucco, è perché quelle sono le più richieste sul mercato, le più vendute e quindi le più economiche. Se nei collage trovi la presenza di numerosi colori è perché utilizzo tutti i fogli che un classico album contiene, senza attuare una selezione, una scelta individuale. Non trovo interessante venire incontro al mio gusto specifico, ma piuttosto prendere come dato di fatto la realtà e da questa agire per spostamenti, non per piacere personale. Quando trucco la tela non faccio altro che agire come chiunque usa gli ombretti sulle palpebre, semplicemente ne sposto il campo d’azione».

Come e perché selezioni di volta in volta pratiche operative differenti?
«Ho letto che nell’arco di una vita perdiamo in media un mese e mezzo di tempo ad aspettare al semaforo rosso. Mi chiedo come ognuno di noi occuperebbe altrimenti tutto questo tempo. Quando abitavo a Milano immaginavo un’opera da realizzare esclusivamente durante i momenti trascorsi davanti al semaforo rosso. Poi penso che gli eschimesi hanno una sola parola per definire il rosso ma ne hanno trenta per il bianco. Non posso non pensare alle cose che entrano volontariamente o involontariamente nella mia vita. Probabilmente se andassi a vivere in Islanda inizierei ad interessarmi ai gas, alle loro proprietà, ai loro usi».
Ci sono maestri a cui fai riferimento?
Quello che mi interessa sono le opere in sé più che i maestri, perché spesso mi coinvolgono due o tre opere per artista e non tutto l’artista. Anni fa a Milano assistetti ad una performance di Marvin Gaye Chetwynd. Ricordo che l’opera era la messa in scena di una corsa di lumache go-kart, ciascuna guidata da una coppia di attori. Era un’opera grottesca, quasi violenta, nell’uso dei corpi, della musica, delle grida, dei colori, del trucco. Mi ero seduta per terra perché la galleria era gremita di gente che spingeva da tutte le parti, mentre queste figure mascherate si muovevano correndo ovunque, venendoci quasi addosso. In breve tempo quello che sembrava un colorato teatro comico diventava via via una fusione di suoni e una stratificazione di immagini di cui ormai eravamo parte senza nemmeno essercene resi conto. Anni dopo alla Temporäre Kunsthalle di Berlino ho visto il FischGrätenMelkStand di John Bock. L’opera era una costruzione di acciaio alta undici metri: una gigantesca struttura su quattro piani proponeva una serie di nuclei ambientali nei quali Bock mise in mostra i lavori di sessantatré artisti, architetti e compositori. Continuando a salire quello spazio si entrava man mano in una sorta di opera d’arte totale. Tre anni fa Urs Fischer ha inaugurato una grande mostra personale utilizzando l’intero Palazzo Grassi a Venezia. La sua opera più interessante, a mio parere, era però fuori dal Palazzo, e si trovava nel chiostro dell’Accademia di Belle Arti. Qui Fischer ha chiesto ai ragazzi dell’Accademia di utilizzare interi panetti di creta per realizzare delle sculture a forma di gatti, da lasciare in quell’area centrale a cielo aperto. Io andai a vedere quest’opera alcune settimane dopo e tutte le sculture si stavano sciogliendo con le piogge cadute in quei giorni. Quello che rimaneva erano solo le tracce di un immenso lavoro collettivo, destinato a scomparire e ad essere solo ricordato, contemporaneamente alle sue cere che intanto si consumavano negli spazi di Pinault».

Parlami della tua formazione in dettaglio
«A 19 anni mi sono iscritta all’Accademia di Belle Arti di Milano, nel corso di Alberto Garutti. I tre anni trascorsi a Brera sono stati il momento più incisivo per la mia formazione. La nostra era l’aula 1 e lì si iniziava ad avere un po’ più di coraggio, a ricordarsi di chiedersi sempre cosa aggiungiamo di nuovo all’arte, a pensare che un buon lavoro deve essere anticipatore, e che se non è così non può bastare. Fondamentalmente il corso di Garutti mi ha insegnato a ridere, e a prendermi meno sul serio, a ricordarmi di lasciarmi andare, e di fare come mi sento. Poi sono partita. Sono andata a vivere a Berlino, per allontanarmi dalla Milano in cui sono nata e cresciuta. A Berlino ho provato diversi lavori, dall’assistente di artisti alla centralinista full time in un call-center. Berlino è umanamente una città molto generosa, di cui è facile innamorarsi, ma a lungo andare prevaleva in me la sensazione di non stare costruendo nulla. Dopo due anni ho sentito il desiderio di tornare a studiare e ho scelto di iscrivermi alla laurea specialistica all’Università I.U.A.V. di Venezia. Passare da Berlino a Venezia è stato un cambio completo di vita, ma appena arrivata sono stata selezionata con borsa di studio tra gli artisti assegnatari degli atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa, e così, tra un anno di residenza e i corsi universitari, anche questa città è stata da subito molto importante per la mia crescita».
Quali sono le tue prossime sfide?
«Lavorare sulle mie paure. Che poi sono quelle un po’ di tutti. Quindi, in fondo, nulla di personale. La paura di se stessi, del tempo, dell’altro, della morte. La sfida non credo sia superarle, ma conviverci bene».
In cosa consiste la collaborazione per Level 0, format ArtVerona in collaborazione con i musei d’arte contemporanea italiani?
«La mia collaborazione prevede l’allestimento di una project room al Museo Villa Croce di Genova dove presenterò l’ultimo mio lavoro: una trilogia di pubblicazioni nelle quali sviluppo una riflessione sulla natura del tempo, indagandone tre passaggi. In ciascuna di queste pubblicazioni cerco di uscire dall’ io, mettendo in gioco un dialogo/confronto ogni volta diverso. Nel primo passaggio viene approfondita la dimensione temporale dell’anno solare, scandita per mesi, investigando lo spazio della coppia. Nel secondo viene vissuto il tempo libero all’interno di un gruppo di persone, nell’arco di una settimana di vacanza trascorsa in un unico ambiente. Nel terzo passaggio viene ritratto il tempo degli altri, di coloro che casualmente vengono a scrivere l’album di una intera vita».
Serena Vestrucci: Che cosa ci si aspetta dall’opera d’arte e che cosa dall’artista?
Andrea Bruciati: «Io credo che un artista debba risvegliare in ognuno di noi quel senso del meraviglioso e dell’inatteso, che ci rende parte viva di un tutto. E tu cosa credi che ci aspetteremmo da voi e quale è il valore del tuo agire?»
Serena Vestrucci: «Penso all’opera d’arte come a quel gesto, anche minimo, che ci arriva sensibilmente, irriducibile a parole, in grado di mostrarci la forma altra di ciò che credevamo di conoscere. Dall’artista mi aspetto la capacità di fare tutto questo e, subito dopo, di farsi da parte».
Serena Vestrucci nasce a Milano il 21 febbraio 1986. Vive e lavora a Venezia.










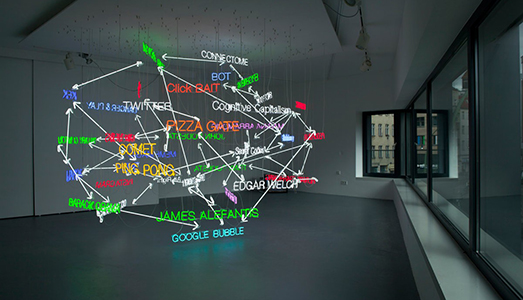















Concordo con la nozione di tempo, specialmente quello che ho perso a leggere un testo mentre vedevo foto che dicono qualcosa che col tempo ha poco a che fare.
Come sopra, ennesima perdita di tempo.
Peace