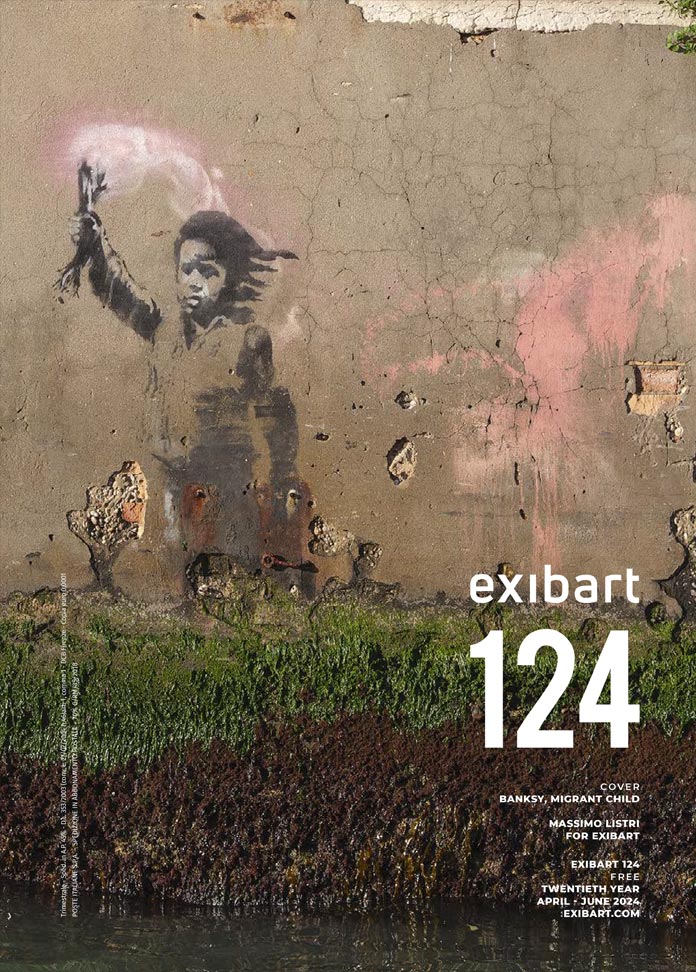Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
24
dicembre 2015
Vita sociale dell’opera d’arte contemporanea
Politica e opinioni
Che cosa implica il restauro di un’installazione? Il saggio Senza cornice di Stefania Zuliani, di cui pubblichiamo un estratto, ci porta dentro un dibattito appassionante
Fino a qualche anno fa considerato uno strumento necessario, se non addirittura sufficiente, nel difficile e per molti versi paradossale processo di conservazione delle opere d’arte contemporanea, l’intervista o, meglio, il sempre più standardizzato questionario con cui il restauratore prova a mettere definitivamente in chiaro le intenzioni dell’artista rispetto alla tradizione del proprio lavoro, appare sempre più un documento fragile e insoddisfacente, spesso addirittura ingannevole. Non è raro, infatti, il caso in cui l’artista o si rifiuta di fornire indicazioni e prescrizioni precise riguardanti la conservazione della propria opera – fra i più citati, l’episodio di cui è stato protagonista Nam Jun Paik che, chiamato ad esprimersi sulle modalità di conservazione e di riallestimento del suo TV Garden (1974-2002) ebbe a dichiarare «Non amo avere il controllo totale – sarebbe noioso. Quello che ho imparato da John Cage è godere ogni secondo della mancanza di controllo» – o addirittura muta nel corso degli anni punto di vista, mettendo così seriamente in crisi l’istituzione proprietaria del lavoro.
Più che l’intenzione dell’artista, con la sua volubilità e la sua inevitabile parzialità, quella che oggi sembra avere conquistato un ruolo determinante nella riflessione sulla conservazione è in realtà l’intenzione dell’opera. Se è forse esagerato considerare, come fa S. Muñoz Vinas, tra i maggiori teorici del restauro dell’arte contemporanea, «l’espressione orale o scritta delle intenzioni dell’artista nulla più di una curiosità storica, una postilla al testo (l’opera d’arte), che resta l’autentico oggetto d’interesse», è certamente vero che è «sbagliato pensare che la volontà dell’artista e la relativa opera coincidano o debbano coincidere», soprattutto quando l’opera in questione è un’istallazione, il cui significato non si può veramente comprendere senza considerare tutti i suoi differenti attori e le reciproche relazioni che, assieme, danno vita ad un processo collettivo dalle molte variabili, una serie di spinte e controspinte, un gioco di ruoli e di sguardi che può efficacemente essere affrontato con gli strumenti della actor-network theory (ANT).
.jpg)
(…) È indubbio che per la sua natura inevitabilmente negoziata, per la sua specifica presenza, l’installazione implica un’autorialità plurale in cui interviene, si è detto, il pubblico ed anche, in termini che, lo vedremo, vanno via via precisandosi e definendosi, lo stesso restauratore. A partire dalla consapevolezza «che l’installazione si realizza come opera d’arte soltanto attraverso il processo della sua messa in opera» (T. Scholte), cosa che di per sé apre un inedito scenario riguardo alla vita silente (latente o addirittura spenta?) dell’installazione quando giace nei depositi e alla connessa attività di tutela – se l’opera non allestita non esiste, che cosa custodiamo nel buio delle casse? -, è evidente che la conservazione dell’installazione sollecita riflessioni e richiede soluzioni che possono e talvolta devono discostarsi da quelle suggerite nel 1963 da Cesare Brandi, la cui Teoria del restauro resta, va sottolineato, un saldo riferimento, un punto di non ritorno per la comunità scientifica internazionale. Il minimo intervento, la reversibilità e, soprattutto, l’assioma per cui «si restaura solo la materia dell’opera d’arte», trovano infatti occasioni di ripensamento, di verifica e, anche, di discussione nelle più recenti declinazioni del dibattito critico internazionale che, almeno a partire dalla cruciale conferenza di Nara (1994), dove è emersa la necessità di «conservare il cambiamento», ha sempre di più spostato l’attenzione sull’esigenza di considerare gli aspetti intangibili del patrimonio da tutelare.

È un orientamento che ben corrisponde alla natura complessa – materiale e immateriale – dell’installazione, medium che, d’altro canto, più di ogni altro sembra necessitare proprio di quel «restauro preventivo» di cui lo stesso Brandi è stato sostenitore, non certo con l’ingenua intenzione di «immunizzare» l’opera, impresa comunque impossibile e in alcuni casi del tutto scorretta – davvero si può pensare di sottrarre ai turbamenti del tempo un lavoro che proprio dei traumi e delle tensioni del presente vuole essere catalizzatore e traccia, come accade, ad esempio, per gli interventi “attivisti” di Judy Baca? – ben sapendo che, in realtà, l’atto stesso della creazione dell’installazione porta in sé le prospettive della sua conservazione o, meglio, della sua costante trasformazione. (…) Conservare l’installazione significa, dunque, non impedirne ma accompagnarne il cambiamento – quello che è stato definito «l’invecchiamento sistematico dell’opera» – cercando di seguirne correttamente gli sviluppi e di comprenderne le ragioni fin dalle origini. È per questo motivo che sempre più spesso i conservatori dei musei scelgono, quando possibile, di documentare con scrupolo l’opera a partire dalla nascita del progetto, partecipando alla sua realizzazione e, quindi, assumendo un ruolo di co-autore («coproducer»), non tanto per l’eventuale intervento materiale nella produzione, quanto per la discussione e la relazione con l’artista e i suoi assistenti, con il curatore della collezione o della mostra, con il responsabile dei servizi educativi, con tutte le figure, insomma, che, prima ancora dell’esposizione pubblica dell’installazione, sono coinvolte nella costruzione del suo significato, perché davvero il restauro è oggi ancor più che in passato una pratica sociale, oltre che scientifica.

Come ha sottolineato Vivian Van Saaze nel volume Installation Art and the Museum, Presentation and Conservation of Changing Art works (2013), «le installazioni non possono essere comprese separatamente dagli attori e dalle pratiche del museo nel quale circolano» ed è per questo motivo che diventa indispensabile pensare alla tutela e alla conservazione di queste opere come ad un processo critico ininterrotto che non si limita ad individuare, una volta e per sempre, ciò che indispensabile, costitutivo dell’installazione, e ciò che invece può essere sostituito o addirittura omesso, anche perché, come è evidente, l’installazione mette profondamente in crisi i criteri tradizionali che distinguono copia e riproduzione in quanto è la stessa installazione a farsi garante di autenticità rendendo originale anche la riproduzione: «L’installazione – ha scritto a questo proposito Boris Groys – s’inscrive in un contesto apparentemente privo di segni, uno spazio aperto di anonima circolazione e prende forma – anche solo temporaneamente – in un contesto chiuso, stabile e fisso topologicamente opportunamente definito “hic et nunc”. Questo significa che tutti gli oggetti collocati in una installazione sono originali, persino quando, o esattamente quando, essi circolano al di fuori dell’installazione come copie».
La documentazione assume così un ruolo determinante nel rapporto tra museo e installazione, perché al di là dei contratti di acquisizione, che oggi specificano in maniera sempre più dettagliata non solo cosa materialmente l’istituzione acquisisce ma anche quali dovranno essere in futuro le condizioni di conservazione e di esposizione, considerando anche i possibili spostamenti all’interno degli spazi della stessa istituzione o gli eventuali prestiti, è necessario monitorare in ogni sua fase quella che, ricalcando un celebre saggio di Arjun Appadurai, Deborah Cherry ha felicemente definito «la vita sociale delle opere d’arte». Pur sapendo che l’opera eccede sempre la sua descrizione, per quanto densa essa possa essere, il museo non dovrebbe rinunciare ad un lavoro di documentazione costante che non può non avvalersi, naturalmente, della fotografia, strumento ormai consolidato di tutela che, grazie alla democratizzazione digitale di questo linguaggio e alla sua condivisione attraverso i social media, ha assunto negli ultimi anni un valore ulteriore, assicurando non soltanto testi visivi utili per conoscere le evoluzioni degli aspetti materiali dell’opera, ma offrendo anche un costante aggiornamento sulle modalità di fruizione dell’installazione da parte del pubblico, sempre più attivo nel fotografare e, soprattutto, nel fotografarsi al museo (…)
.jpg)
Ad ogni modo, per quanto sempre più sensibile alla presenza del pubblico nelle sale del museo – e, in questo, ha sicuramente fatto alta scuola Thomas Struth con la serie delle sue straordinarie Museum’s photographs – la fotografia delle opere esposte, non diversamente, peraltro, dalle riprese video, non sembra essere strumento sufficiente a documentare le esperienze, le reazioni, le relazioni attivate da un’installazione, che hanno comunque carattere individuale e soggettivo. Più efficace, nella sua franca soggettività, la narrazione, una rinnovata pratica ecfrastica che non è puro esercizio descrittivo, sapiente costruzione di calchi linguistici che dell’opera restituiscono per forza di attenta retorica i dati fenomenici, quanto (impossibile e persino «suicidaria») autobiografia, frammento di diario che punta non tanto sugli elementi sensibili che compongono l’opera (che, come si è più volte ribadito, sono di per sé instabili e, singolarmente, inerti) quanto sui processi, razionali ed emotivi, innescati dall’installazione. A questo lavoro di racconto il restauratore è, non bisogna dimenticarlo, da sempre chiamato (…) con un’impostazione che è però di natura squisitamente scientifica e che non tiene conto se non in minima, residuale parte degli elementi soggettivi che sono invece determinanti per restituire l’«intenzione dell’installazione», confluenza di dati concreti e di singole esperienze e attese. (…). Perché l’installazione, qualsiasi sia la sua configurazione, non si risolve negli oggetti e nelle materie che la compongono, il suo funzionamento ha un tempo e un luogo specifici e comunque irripetibili, una vita in incessante trasformazione a cui la critica, in qualunque modo si esprima (in scrittura, in curatela, in attività di conservazione o in pratiche educative) non può opporre un rassicurante know how ma deve avere il coraggio – ed anche la responsabilità – di rispondere con un interminabile knowing how. Un’attitudine alla ricerca e all’ascolto che mette in conto l’errore, che osa la meraviglia e persino la poesia: «Il sole – ha scritto Tomas Tranströmer – fa sbattere le palpebre alle statue».
L’intenzione dell’opera: a proposito della conservazione delle installazioni
Estratto da Stefania Zuliani, Senza cornice. Spazi e tempi dell’installazione/Without a frame. Spaces and times of the installation, Arshake, Roma 2015. Critical Grounds #04, collana a cura di Antonello Tolve e Cristian Caliandro, (http://www.arshake.com/senza-cornice-spazi-e-i-tempi-dellinstallazione/)