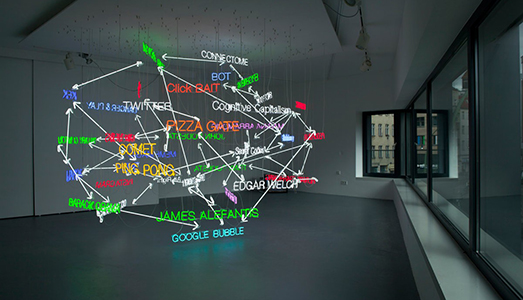Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
07
settembre 2016
ALLONS ENFANT/22
rubrica curatori
Giulia Cenci è la nuova protagonista nell'indagine sui giovani artisti italiani di Andrea Bruciati
Nulla deve frapporsi
Fra te e le forme che assumi
Quando la crosta della forma è stata distrutta.
Mark Strand, Il Monumento, traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan, Fandango Libri, Roma 2010, p.22.
Spiegami nel dettaglio cosa intendi per crosta.
«Il visibile, la superficie di tutte le cose: un visibile sottile e mutevole, nello scritto la sua fragilità è scontata, la sua distruzione anticipata ma la possibilità di ricrearsi lo rende al contempo forte, come forte è la parola forma. È un’insicurezza che veste le cose, tramite la quale è possibile scavare al loro interno per mostrarne tanti altri aspetti, proprio come la pelle di un corpo o l’intonaco di un muro. In un primo momento questa crosta funziona per me come l’incontro tra lo sguardo e l’oggetto di lavoro, il luogo che mi consente di indagare gli aspetti che ne sono meno visibili. In un secondo momento, invece, il lavoro stesso diviene quella crosta, il residuo tangibile delle azioni che si sono susseguite su un oggetto o una parte di spazio, ciò che rimane. Visto in modo classico, il monumento non è altro che materia deposta a testimoniare qualcosa che non c’è più, ma una pietra che sostituisce un corpo in carne ed ossa, più che costituire la presenza sembra attestarne la fragilità, l’impossibilità di sopravvivere oltre il suo tempo. Il Monumento di Strand invece non è più visibile, si deve cercare nell’assenza, un invisibile che forse si nasconde a testa in giù, sotto terra, e questo proprio perché coincide con l’oggetto della sua rappresentazione. La crosta è il residuo del soggetto e dell’oggetto di lavoro, non ha le pretese di sostituirsi a qualcosa come farebbe un monumento ma piuttosto coincide con una parte di ciò che è stato analizzato, facendo delle sue fragilità e potenziali distruzioni la sua forma».
Ti definiresti scultrice?
«Non mi ci vedo definizioni del genere. Ho utilizzato passaggi linguistici della scultura così come del disegno e del video, ma ciò che mi interessa è la loro capacità di poter appartenere tanto al linguaggio artistico quanto a processi ed accadimenti del reale. Mi piace pensare che chi si occupa d’arte diventi quasi un mediatore tra la materia (e dati i tempi per materia intendo tutto, dalle materia modellabileall’oggetto finito, ready made, dallo spazio reale a quello virtuale, rappresentato) e l’uomo. Un interprete capace di rendere visibili passaggi che sarebbero altrimenti destinati a sfuggirci, in quanto quasi incomprensibili, lontani e talvolta troppo temporanei. In questo senso tra le discipline artistiche, per com’erano intese fino alle avanguardie (o forse fino a La petite danseuse de quatorze ans di Degas) la scultura è forse la disciplina che più si avvicina al mio modo di vedere, in quanto è destinata per sua natura linguistica ad includere ed escludere lo spazio del reale».
Qual’è il tuo rapporto con il materiale (fisico intendo)?
«Un rapporto complicato, non privo di sorprese, ma soprattutto un rapporto di osservazione. Credo di aver sempre trattato la materia in modo molto umano, artificioso, chiedendogli di poter fare quello che non può fare, quello che non è destinata a fare; chiedendogli di mostrarci i suoi lati più fragili… in un certo senso cerco di metterla alla prova. Ma questo avviene solo dopo averla osservata e poi testata, solo dopo averne individuato qualità, promesse, potenzialità e limiti. A questo punto il mio intervento diviene quasi un utilizzo sbagliato della materia (o della cosa): cerco di utilizzarne i punti deboli, gli errori, così come cerco di utilizzare gli errori del mio rapporto con essa. E questo non per migliorare le mie capacità ma piuttosto per ricercare delle possibilità. Mi ricordo che quando ho iniziato ad approcciare i materiali e gli oggetti, durante i primi anni di accademia, mi rivolgevo spesso a dei tecnici per chiedergli il loro parere, si trattava soprattutto di muratori, elettricisti, restauratori… La loro risposta coincideva sempre: “È impossibile! È sbagliato, non ha senso…”, e credo che questo sia il punto. Di qualsiasi tipo di materia o cosa si tratti, appartenente alla sfera dell’arte, dell’edilizia, dell’industria, dei mass media, etc, il mio rapporto con essa è sbagliato, umano».
Mi parli del tuo percorso formativo?
«Credo che la parte più importante della mia formazione sia il luogo in cui sono cresciuta in toscana, tra un paese molto piccolo e una casa molto lontana dal paese molto piccolo, ma per questo davvero speciale. Un luogo dove cose tra loro divergenti si sono incontrate e in un qualche modo ibridate: monografie di artisti a fianco di attrezzi agricoli, note ed appunti di persone mai conosciute mangiate da farfalle notturne e topi; disegni, schizzi e riproduzioni di opere d’arte precipitate nelle crepe dei muri. Tante crepe nei muri, perché la terra è l’argilla e non permette a niente di stare fermo, di non modificarsi. Dopo ci sono state le scuole, i corsi, le tecniche… una serie di persone che portavano tra le mani dei saperi obsoleti, semplicemente perché ripetuti alla lettera, delle macchine artigianali. A Bologna ho frequentato l’accademia un po’ a modo mio, scegliendo con chi confrontarmi (specialmente studenti) come qualsiasi persona in qualsiasi accademia d’arte italiana. Poi ho partecipato ad un Master in Arti Visive in un altro paese piccolo, ma in Olanda. In quel momento avevo la necessità di isolarmi per capire la relazione tra le cose che avevo in testa ed un resto completamente differente, sconosciuto, nuovo. Adesso sono ad Amsterdam… non so ancora cosa dire, sto cercando di usare le risorse che ho (tante) per continuare a portare quelle cose che ho in testa nel presente in cui sono, lasciandole continuamente modificare ed interferire con un resto».
Trovi che vi sia una parte crepuscolare nel tuo lavoro?
«Ecco credo che ci sia qualcosa che mi interessa anche di quel periodo storico: una certa curiosità per la periferia delle cose, per ciò che non è centrale, in qualche modo irrilevante. Ma il modo in cui certe cose vengono narrate per me si rivela quasi troppo angosciante, una forma di rifugio. i crepuscolari sembrano coperti da un’ombra arrendevole, una sorta di rassegnazione. Ecco io non vedo le cose o la materia in questo modo, non mi sento arresa o schiacciata da ciò che mi circonda e, tantomeno, voglio recuperare un passato ‘che fu’. Tutt’altro voglio utilizzare degli elementi del percorso evolutivo del linguaggio artistico e culturale, presenti e passati, per scrivere, formare, modificare la materia e le cose, per cercare delle possibilità. Il motivo per cui spesso accosto materiali ed azioni ‘tipici’ del linguaggio artistico a materiali (e ricordo che per materia intendo tutto) ed azioni che sono invece parte della periferia del linguaggio o addirittura estranei a questo, è proprio perché penso che il linguaggio si è venuto a creare per dei bisogni di espressione, per delle necessità che hanno da sempre investito tutta la sfera umana».
Parlavi di distruzione delle cose.
«Non asserisco a questa parola un senso tragico ma ritorno proprio a quella parola e all’origine del fare, del modellare, dello scolpire, del disegnare. Per fare tutto questo è stato necessario distruggere, modificare: per costruire una lancia è stato necessario distruggere la forma della pietra, privarla di una parte di essa per renderla più appuntita, più pertinente al fine necessario. E così via, per rappresentare (formare, disegnare) degli animali sulle pareti di una caverna, è stato necessario sfaldare una sezione di terreno, estrarne della polvere e renderla pigmento. Noi possiamo chiamare queste azioni di estrapolazione e sfaldamento con il termine modificazione, ma di fatto questa alterazione contiene al suo interno anche l’idea di distruzione di qualcosa per la formazione di un’altra cosa. Oggi siamo arrivati ad un punto in cui abbiamo utilizzato talmente tanto la materia da renderci impossibile classificare una materia pura da una modificata dall’uomo».
Approfondiamo questa tua riflessione sul dato antropologico.
«Mi piace sempre pensare che se andassi ad estrarre dell’argilla da una cava, probabilmente al suo interno ci troverei della plastica, del metallo, dei frammenti di oggetti già formati dall’uomo e già distrutti da esso. Ecco, questo è il motivo per cui mi piace utilizzare quegli elementi e gesti del linguaggio che sono considerati ‘naturali’ e ‘classici’, ma accostarli a materie create e distillate dall’uomo. Perché se fosse vero (gli studiosi non ne sono sicuri al 100 per cento ma a me sembra piuttosto evidente) che siamo arrivati ad un punto in cui la presenza dell’uomo sulla terra è arrivata a modificarne l’andamento geologico, allora questo potrebbe significare che proprio quel modificare, fare, modellare che nei secoli si è trasformato oltre che in arte anche in tecnologia, racchiude dentro di se il seme della distruzione».
Qual’è il tuo atteggiamento rispetto al concetto di tabula rasa?
«Credo di avere un’attitudine a ribaltare ed a scavare proprio tutti quei segni che metaforicamente sono inscritti sulla citata tabula. È come se avessi la necessità di non assumere e dare per scontato dei codici che ho imparato, per tentare di trovare una modalità differente -alle volte opposta- di usarli. Questo rispetto a dei codici linguistici del linguaggio visivo, così come rispetto ad altri tipi di codici. In un certo senso ho come l’impressione di non riuscire a vedere nulla in modo definito, stabile, giusto. Ecco, alle volte è come se cercassi di proiettarmi in quel mondo, un mondo del possibile, dove nessuna educazione, codice o definizione è data per scontata, dove non c’è solo un modo giusto ed uno sbagliato, ma un vasto potenziale».
Ritieni di far parte di una tradizione nel senso che trovi un fil rouge nel tuo lavoro con un determinato passato / Storia?
«Non so, non credo di ricondurmi a qualcosa di specifico, di identificarmi con una ‘tradizione’ in particolare, ma piuttosto di cercare di ritrovarmi in cose differenti (anche molto differenti tra loro), a modo mio. Sicuramente ci sono dei momenti-passaggi che ritengo fondamentali nell’evoluzione del linguaggio artistico, le cui azioni e conseguenze mi interessano particolarmente, tra questi le avanguardie storiche con la loro rottura delle discipline e l’introduzione del ready made, così come tutti quei movimenti che nel dopoguerra hanno indagato lo spazio e la realtà come parte effettiva dell’opera o addirittura come soggetto (tra gli americani Gordon Matta-Clark, mentre per gli italiani ho sicuramente un interesse per Gianni Colombo). Ho poi un particolare interesse per alcuni artisti che hanno lavorato su un’idea di superficie, come luogo ultimo di materia in cui i gesti volontari ed involontari vanno a costituire l’opera, le sue vibrazioni, in cui la superficie diviene appunto la parte visibile portatrice di un processo o movimento più amplio, che lascia intravedere una possibilità di passato e di futuro, grazie anche alla sua incompiutezza, al suo carattere informale. Tra questi ti cito tre artisti completamente differenti che hanno per me particolare importanza: Alberto Burri, Alberto Giacometti e Medardo Rosso».
Giulia Cenci: La mia domanda per te… da curatore ed osservatore della giovane scena artistica italiana, trovi che si possano ancora identificare degli interessi comuni tra i giovani artisti italiani? Se si, quali?
Andrea Bruciati: «Non so se sia una specificità italiana ma amo gli artisti generosi e aperti allo scambio soprattutto fra loro stessi. Il fatto di vivere in un contesto così deperibile e precario sicuramente unisce i più intelligenti in una piattaforma comune di grande consapevolezza identitaria. Finalmente».
Giulia Cenci nasce il 12 luglio 1988 a Cortona (Arezzo). Vive e lavora fra la sua città e Amsterdam.