-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Cosa ci aspetta dopo l’Ancien Régime
Extra pART
Andare per grazia e trovare
giustizia. Da alcuni giorni vedo affiorare questo proverbio in forme sempre
diverse. Una frase sintatticamente ben organizzata, con un ritmo completo e una
solida struttura di significato che riesce a compendiare un certo afflato
biblico verso l’ineluttabilità del destino e le velleità letterarie del
citazionismo kafkiano in materia di paradossi giuridici. Soprattutto, appaga a
livello fisico, perché riempie la voce di fonemi e articolazioni, quelle R e
quelle Z che ritornano così armonicamente lungo tutto il coordinato saliscendi
dell’emissione d’aria.
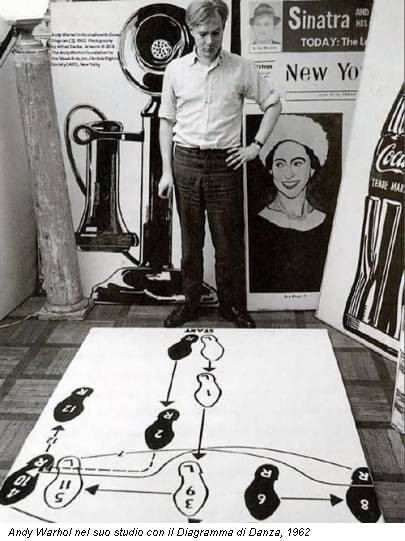
Mentre ripenso a tutte le
occasioni in cui avrei potuto fare affidamento su questo proverbio per chiosare
a un discorso, in particolare di ambito calcistico, vengo distratto dalle note
sinuose di un tango. Nella funicolare che porta a piazza Amedeo, a pochi passi
da via dei Mille e da Riviera di Chiaia, c’è un signore dai tratti nomadi che
suona la fisarmonica, se dovessi descriverlo mi piacerebbe riprendere
l’aggettivo “azzimato”, non per questione di ricercatezza linguistica ma per
l’incredibile precisione con la quale definisce l’insieme delle fattezze e dell’atteggiamento
dell’uomo. Nell’instabile paesaggio del trasporto pubblico, nel caos delle mode
che si avvicendano da un vagone all’altro, nel lancinante arcobaleno dei loghi da
mezza stagione, si pone come una presenza fissa, tranquillizzante come una
struttura architettonica solida, un balcone al centesimo piano o un ponte tra
Lisbona e Washington. La riga laterale definita con precisione sui capelli duri
e nerissimi, la morbida modulazione della voce, le guance spaziose, sbarbate di
fresco, fanno parte di un’estetica coordinata nei minimi particolari che
assolve sapientemente alla sua funzione. L’uomo riesce ad attirare l’attenzione
del pubblico che dà cenni di aver gradito l’esibizione dei tre pezzi di Astor
Piazzolla, da che ho memoria sempre gli stessi ed eseguiti con la giusta misura
di pathos, calibrando l’andamento delle spalle con quello dello strumento, le
tonalità delle note con gli scossoni del vagone. Un’unica volta l’ho visto
fuori dall’orario di lavoro, era di pomeriggio tardi, a piazza Bellini, quindi
ben al di là dalla zona della funicolare, insieme ad altri suoi amici che,
sebbene ugualmente provvisti di fisarmonica ed evidentemente fautori
dell’identica cifra visiva e stilistica, non riuscivano a imitarne la
perfezione, risultando, al più, dei discreti manieristi. «È
bravo ma ci vorrebbe anche un napoletano che suona la tarantella»,
commenta un signore anziano, la sua voce viene fuori da un pesante cappotto
scuro, una canuta solennità rivolta a nessuno in particolare. «Ci
sta, ci sta. Alla fermata a Piscinola», rassicura un venditore ambulante di
calzini e scaldacollo che, appena salito sul vagone, ha scambiato un cenno con
il musicista, un fugace ma denso saluto che sa tanto di Entente Cordial, il
patto stipulato tra Francia e Gran Bretagna nel 1904 per il reciproco
riconoscimento delle sfere d’influenza coloniale, in particolare sul Marocco e
sull’Egitto.

Arrivo finalmente a Villa
Pignatelli, il rumore del traffico di Riviera di Chiaia è chiuso da lievi
folate di vento, sibilanti tra gli arbusti del parco che circonda l’edificio
neoclassico. Qui l’aria si carica di particelle opposte, dell’umidità del prato
all’inglese e della salsedine del mare. La villa monumentale fu costruita a
partire dal 1826, per volere del baronetto Sir Ferdinand Richard Acton, figlio
del ben più noto Sir John Francis Edward Acton che, durante il regno di
Ferdinando IV, prima fu ministro della Marina e della Guerra, poi segretario di
Stato e, durante, amico molto particolare di Maria Carolina D’Asburgo, moglie
del Re. Al declino degli Acton, fu venduta al banchiere tedesco Carl Mayer von
Rothschild che, nel 1821, aveva stabilito una filiale a Napoli. Dopo i
Rotschild, per un breve periodo, venne usata come oratorio dalla comunità
ebraica, quindi venduta al principe Diego Aragona Pignatelli Cortes e, infine,
nel 1952, ceduta allo Stato, per volere della principessa Rosina. Dagli anni ’80,
l’edificio è stato sede di diverse operazioni d’arte contemporanea, come il Concerto per piano in memoria di Giovanni
Morra, di Hermann Nitsch,
diventando punto di riferimento, in particolare, per la fotografia, alla quale
è dedicato tutto il primo piano, con mostre, tra gli altri, di Mimmo Jodice, Wim Wenders e Paolo Gioli.
La villa è un tripudio di paraste ioniche e porticati dorici, ampie scalinate
in marmo, salotti e salottini, sale da bigliardo e da ballo, toelette
semicircolari, stucchi e grisailles, damascati rossi, consolle neobarocche,
candelabri francesi, scenette mitologiche. Insomma, il completo dizionario
simbolico sfogliato dall’alta aristocrazia per saturare gli spazi con il
proprio ideale di autorappresentazione, escludendo ogni confronto con la realtà
che, al di là dei tentativi di Restaurazione e delle monarchie illuminate
guidate dalla provvidenza, doveva fatalmente prevalere. Bisogna ammettere,
però, che noi contemporanei siamo facilmente tentati dall’interpretare tale tensione
alla pienezza e alla pesantezza come ombra lunga di un presentimento di
decadenza, l’estrema volontà di aggrapparsi a un sistema dei valori diventato
improvvisamente sfuggente, non più comunicabile, rappresentabile. In fondo,
forse, al tramonto del 2016, ci sentiamo molto più vicini alla tipologia di
crisi che caratterizzava quel periodo, mentre l’angoscia del secolo breve
l’abbiamo già razionalizzata e sembra risalire a 100 anni fa.

In ogni caso, va detto che, dopo
gli importanti restauri conclusi giusto un anno fa, fortemente voluti da Denise
Pagano, direttore della casa-museo, e da Mariella Utili, in quel periodo
direttore del Polo Museale, il pavimento è tirato a lucido, i marmi splendono,
sulle sontuose suppellettili non c’è un velo di polvere, l’edificio sembra
pronto per un esclusivissimo ricevimento regale, se non fosse per i cartellini
e le didascalie dei pezzi custoditi nelle bacheche che, con discrezione e
severità, dichiarano la destinazione museale, di pubblica fruizione. Soprattutto, «tutte le luci di tutti i
lampadari sono accese, una situazione di manutenzione e cura molto al di sopra
della media italiana», dice Philippe
Daverio, invitato alla conferenza di presentazione della mostra su Domenico
Spinosa, notando, con la consueta piacevolezza vocale, lo stato di grazia del
complesso. E qualcosa in me già inizia a incrinarsi. Mi trovo a una
retrospettiva su uno dei maestri napoletani più conosciuti, per gli studi e le
esperienze posso leggere uno stile preciso nelle sue opere, l’immediata
tensione all’astrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, cogliervi i rapporti
con l’ambiente del tempo e seguirne le influenze. Tutto storicizzato e ben
saldo nei libri, una conoscenza tranquillizzante, quindi, una consapevolezza. Questo
era tutto ciò che sapevo e che mi aspettavo di trovare, prima di ascoltare le
parole di Daverio e Nicola Spinosa,
storico soprintendente del Polo Museale Napoletano, dal 1984 al 2009.
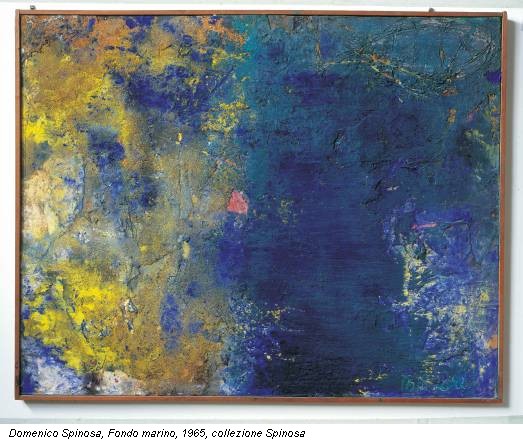
Daverio continua ad aprire il
varco, riferendosi strategicamente a un contesto di incertezze e debolezze
generali che la pratica e la teoria dell’arte si trovano ad affrontare, «c’era
una volta la favola dell’Europa», transitando su alcune derivazioni
dalla questione, «per quale motivo il mercato in Italia non riesce a portare avanti
i suoi maestri?», sfiorando infine il nucleo della questione, «questo delle
nostre tracce storiche è un problema gravissimo, perché indica un sistema
incapace di riconoscere le energie creative. Eppure, a Napoli vedo un’isola di
resistenza». Non posso non sentirmi chiamato direttamente in causa, anche solo
per le evidenti ragioni anagrafiche che, se mi mettono a distanza di sicurezza
dalla storia dell’astrazione del secondo dopoguerra, pure mi scaraventano nella
mischia di questo nuovo tipo di incertezza che è e, di fatto, continuerà a
essere, il paradigma percettivo di una intera generazione. Non malinconia da
Ancien Regime o aspirazione all’Avanguardia, non sentimento di qualcosa di
nuovo pronto a sostituire il passato, insomma, non l’instabilità, che
presuppone un punto fisso in relazione al quale sviluppare momenti di altro. Si
riesce a procedere solo per negazioni, per quanto ci si sforzi con i sinonimi e
con le figure retoriche è ancora impossibile trovare una definizione per tale condizione
generazionale, che chiamiamo incertezza ma in via orientativa, unicamente per
la sua comoda accezione indeterminata. Entrati in un campo indicibile, non
trovando un termine più adatto, ci accontentiamo.

Il riferimento di Daverio, invece, è inequivocabile
e mi chiama in causa non solo come generazione ma come abitante di una precisa latitudine.
Napoli come un’isola di resistenza. Qui, alla periferia della periferia di un
impero ormai sgretolato, nelle regioni provinciali del pensiero globale,
possono nascere nuove idee, nuove concezioni. Molto bello e stimolante,
l’identica immagine che dovevano avere presente Domenico Spinosa, Renato Barisani, Tatafiore che, con le strade invase dalle jeep degli Alleati, tra i
muri sbriciolati, «trovavano in questa città la forza di dialogare, di aprirsi
al mondo, per trasformare il Vesuvio in qualcosa d’altro, di nuovo», tuona
Nicola Spinosa. «Ma questa città dimentica continuamente se stessa, guarda solo
davanti e non ricorda il passato», continua con la voce abituata dalle
sigarette e dai decibel, da decenni di duro, durissimo, lavoro sul campo, a
stretto contatto operativo con artisti, critici, storici dell’arte. Spinosa si
riferisce alla città agli ultimi posti delle classifiche sulla vivibilità e
amata da tutti gli artisti del mondo, da chiunque abbia quel minimo di
sensibilità necessaria per attraversare la strada senza farsi investire e per
emozionarsi di fronte ai panorami, la città raccontata dalle tarantelle di
piazza e dai post del Saviano di turno, un luogo in cui l’esperienza quotidiana
deve sempre essere intrisa di una qualità eccezionale, bellezza faticosa come
una vetta difficile da raggiungere, altrimenti non è comunicabile. Gli
operatori estetici, come andava di moda chiamare, alcuni anni fa, chi si
occupava di queste cose, nella migliore delle ipotesi si trovano senza mezzi
per fronteggiare una struttura di racconto così imponente, puntellata su
piattaforme del calibro di Mondadori e Sky. Nella peggiore, è la città stessa
che continua ad alimentare la sua oleografia, la cartolina è sicuramente più
vendibile e tranquillizzante della cartografia, ci si arrangia come si può, in
attesa che passi la nottata. A parte quelle di livello altissimo, che seguono
meccanismi completamente diversi, le strutture intermedie, che dovrebbero
supportare la sperimentazione e la ricerca, non riescono a resistere per un periodo
abbastanza lungo, tale da intervenire con efficacia non tanto sul territorio ma
sulla formulazione di un’idea di territorio, codici estetici per esprimere
nuovi modelli di narrazione.

Così, chi non riesce ad accedere ai
rimasugli, è costretto a caricare armi e bagagli per andare da qualunque altra
parte, affidando alle bacheche dei social network tutti i rimpianti per il
clima mite, per la pizza sottile e per un certo modo di fare le cose che avrà
anche dato belle soddisfazioni ma non è riuscito a produrre altro, rispetto a
un breve momento preparatorio. E questo fatto così localistico, vicino al
folclore tribale, seguendo le meravigliose circonferenze del pensiero, torna alla
sua forma di problema generale. Se la città non è in grado di riconoscere le
sue energie creative, allora, tutto l’organismo potrebbe risentire dello stesso
problema. Forse, è successo che il sistema di riferimento è diventato obsoleto
rispetto alla produzione, non è un caso, infatti, che i nuovi, numerosissimi
fuoriusciti siano stati accolti con piacere e profitto da altri ambiti,
diventati incredibilmente affini all’arte, dalla grafica pubblicitaria ai
videogiochi e alle serie tv, non proprio arte tout court – se vogliamo essere pedanti
sulla terminologia – ma ormai ci siamo quasi.

Magari, una chiave di lettura potrebbe
iniziare a formarsi allargando il campo non alla superficie degli altri
linguaggi ma agli utenti che li parlano, tensione che sembra essersi persa,
considerandoli non come nuovi fruitori o soggetti di studi antropologici ma
potenziali artefici, pars costruens del senso e dell’estetica. Una cosa che è
già successa molte volte nel corso della storia, con le tendenze visive le cui
opere erano effetto e causa di un avvicendamento nelle modalità di fruizione,
conseguenza di mondi e società emergenti che volevano svilupparsi, anche
aprendo nuovi spazi in un’economia stabilizzata. Questa responsabilità investe
un’intera generazione, che ha tutti gli strumenti per conoscere perfettamente
le opere del passato, i movimenti artistici e le idee che esprimevano ma non sa
più con chi parlare del proprio presente, quale alfabeto usare.






.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)















