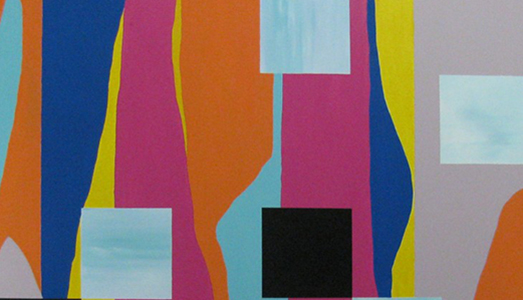Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
A guardare le cronache, con il rigoglioso prosperare di festival, eventi, mostre che contengono espliciti riferimenti ad azioni performative, sembra davvero che questo linguaggio stia conoscendo una rinnovata stagione di successi. Dalle grandi città alle periferie dell’arte, è un susseguirsi di proposte, a volte le performance “animano” o rianimano le mostre che dopo il vernissage si afflosciano su sé stesse, altre volte si tratta di kermesse o premi che ci fanno ritornare agli anni settanta, come non ricordare la mitica settimana della performance alla vecchia GAM di Bologna nel 1977? Il reprint dell’ormai introvabile catalogo ha colmato un vuoto editoriale e ha rilanciato un linguaggio artistico di cui si dovrebbe parlare più spesso. Alla faccia del mercato sempre più cieco e aggressivo, la temporalità concentrata della performance sembra una sopravvivenza arcana, agita le coscienze, innalza gli artisti all’eroismo del rapporto con il pubblico, a metterci la faccia e tutto il resto del corpo.
Per come ce la ricordiamo, la performance in senso classico fa parte di quel ritorno al corpo che ha caratterizzato gli anni sessanta e settanta in cui certamente il ruolo delle donne ha avuto un‘importanza pari alla violenza della loro esclusione sociale oltre che nel campo dell’arte. La nudità era sovversiva perché trasgrediva i canoni borghesi e poi era pubblica. La Marina Abramovic di Rhythm 0 del 1974 allo Studio Morra di Napoli attorniata da 72 oggetti, invitava il pubblico a usarli con e contro di lei. L’idea di mettersi in gioco e di “donarsi” al pubblico con conseguenze non prevedibili, faceva parte della sostanza della performance stessa. Anche Gina Pane cattolicamente offriva il suo sangue agli spettatori, però il suo corpo restava celato sotto i vestiti. Usava anche dei grandi occhiali scuri, il rapporto con il pubblico per lei era mediato dalla rappresentazione, era meno fisico, anche se il sangue sgorgava dalle sue blessures per ricordare che era tutto vero. Nel 2005 la stessa Abramovic archivia la fine di questo tipo di performance con Seven easy pièces in cui al Guggenheim Museum di New York interpreta sette performance storiche, da quella straordinaria di Valie Export in Genital panic (1969) al Beuys di How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965), lasciando a sé stessa il ruolo principale, come era scontato. Un mondo finito e chiuso in cineteca? Fino a un certo punto, il corpo sta zitto ma il suo è un silenzio assordante.
Poi c’è sempre stata un altro tipo di performance o azione, che aveva già tutte le caratteristiche dell’arte relazionale che da anni imperversa in tutte le salse para-sociologiche. Si pensi a Franco Vaccari e al suo indelebile Lasciate una traccia fotografica del vostro passaggio del 1972 alla Biennale di Venezia. In questo caso l’artista non partecipava direttamente ma delegava il pubblico a farlo. Alla fine degli autoscatti nella cabina automatica, la gente appendeva la sequenza di 4 immagini sulla parete messa a loro disposizione. La gente diventava protagonista mentre l’artista si faceva da parte, trovandosi il ruolo di catalizzatore e regista di un evento pubblico. Qualcosa del genere erano gli happening di Allan Kaprow, che già alla fine degli anni cinquanta portava il teatro in strada per uscire dal chiuso delle sale e stimolare il pubblico a riflettere su temi sociali o su sé stesso, o al ruolo degli individui nella società di massa o a prendere coscienza dei propri desideri. Probabilmente l’happening vive oggi in una forma attualizzata come il flash mob, in cui l’azione si materializza tra la gente comune grazie al tam tam immediato della tecnologia. Ancora una volta i non-luoghi vengono abitati, cambiano aspetto, forse solo per qualche minuto o qualche giornata.
In generale la performance oscilla sempre tra antropologia e sociologia. L’artista che si denuda fisicamente e mentalmente davanti al pubblico è colui che si proclama lo sciamano del villaggio, vedi Denis Oppenheim e lo stesso Joseph Beuys. Parla un linguaggio arcaico, primitivo, diretto. Assume il ruolo di portatore della verità, di una conoscenza sapienziale, oscura, profetica. Invece l’artista comportamentale si occupa di sociologia e di quello che fanno le persone se vengono adeguatamente sollecitate. Fanno indagini come nelle pubblicità di detersivi, chiedono alla gente che cos’è la felicità come farebbe un Gigi Marzullo. Eppure le performance culturali fanno parte del modo congiuntivo della cultura ed esprimono desiderio, ipotesi, possibilità. Nel caso della body art siamo invece in una fase più vicina al modo indicativo, all’azione diretta, alla ricerca non di una meta comunicazione alla Gregory Bateson, ma ad una proposizione diretta sulla realtà. Nuovi riti, nuovi miti.
Attorno a questi paradigmi artisti come Vanessa Beecroft o Marcello Maloberti hanno tracciato un percorso importante in cui hanno sperimentato tanto la partecipazione diretta all’azione che la regia, la mise en scene. La stimolazione di coinvolgere il corpo collettivo è importante per le azioni di strada, ma anche per le azioni ripetute, quelle che hanno luogo ad una determinata ora e determinato giorno. Probabilmente in Maloberti la carica umanistica che le performance sprigionano, va di pari passo con la ricerca di una razionalità del fare arte oggi e in questo modo. Vi è la ricerca di una diversità dell’essere artista che non è frattura con la società, ma tensione dialogica. Non una pura e semplice festosa liberazione carnascialesca alla Helio Oiticita, ma capacità e volontà di esserci. Infatti, è meglio evitare le trappole del sociologismo relazionale che conducono a scoprire l’ovvio senza riconoscerlo.
Ma altre strade si aprono, nuovi soggetti si affacciano alla scena dell’arte. Un artista e teorico performativo come Hannes Egger ha scritto già nel 2014 un libro dal titolo profetico “Web performance today” in cui il mondo collettivo è “naturalmente” il web come rizoma di scambio di esperienze di storie da rielaborare, di vissuti da scambiare con altri. Ha anche elaborato un Performance game per educare il pubblico giovane e della scuola. Valentina Colella nel 2016 ha realizzato una performance via Facebook, dislocando il proprio corpo nella rete dove ha raggiunto i più svariati e anonimi users. Dalla strada al web il passo non è poi così grande, anche se è chiaro che si ripropone il tema della fisicità Vs. virtualità, di quel esserci a metà a cui bisogna abituarci. Il corpo c’è sempre però, Maria Pia Zumpo si fa ricoprire dal pubblico di foglia d’oro in un tentativo di rinascita. L’artista napoletana all’opposto della Abramovic sollecita il pubblico a collaborare ad un rito contemporaneo, a mettere fuori le buone intenzione e non i peggiori istinti. Tempi che cambiano, finalità che mutano. Tra sopravvivenze e nuove possibilità il presente della performance è vivo non solo nelle decine di festival dedicati, ma anche nella volontà degli artisti di partecipare, di esserci in tutti i sensi anche in senso heideggeriano (e non poteva mancare). Non è un caso che un artista come Jan Fabre realizzi spesso delle performance dentro le sue mostre: le opere e la rappresentazione come diaframma e apparato non vanno lasciati da soli. L’artista è presente. (Valerio Dehò)






.jpg)