Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
14
giugno 2013
Che ne è dell’arte dopo la Biennale di Gioni?
altrecittà
La massiccia presenza degli “artisti per caso” che Massimiliano Gioni ha portato a Venezia manda all’aria i criteri per cui un manufatto è promosso ad opera e un dilettante al rango di artista. Ma questa operazione rivela una posta in gioco ben più decisiva: che cosa è l’arte oggi? Perché il suo essere onnicomprensiva, capace di appropriarsi di qualunque altro linguaggio, non basta più. Anzi, è proprio da qui che comincia una nuova storia
Se ne sta parlando tantissimo di questa Biennale di Massimiliano Gioni. E se ne parla bene, come è giusto che sia. Anche se, senza venire allo scoperto, c’è chi gufa che si tratti di una “Biennale furba”, poiché il presunto attacco al sistema dell’arte viene da una persona che in questo sistema ci sta allegramente e che quindi, con invidiabile (soprattutto invidiabile) astuzia, avrebbe collocato i big – leggi Paul Mc Carthy, Cindy Sherman sebbene in qualità di curatrice, Charles Ray, Tino Sehgal più le Leonesse d’oro Marisa Merz e Maria Lassnig e altri notabili evergreen– tra le pieghe del suo concettoso e ambizioso “Palazzo enciclopedico”.
Ammesso che sia vero, ce ne importa qualcosa? Direi di no. È una Biennale destinata a rimanere scolpita nella storia delle Biennali, che per certi versi ha illustri precedenti nell’altrettanto storica mostra “Le Magiciens de la Terre” allestita nel 1989 al Centre Pompidou di Parigi per la cura di Jean-Hubert Martin – l’Arsenale dopo il modello del “Palazzo Enciclopedico” di Marino Auriti si spalanca subito all’Africa, tanto per dirne una – e in qualche edizione di Documenta (compresa l’ultima, in particolare nella sezione che Carolyn Christov-Bakargiev ha denominato il “cervello”).
Ma veniamo al Palazzo Enciclopedico, di cui non voglio raccontare le opere esposte, semmai lodare ancora una volta la maniera impeccabile in cui sono presentate, dalle esaustive didascalie all’ordinamento tutto, che rende accessibile la lettura dell’idea di Gioni. Per inciso: condivido il rischio evidenziato da Luca Rossi in un post su Exibart circa la marginalizzazione delle opere a favore del primato del curatore, tuttavia in questa sede mi interessa fermarmi sull’idea dell’arte che questa Biennale ci propone. Anzi, che con eleganza ci sbatte in faccia.
Massimiliano Gioni è un fan di quell’idea “sferica” dell’arte più volte teorizzata da Germano Celant. Un’arte pervasiva e onnicomprensiva, capace di masticare tutti i linguaggi, e non solo. Che non solo mischia i vari codici visivi, di cui da anni si compone, con il suono (quante installazioni sonore sono presenti in questa Biennale? Tantissime), gli odori e allertando tutti i sensi possibili. Basta farsi un giro tra Arsenale e Padiglioni stranieri per percepire ancora una volta (se ce ne fosse bisogno) l’incredibile capacità dell’arte di inglobare tutto. Non c’è linguaggio culturale più dinamico, più duttile e più famelico, in grado di accogliere tutti gli altri al suo interno, come è oggi l’arte. Sotto la cui etichetta da tempo può rientrare tutto, anche quelle performance o installazioni che lasciano disorientati i più. E questo è possibile perché l’arte di oggi (e da tempo) non possiede più una centralità, perché si pone come linguaggio ibrido e ambiguo, perché, più che nella letteratura, il Dada ha trovato qui il terreno più fertile, perché il Surrealismo funziona meglio con le immagini che con le parole, che mantengono “un che di gabbia” e impediscono quella libertà assoluta che le immagini invece consentono. Perché il bricolage, come ricorda un libro di Angela Vettese, nell’arte si è trasformato in un linguaggio nobile. Perché l’arte “si fa con tutto” e accoglie tutto. Se questo sia un bene o meno, se questo significhi il definitivo divorzio dall’estetica, lo rimando a tra un po’.
Mi preme di più ora rimarcare che “l’arte sferica” si appropria anche di quello che meno ci piace dell’arte: il suo essere spesso molto apparentata al mercato, molto mondana e modaiola, il suo essere glamour. Fenomeni che penso sia l’ora di analizzare anche come capacità di dominare (e articolare) una fetta importante del mondo economico e commerciale e di imporsi come modello anche sulle pratiche d’intrattenimento, riuscendo addirittura a ridescriverne le coordinate. Mi diceva giorni fa svagatamene un’ex gallerista francese: “Ormai non si va più a Cannes, ma a Venezia, per la Biennale”. Ci fa orrore? Forse, ma la moda in genere segnala cose importanti. Anche se poi ci fa il business sopra.
L’arte “sferica” è anche questo. E probabilmente, come in tutte le sfere del mondo, accoglie al suo interno il buono e il cattivo, ammesso che sia possibile distinguerli con taglio manicheo. E questa arte onnicomprensiva, bulimica nel suo masticare e metabolizzare di tutto, l’hanno edificata gli artisti prima, rompendone gli argini, e i curatori dopo, teorizzando quella rottura e rilanciandone la portata. Quindi, è la nostra arte. E semmai sta a noi tirarne fuori il meglio, piuttosto che il peggio.
Penso che Massimiliano Gioni, non solo abbia chiaro tutto questo ma che, anche in virtù della forza dei suoi 40 anni, abbia scelto di sfidare questa “sfericità” per aprire un altro capitolo. Facendoci vedere quanto sia labile, arbitrario, se non addirittura improprio, decidere che cos’è arte e che cosa non lo è. Che a deciderlo siano criteri convenzionali (come minimo) se non commerciali o fatali (nel senso di fato, destino, fortuna: magari semplicemente trovarsi al posto giusto al momento giusto) e che chi non ci si trova, è tagliato fuori, pur intrattenendo un rapporto fecondo e immaginifico con il suo ristretto mondo, capace però di dilatarlo fino a fargli raggiungere quella altissima e poco chiara vetta dell’universale.
È impressionante la prevalenza del dato biografico in questa Biennale: non lo sfondo sociale a decidere della pertinenza (o bontà, talvolta) delle scelte artistiche, non l’essere parte di un conflitto, ma la vita vissuta ai margini, spesso in condizioni disagiate, che fanno diventare l’individuo “artista per caso”, o suo malgrado. Dove l’arte ha il volto del dono: dono ricevuto (e ci si mette a dipingere dopo che qualcuno ha regalato matita e pennelli) e riscatto del dono: la possibilità di una vita diversa, e di senso, a partire da un fare. Chi è, allora, e che cosa decide se il lavoro marginale di quell’individuo sia arte o meno? Mi pare che Gioni, a differenza di quello che qualcuno insinua, metta molto in questione il mercato. Come reagirà questo di fronte a quella che fino a poco fa era considerata non arte? Si rimboccheranno le maniche, galleristi e dealer, per scovare nei vari angoli del pianeta manufatti e consimili, partoriti da sciamani o da sconosciuti in beata solitudine?
Ma, questioni di mercato a parte, direi che Gioni pone una domanda forte sull’idea stessa dell’arte, che cosa è oggi e che cosa è dopo che, lui in maniera esplicita e con meno chiarezza altri prima di lui, l’hanno dilata fino a farla esplodere. Il Libro Rosso di Jung che di fatto (e simbolicamente) spinge il sapere verso le soglie dell’irrazionale, del non codificabile e, parallelamente, il modello di Auriti che salda il sapere, e l’arte che in questo sta, a un’utopia altrettanto non codificabile, cambiano (forse per sempre) l’idea (ammesso che l’uso di questa parola si ancora valido) dell’arte. Perché se abbiamo per anni accettato (e oltre) oggetti, mise en scene, situazioni, prelievi dalla strada e dal pensiero corrente, scarabocchi e pasticci di colori che all’interno del nostro sistema erano arte e fuori di questa cerchia erano autentiche schifezze (basta ancora il gesto dell’artista per trasformare il ranocchio in principe?), è legittimo porre la questione a quale titolo disegni fatti in totale solitudine, costruzioni alambiccate, vibranti reperti di mondi lontani su cui è stato fatto un investimento di senso (magari condiviso) invece non lo siano. Chi lo decide, il mercato, i curatori, i critici? Che senso e quale legittimità hanno questi quando a vacillare, a sfaldarsi è la stessa idea dell’arte? Ha ragione allora il Museum of Everything, che guarda caso a Venezia è a metà percorso tra Giardini e Arsenale, che raccoglie l’operato degli outsider? Ci consegniamo a questo o ripensiamo (ripartiamo) dalle ceneri dell’arte?
Rimane la questione del divorzio dall’estetica. Ma non è già stato abbondantemente consumato a partire dall’ingresso di un orinatoio in un museo che l’artista ha trasformato in Fontaine, solo per citare lo strappo più violento? Nella non estetica dell’arte viviamo da molto tempo, come ben sappiamo, e l’estetica, alla quale abbiamo rinunciato a partire dagli artisti, è migrata altrove: nel design, nella moda, nel cibo che, “decorato ad arte” prende il simpatico nome di food. Linguaggi che non a caso guardano ancora molto all’arte, anche se questa non ha più a che fare con l’estetica – e, spiace dirlo, sono proprio i filosofi a mostrare il fiato corto su questo – ma mantiene al suo interno la capacità trasformativa, etero e autoreferita. E penso che questa capacità trasformativa sia quello che sta a cuore a Gioni e che ci ha voluto far vedere, scoprendo altre trasformazioni, altre possibilità di investimenti di senso.
Che poi tutto questo sia fatto in modo eccellente, tirando fuori anche disegni, pitture e storie “belle”, beh allora possiamo dire che Massimiliano ha vinto la sua scommessa. E che bisogna ripensare un bel po’ di cose.










.jpg)




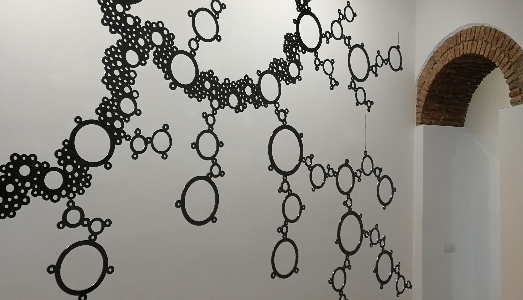


















Massimiliano Gioni è stato bravissimo e concordo con te Adriana, questa Biennale rimmarrà scolpita nella storia delle biennali come un punto di svolta, di violenta sterzata, di ripensamento globale…una mostra allestita in maniera impeccabile, anzi io di mostre allestite così perfettamente forse non ne avevo mai viste, un’esposizione apparentemente complessa ma di facile lettura grazie alle schede perfette, esaurienti e talvolta affascinanti (alcune storie per me rimngono indimenticabili) che corredavano ogni lavoro, un piacere leggerle per entrare in un mondo parallelo dominato dall’ossessione. Il nostro mondo è in crisi, i valori a cui ci siamo tutti, chi più chi meno, aggrappati per dare un senso e anche uno scopo alla vita si sono come disciolti. Il pensiero illuministico razionale ha perso e, da sempre, l’essere umano nei momenti di passaggio, di incertezza e di perdita dei punti di riferimento si rifugia nell’irrazionale, nel metafisico, nei sogni e nelle utopie. Marino Auriti, ormai famosissimo, era un utopista, un folle epitomo di Diderot e D’Alambert che ha provato ad immaginare un luogo dove raccogliere fisicamente lo scibile umano, in una sorta appunto di Palazzo Enciclpedico che è la rappresentazione tattile, muscolare, viva dei volumi dei suoi predecessori francesi.Niente sembra darci più fiducia e se Marx è morto certamente Dio non sta meglio travolto e calpestato da una curia che sprofonda negli scandali a base di sesso e denaro, i credi monoteisti non sembrano dare più risposte convincenti e quindi perchè non trovare una via alternativa in una sorta di a-religiosità primitiva e animista? L’arte contemporanea è appunto sferica, globale, tutto introietta e tutto tocca e mette in cortocircuito, l’arte è religione e la religione può certamente essere una forma d’arte. La scrittura automatica, i disegni fatti in trance, le visioni extrasensoriali dipinte da esseri umani che parlavano con gli angeli. Qualcuno ha detto che in questa Biennale gli oggetti prevalgono sulle forme…si forse si, gli oggetti sono tanti, tantissimi, casette di bambola, casette utopiche, architetture fantastiche, disegni fatti con il fumo, bambole-bambine dallo sguardo inquietante, statuine di terracotte, bandiere rituali, diari, fotografie, ma la risposta forse è proprio questa, la crisi è la risposta, il sincretismo culturale e certo si, la forma e l’opera non possono che essere granitiche risposte. Poche forme, poche opere ma che svettavano come giganti come ad indicarci un cammino, e lungo la strada la nostra follia che si disperde in mille risposte ad una sola domanda, e tutte le strade sono valide, come forse tutte le risposte. Forse dovremmo abbandonare le cose alla loro solitudine per valorizzarle o forse è bene immergersi dentro questo mondo di cose, di immagini, di stimoli, di sensazioni per uscire da troppi percorsi già segnati, già battuti, già vecchi. Grazie Massimiliano per questo tuo enciclopedico lavoro di archiviazione, catalogazione, ricerca, esposizione. Secondo me hai aperto uno squarcio. Il mercato ne approfitterà??? chi se ne importa, l’opera d’arte è un dispositivo di senso ma anche una merce e in questo non c’è nulla di male.
Dear Adriana, Nice article, and thank you for soliciting responses. Everything I have to say about art — and any Biennale — is represented in the show “A Very Light Art,” at Ca’ Rezzonico, in Venice. Sponsored by the Musei Civici Veneziani, and C. Tognon, a Venetian gallery. Featuring Airo, Arienti, Favelli, Ontani, Orozco, Wyn Evans, and Zoberng. Baci from Rome, Cornelia
Devo dire che questo è l’articolo sulla Biennale che mi trova maggiormente d’accordo. Altri approcci rischiano di essere troppo “novecenteschi”. Dove Gioni indica un andare alle radici del “fare arte” (fatto di ossessioni e sistematizzazioni, impulsi inconsci o spiritualistici), molti hanno visto solo il culto dell’irrazionale, della visione surrealista e, in altri casi, pura furberia da giovane curatore rampante. Gioni si è interrogato sul perché delle immagini (archetipiche?); non a caso jung è una delle chiavi di lettura. Non il caos tipico delle biennali o fiere sparse per il mondo ma un momento di pausa… per ripartire.
Gentile Adriana Polveroni,
leggo volentieri i suoi editoriali e dopo la lettura di questo articolo sono ancora più certa della qualità della sua linea editoriale e delle sue idee sull’arte e sul sistema dell’arte che condivido pienamente.
Avevo in programma di visitare la Biennale in autunno, e dopo la lettura del suo articolo spero che l’autunno arrivi presto.
Cordiali saluti
Cecilia Perrozzi
Il Sig.re M.Gioni con un budget molto limitato ha fatto una scelta intelligente e funzionale, confezionando una mostra con cose non troppo sovraesposte (anche se molte ben inserite nel sistema in crescita in questi ultimi anni, conferma l’attuale ArtBasel che già ottimizza la proposta).
La storia del curatore che primeggia mi pare un fatto assodato da almeno un decennio per cui non ci vedo nulla di nuovo, forse la capacità di giostrarsi sempre di più sulle derive dell’arte mi pare un fatto in forte crescita e da mettere in risalto.
Il mercato non piacerà ma senza di esso non ci sarebbe più l’arte, che esiste proprio per alimentare questo mercato. Oggi il concetto di arte è tenuto in vita per una “filiera” di prodotto che è ben struttura.
Tanto più quando come è successo in questa biennale si allontana lo sguardo da chi professa la professione di artista a vantaggio di “proposte” marginali, più facilmente gestibili da operatori commerciali.
Che tutto questo rimanga negli annali non saprei già dopo alcuni giorni, passeggiando per Basilea la mente viene rapita da cose più forti e pregnanti, soprattutto da una forza “visionaria” che nel suo complesso la Biennale di Gioni sfiora ma non raggiunge.
Il Palazzo Enciclopedico è la ragnatela di ansia che invade il nostro quotidiano. Come gli spettatori nella sala dei Giganti a palazzo Te dove, i fasti dei Gonzaga celebrati armoniosamente da Andrea Mantegna sono sostituiti da Giulio Romano con i tronchi di colonne spezzate, assistiamo sgomenti al crollo di ogni sicurezza, ed elaboriamo, come animali braccati nella savana, strategie di sopravvivenza. Il cibo, la natura, la politica, la genetica, la tecnologia ci proiettano nella sfera dell’artificiale, dalla quale solo il sogno può salvarci. Ma in questi giorni sconnessi anche i sogni si trasformano presto in incubi, ossessioni, manie, follie e incantesimi, e le immagini del palazzo Enciclopedico ci crollano addosso all’interno dei padiglioni nazionali, dove l’armonia misurata e segreta di ritratti e pale d’altare è mutata in ambienti pervasi da un senso di catastrofe imminente. Come bloccare lo sfarzo incontenibile dei plutocrati russi, se non traducendolo in una parodia mitologica, si domanda Zacharov, mentre Jeremy Deller fa scaraventare lo yacht di Abramovic da un William Morris redivivo? Quale bizzarria della genetica permette ad un tronco di farsi corpo di gigante ferito ritrovato in un abisso, si chiede Berlinde de Bruyckere, vicino ai cumuli di pietre, sabbie e vetri che compongono il paesaggio di rovine di Lara Almarcegui? Mark Manders tiene pressati i materiali della scultura con cinghie e tiranti, Anri Sala riflette sulla possibilità di trasformare un handicap fisico in un diverso modo di comporre musica, e Mathias Poledna svela la strategia di potere celata dalle immagini di un cartone animato in stile Walt Disney negli anni Trenta. Gli 800 sgabelli di legno raccolti da Ai Wei Wei sono tracce della cultura cinese spazzata via dalla Rivoluzione, così come gli archivi fotografati da Dayanita Singh saranno ben presto sostituiti da banche dati informatici.
Perfino i ragazzi che emettono suoni disarticolati nelle performance di Tino Seghal sembrano persone in stato di trance o in preda ad attacchi epilettici, quasi per farci riflettere su patologie neurologiche sempre più frequenti come gli attacchi di panico o le fasi acute della depressione. Nella dimensione museale e perfetta di questa Biennale, una delle più intense e interessanti degli ultimi decenni, si nasconde la stessa cupio dissolvi della camera dei Giganti di Giulio Romano. In un mondo travolto da una trasformazione che sembra infinita, ci sarà possibilità di salvezza?
Mi arriva notizia che Bartolomeo, curatore designato dell’ultimo Padiglione Italia, abbia nominato sua moglie come architetto del Padiglione; abbia nominato altri 14 curatori per curare una mostra di 14 artisti (15 curatori per 14 artisti di cui almeno due deceduti); abbia speso 28.000 euro per far arrivare uno chef da Roma; abbia avuto bisogno di 850.000 euro per fare la mostra, di cui 250.000 raccolti tramite donazione del pubblico. Tutto questo per una mostra che non è a fuoco, e dove anche buoni artisti vengono depotenziati dalle scelte curatoriali. Se passiamo alla Biennale di Massimiliano Gioni, capiamo subito che si finisce solo per parlare di Gioni e del suo progetto curatoriale, come se lui e solo lui fosse l’artista-regista. Tutti cadono in questa trappola, mentre non si parla delle opere, che sembrano sfumature, inutili e inconsistenti se prese singolarmente. La Biennale di Gioni è una grande installazione, è l’opera di Gioni.
Alla vicina Fondazione Prada, sempre a Venezia, si propone il re-make di una mostra del 1969, curata da ben tre persone. Guardando tutto questo mi sembra che il ruolo di artista, anche solo rispetto a quello di “curatore” (evidentemente ci sono tantissimi malati…), sia profondamente in crisi e profondamente debole. Tale ruolo, per come comunemente inteso, è anacronistico, e il centro dell’opera è altrove, forse da dove arrivano le pizze. Dell’opera non importa a nessuno. Come giustamente rilevato dall’ultimo film di Sorrentino (La Grande Bellezza) l’arte contemporanea sembra popolata da gente vuota e inutilmente eccentrica, mentre come “opera d’arte” sembra giustificabile tutto e il contrario di tutto; ed è vero ma servirebbe consapevolezza critica. Da quattro anni cerco di stimolare un confronto che possa spingere verso questa consapevolezza;mi interessa stimolare e innescare un confronto, non dirigerlo; non vorrei mai imporre sintesi, ma fornire tesi grezze, in attesa di antitesi che arrivano raramente; non mi sento certo un critico, un artista o un curatore, ma semplicemente uno spettatore attento, come evidentemente non ne esistono o ne esistono pochi. Tendenzialmente, vengo ovviamente censurato e ostracizzato, perchè in questo sistema servono persone deboli, che non devono pensare, manipolabili..in una parola mediocri. Ed ecco molti artisti odierni. Compresi quelli che stanno ancora “fuggendo” dagli anni 90, e stanno chiusi nel negozio con fuori il cartello del “torno subito”.
Ma non credo che sia sufficiente criticare, anzi è fin troppo facile fare Gesù nel tempio che da buoni consigli. L’alternativa sta in una retroguardia. Un passo indietro, per vedere meglio le cose e avvicinarsi (senza poterla raggiungere) a quella consapevolezza critica di cui scrivevo prima. Tale consapevolezza permette di ritrovare il centro dell’opera, e di materializzarla oltre la dittatura delle pubbliche relazioni.
Un passo indietro equivale a precipitare. Una retroguardia che ti costringe a un precipizio, in cui non sai se cercare appigli o metterti in una posizione più aereodinamica. Uno spettatore che precipita.
A questo proposito vorrei mettere in relazione 4 progetti: ship for two japanese, opening, gagosian projetc e “Everything you..”.L’ultimo in ordine temporale è “ship for two japanese”. Mi accorgo solo ora dopo diversi giorni dalla sua presentazione, che potrebbero essere i resti di uno spettatore che precipita. L’opera è discesa, in modo logico e argomentato, da un dialogo con due ragazze giapponesi in fila per entrare nel Padiglione dei Paesi Nordici. Se il centro dell’opera è “altrove” non raggiungibile con i mezzi tradizionali, abbiamo pensato di invertire la logica di un mezzo tradizionale come la barca. L’opera vive una fibrillazione fra tre dimensioni: l’opera fruita da me e dalle due ragazze, forse da qualche altro spettatore; il vuoto che c’è ora davanti al Padiglione dei Paesi Nordici e la documentazione dell’opera che trovate più in basso su questo blog.
Gli altri tre progetti discendono sempre da questa immagine di uno spettatore che precipita. Forse il ruolo ,oggi, più vicino a quello di artista, come comunemente inteso.
Dopo gli anni 90, vediamo un istituzionalizzazione un professionismo del ruolo di artista. A questo fatto bisogna aggiungere sovraproduzione di opere e saturazione del linguaggio. E non esistono barriere all’entrata nè per fare nè per comunicare il proprio lavoro. Io posso chiudermi in questa stanza, fotografare, fare un portfolio e comunicarlo al mondo via internet. Questo ha paradossalmente depotenziato il ruolo di artista: servono altre figure, come il curatore, per caricare di ragioni, motivazioni e valore l’opera. Mi sembra significativo che Tino Sehgal abbia vinto il Leone d’oro. Un lavoro molto significativo che esiste solo in ragione del sostegno di luoghi(place) e pubbliche relazioni (rays), e fatto realmente di una materia fatta di luogo e pubbliche relazioni.
Bella la definizione di “arte sferica”, a tutto tondo, che ingloba tutto il possibile. Accanto alla sfera globale ricorda però anche il Blob che ingoia tutto e tutto trasforma in una gelatina informe che cresce. Emergono i mille motivi per cui qualcosa può essere considerata arte, ma che lascia affiorare il sentore che non lo si possa in realtà definire, in un momento dove parafrasando Duchamp, tutto potrebbe essere arte, come potrebbe non esserlo. Mi sembra rilevante nell’articolo l’interrogarsi sul rifiuto dell’estetico da parte dell’arte contemporanea, e il chiedersi dove sia finito. La domanda che appare innocente, non lo è affatto, pone in effetti una questione capitale: ammesso che l’arte contemporanea si stia trasformando in un Blob, forse l’estetico, il bello, può riportare un senso e una universalità? In effetti ci sono molte premesse che lasciano supporre che la strada sia quella, o meglio se la situazione non si sblocca, sarà necessariamente quella, intendendo ciò in un mutamento spontaneo, istintivo che non tiene più conto dei dogmi del contemporaneo (Nietzsche diceva: I nuovi valori nascono da sé una volta eliminato il mondo “vero” (la sovrastruttura intellettualizzata). Tra i massimi filosofi del Novecento hanno posto questo problema, oggi Emanuele Severino scrive: «quando la civiltà della tecnica avrà fallito, non rimarrà che l’arte e il bello, che sono sinonimi, perché un’arte non bella è un’arte difettosa». Una frase profetica ma con motivazioni profonde. In effetti siamo nel mezzo della crisi di una cultura che sembra arrivata alla sua determinazione finale, e si sta incominciando a non sperare più nell’onnipotenza dell’oggettivazione: la fallacia delle ideologie, l’insufficienza delle tecno scienze, che se risolvono problemi ne creano inevitabilmente altri (vedi dissesto ambientale, esaurimento delle risorse, competizione globale, crisi economica e crisi del soggetto) La fine della modernità di cui si parla da molto tempo, è determinata dall’essersi resi conto che per questa via non si arriva a eliminare tutti i problemi dell’umanità, che ritornano sempre sotto altre forme. Nell’arte contemporanea la questione è analoga, proprio nel rendersi conto che la rappresentazione (il linguaggio, lo stile, il contenuto) non può sostituire uno statuto ontologico più vasto, non può costituire il fondamento; rendersi conto cioè che l’estetica e la storia su cui si sono costituiti i paradigmi del contemporaneo non sono in grado di determinare un valore universale dell’arte.
D’altro canto è legittima anche la domanda dove è finito il bello oggi? E la risposta mi sembra anche corretta quando si rileva l’onnipresenza dell’intrattenimento superficiale e soggettivo. La nostra civiltà affidando tutto a una cultura dell’oggettivazione ha abbandonato la coltivazione del soggetto: a scuola si insegna la storia dell’arte e non a riconoscere il bello, così come sul versante religioso (che è l’altra questione cruciale) sono i precetti, i dogmi, la storia e la teologia ad essere in primo piano; non sicuramente le mistiche, i riti, la preghiera, per arrivare a sentire l’afflato cosmico da cui nasce ogni fede. Questo per dire che un uomo che pensa di risolvere tutto con la ragione non potrà che rimanere scisso tra una razionalità ipertrofica e una soggettività banale, dedita solo al puro divertimento.
Eppure nella nostra cultura rimane ancora una istituzione dove si coltiva il soggetto: l’esecuzione della musica classica (forse anche la danza classica). Al di là della conservazione di una cosa del passato, si coltiva anche la facoltà di percepirne l’atemporalità in cui risiede l’essenza, in quanto il bello trascende la storicità dello stile, anche se su di esso di appoggia necessariamente.
Qui ci troviamo a scoprire una cosa molto importante, che è difficile da accettare in un’ottica moderna, come sostiene Elemire Zolla: il bello è percepibile come valore intersoggettivo universale, solo grazie all’esercizio su forme canoniche (sempre Nietzsche: «Non attraverso la conoscenza, ma con l’esercizio e un modello noi diventiamo noi stessi»). Come nella musica classica suonando e risuonando gli stessi brani si arriva a percepire la qualità della musica e dell’esecuzione. Solo facendo e rifacendo le stesse forme si supera la loro storicità e si perviene all’essenza. Ecco perché le grandi opere del passato che riconosciamo come immortali emergono sempre da culture dove i modelli erano uniformati in modo più o meno rigoroso (Raffaello dipingeva come Perugino – e come molti altri – ma con una qualità superiore).
Dunque oggi il “bello” anche se fosse prodotto nell’opera di artisti (e lo è) la maggior parte di coloro che operano nell’ambito dell’arte contemporanea non lo riconoscerebbero, semplicemente perché si sono coltivati nel cercare un valore nell’oggettivazione del linguaggio e non nella soggettivazione della percezione estetica. Il contraddittorio è che non possiamo più per diverse ragioni accettare un modello fisso, ma il modo per superare il problema lo hanno trovato gli artisti che hanno fatto questo passo. Tra questi c’è David Hockney che da una decina d’anni ha mutato radicalmente le sue modalità espressive, qui risiede la grande novità del cambio di paradigma in cui siamo immersi. Tutto ciò è teorizzato in modo esplicito nel mio libro Figura Solare, (Marietti 2011) recensito qualche mese fa su queste pagine da Ernesto Jannini.
È l’arte, a mio parere, ad essere stata inglobata dagli altri linguaggi e non viceversa. Se è vero che l’arte è testimonianza del proprio tempo è vero che testimonia la sua assenza e la sua disfatta nella sua incapacità di affermare il proprio linguaggio. Ceduta alle lusinghe del mercato ha negato le sue potenzialità. 0
Un manufatto , di qualsiasi origine, tecnica, grandezza e intenzione, è arte se è ARTE, cioè contiene ed esprime quella particolare tensione,
che lo rende altro da un prodotto artigianale o semplicemente ludico e creativo.
So che sembra un’affermazione lapidaria, poco articolata, ma questo è ciò che penso, credo e sento.
Il problema semmai è saper riconoscere questa tensione. Possono vederla solo altri(alcuni), artisti o quelle persone di sensibilità e cultura atte a captarla.Ugualmente questo è un momento irrinunciabile per la sperimentazioe, l’avventura, l’azzardo, la libertà di espressione. Questo momento storico confuso riguardo all’arte, ma formidabile per l’esplosione di qualsivoglia talento, magari ancora non ben definibile e definito.
Chi capisce davvero sono comunque un manipolo; il resto è spettacolo.
La Biennale di Gioni mi è piaciuta moltissimo: la più bella e linguisticamente complessa che io ricordi. È bello vedere che un quarantenne riporta alla vita un bisogno profondo e struggente di riconoscimento e di comprensione del mondo che travalica ogni barriera linguistica… qualcuno che è stato capace di arrivare al cuore… all’anima, per sentirsi “appartenente” .
Tutto passa dal corpo che diventa generatore di trasformazione di energia, chiave di percezione, appercezione e comprensione del mondo. Questo è per me una sorta di nuovo Rinascimento. E questa Biennale è un inno alla ricerca di senso, al di là dell’estetica.
Due parole sui Padiglioni e le mostre fuori Biennale: impeccabile quello olandese con Manders, commovente quello del Belgio, fortissimo quello di Israele, bello quello americano e quello dei Paesi Nordici. Ho trovato didascalico il Padiglione russo che tutti hanno declamato, poco interessanti quello tedesco e quello francese. Il Padiglione Italia era di un buon livello, soprattutto la sala Ghirri/Vitone, quella di Benassi/Baruchello e il lavoro della Grilli. Una perla il padiglione messicano.
Prada mostra per me macchinosa e quasi ‘illeggibile’ dal punto di vista museografico. Bella e d’impatto anche emozionale la mostra di Palazzo Grassi. Della mostra di Punta della Dogana mi e piaciuta soprattutto la messa in dialogo tra Minimalismo orientale e Arte Povera italiana.
Anche i concordo sul fatto che sia una Biennale bellissima. Ricca di spunti e di riflessioni su cosa rappresenti l’Arte oggi e chi sia veramente l’Artista contemporaneo.
Mi sono avventurata da un Padiglione all’altro mai sazia o stanca, ma col desiderio di vedere e osservare ancora.
Anche io credo che questa Biennale cambi tutto. Sia un punto di svolta e di non ritorno.
L’Arte, gli artisti e i curatori d’ora in poi dovranno fare i conti con l’idea proposta da Gioni. L’arte è talmente caotica oggi, che non è possibile ri9assumerla, ma costruire dei percorsi e delle riflessioni attingento a forme d’arte diverse tra loro. Ma soprattutto si dovrà fare i conti con la domanda fondamentale che mi ha lasciato questa Biennale. Chi può veramente essere considerato artista oggi? Se è possibile inglobare artisti autodidatti e per passatempo alla Biennale di Venezia e apprezzarne il contributo, chi è allora l’artista? Non è forse che siamo avvolti dall’arte, permea talmente tanto la nostra esistenza che a volte non ci accorgiamo che onnipresente negli oggetti quotidiani, nelle riviste che leggiamo, nel web dove navighiamo.
Il Venezuela ha proposto, ad esempio, un Padiglione memorabile da questo punto di vista. Ha portato la street art in Biennale. Straordinario!
Considerando che siamo il paese ospitante,la posizione del Padiglione Italia alla biennale dovrebbe tornare ad avere una maggiore centralità , invece di essere dislocato all’estremità dell’Arsenale. Come nelle prime lontane edizioni ,quando si trovava ai Giardini nel Padiglione Pro Arte ora sede istituzionale della mostra principale della Biennale. Trovare una giusta collocazione credo che sia importante.
Ho trovato sconfortante che alcuni curatori in gran parte stranieri e altri addetti ai lavori non siano riusciti a visitare il padiglione e quando sono riusciti a raggiungerlo erano talmente stremati che diventava una mera passeggiata tra i lavori a cui non si dava l’attenzione dovuta. D’altronde la Biennale si sta sempre più espandendo, si aggiungono nuovi padiglioni, e la città pullula di mostre diffuse di grande richiamo. Ritornare ad essere in una posizione centrale darebbe sicuramente maggiore visibilità.
Sappiamo che è un dibattito ripreso anni fa, ma mai completamente risolto.
Un altro elemento importante è l’investimento economico che il Ministero per i beni e le attività culturali dovrebbe stanziare. Basti pensare al passato delle Biennale quando si cercò in tutti i modi di far partecipare con sostanziosi contributi economici Stato, Regione, Provincia e Comune. Non siamo più competitivi. Gli sforzi economici degli altri padiglioni sono nettamente superiori, il coinvolgimento delle gallerie è presente ma non in modo così preponderante come nella situazione italiana. Mancano poi sponsor di rilievo che diano un contributo economico ai singoli padiglioni.
IL PALAZZO DI EVERYTHING // EXTENDED UNTIL THE 18th OF AUGUST
We have the pleasure to let you know that our Exhibition Il Palazzo di Everything has been extended until the 18th of August!
See you soon,
The Museum of Everything
WHAT Il Palazzo di Everything
featuring
Carlo Zinelli and The Salon of Everything
WHEN from 29th May to 18th August 2013
Tuesday to Sunday // 11am to 7:30pm
WHERE Serra dei Giardini (The Greenhouse)
Viale Giuseppe Garibaldi, 1254
Castello 30122, Venice
HOW next to the entrance of the Giardini
map: http://goo.gl/maps/qXoSq
vaporetto: Giardini
WHY Official Collateral Event of the 55th Venice Biennale