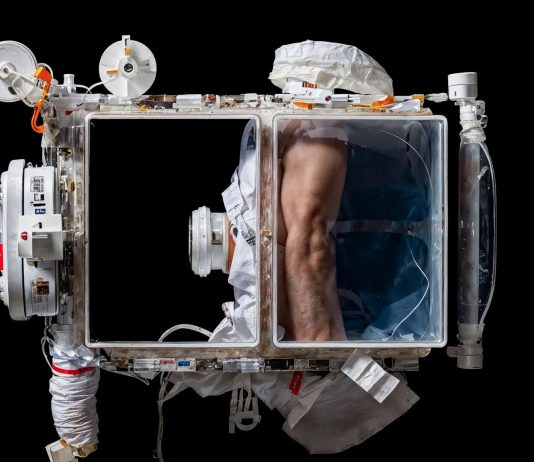-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
Il direttore del Centro d’Arte Contemporanea di Tel Aviv, Nicola Trezzi, racconta limiti e potenzialità della scena israeliana
Arte contemporanea
di Lea Foà
Halon procede focalizzandosi su CCA Tel Aviv-Yafo (CCA è l’abbreviazione di Center for Contemporary Art, centro per l’arte contemporanea), istituzione no-profit nata nel 1998 come club di video arte che si teneva nella Cineteca di Tel Aviv e da diversi anni ormai centrale nella sperimentazione a livello istituzionale. CCA, che si trova a pochi passi dallo Shuk Ha’Carmel, il principale mercato della città bianca, è diretta dal curatore italiano Nicola Trezzi, nato nel 1982 a Magenta (MI).
Attraverso un intenso programma che prevede circa sette mostre l’anno, il Centro promuove artisti che sono nati in Israele o che vivono in Israele (il che significa anche Palestinesi che vivono in Israele e Israeliani che vivono all’estero) e artisti stranieri. Nata come situazione di nicchia, CCA è diventata nel giro di 25 anni, cinque dei quali diretti da Nicola Trezzi, un luogo di ritrovo per scena artistica della città e del paese.
Parlando del Centro, il Direttore dice: «A mio avviso CCA dà la possibilità agli artisti emergenti di esprimersi molto liberamente. C’è poca burocrazia che li schiaccia e hanno a disposizione un budget che permette loro di presentare progetti che non sarebbero possibili in altri contesti. In altre parole CCA fa mostre che, per diverse ragioni, spazi alternativi, musei e gallerie commerciali non si possono permettere».

Sei arrivato per la prima volta in Israele con Artis, iniziativa che ha come obbiettivo promuovere artisti da Israele all’estero; quali sono le difficoltà che devono affrontare gli artisti israeliani che si vogliono affacciare sulla scena contemporanea internazionale?
«Sono venuto in Israele per la prima volta nel 2008 e da allora la mia conoscenza della scena è profondamente cambiata; vivo e lavoro in Israele da otto anni ormai, dal 2016, e vedo condizioni doppie e parallele. Da un lato, gli artisti Israeliani devono confrontarsi con situazioni vicine ai movimenti BDS, acronimo di Boycott, Divestment, Sanctions, che significa sanzioni di boicottaggio e disinvestimento culturale su Israele ma dall’altro lato ci sono molte situazioni, tra le quali diverse legate alla filantropia ebraica, che non sono ostili. È importante inoltre sottolineare la differenza tra artisti e istituzioni. I primi, in quanto individui, sono meno soggetti al boicottaggio, diversamente dalle istituzioni pubbliche che ricevono fondi statali e quindi soggette alle regole dei movimenti BDS. Ultima cosa, ma non per importanza, è la differenza tra essere Israeliano e vivere in Israele e essere Israeliano e vivere altrove.
A questo proposito penso che i veri problemi, sistematici, siano interni. La filantropia locale verso l’arte contemporanea è molto scarsa e non c’è tanto collezionismo. Nella maggior parte dei paesi occidentali il collezionismo non fa distinzioni tra gli artisti del posto e quelli stranieri; in Israele invece la maggior parte delle gallerie, delle istituzioni e dei collezionisti puntano solo sugli artisti israeliani. Questo fatto, che può sembrare positivo, di supporto, invece non lo è poiché genera maggiore chiusura e minori scambi internazionali, che sono alla base dell’emancipazione di qualunque scena artistica che voglia definirsi tale».

Quali pensi che siano le ragioni di questo fenomeno?
«Le ragioni, di carattere logistico, politico-economico e culturale, sono profonde e complesse. C’è una questione legata a problemi fiscali, per esempio spedire e soprattutto importare opere d’arte in Israele costa moltissimo; per quanto riguarda le scelte politico-economiche basti pensare che nelle sue valutazioni il ministero della cultura considera solo le mostre fatte con artisti israeliani e di conseguenza solo istituzioni come CCA, Tel Aviv Museum of Art e Israel Museum Jerusalem, che hanno una struttura internazionale, possono permettersi di esporre artisti stranieri.
Culturalmente, c’è una convinzione, falsa a mio avviso, che la scena artistica sia isolata e che quindi vada supportata al suo interno dando spazio agli artisti locali che altrimenti non hanno occasioni di esporre. In realtà questo crea solo più isolamento, abbassa la qualità dell’offerta, e, invece che risolvere il problema, lo aggrava, creando una realtà paradossale nella quale artisti come Keren Cytter e Daniel Silver hanno avuto grazie a me la loro prima personale istituzionale nel paese i cui sono cresciuti».

Come è cambiato il tuo approccio alla curatela una volta arrivato in Israele?
«Il mio approccio è cambiato ma non per via d’Israele ma a causa di CCA. Sebbene abbia sempre lavorato per qualcuno, da Flash Art International, alla Bezalel Academy of Art and Design, ho sempre curato da indipendente e quasi sempre curato mostre collettive. Invece CCA fa solo mostre personali, delle sette all’anno solo una è collettiva e non sempre la curo io. Lavorare su personali, che non sono retrospettive bensì nuove commissioni e produzioni solo con artisti viventi, richiede un approccio completamente diverso.
Nello specifico, il curatore di nuove commissioni e produzioni si trasforma spesso in un agente che deve comunicare il lavoro e non curarlo, ma soprattutto produrlo, che si traduce nella mera ricerca di fondi; in questo frangente vorrei chiarire che il sostegno pubblico a CCA, che sono la municipalità e il ministero, è pari al 20% del budget totale e non copre nemmeno le spese di manutenzione. In altre parole i fondi per le mostre vanno sempre e tutti trovati dal sottoscritto aiutato dallo staff e dal board of directors (consiglio direttivo).
In questo scenario dove la creatività legata alla curatela sembra soppressa faccio il possibile per produrre progetti aperti con artisti dialoganti come nel caso di Jonathan Monk e Marinella Senatore».

Puoi anticipare il tema della mostra di Marinella Senatore?
«La mostra di Marinella dovrebbe aprire a marzo 2024 e sarà la sua prima personale in Israele. Il titolo è A Blend of Common Humanity e sarà un’occasione per dare spazio a diversi lati della società israeliana. Presenteremo per le strade di Tel Aviv e Giaffa una nuova versione della SOND, la sigla (SOND sta per School of Narrative Dance, scuola di danza narrativa) che definisce le sue parate-processioni con individui e membri di diverse comunità legate alla musica e alla danza, ma non solo; presenteremo inoltre una nuova serie di stendardi, con slogan in inglese, ebraico, arabo e tigrino, fatti in situ da individui e comunità come Kuchinate, un collettivo di donne africane richiedenti asilo; Rawan Jabarin, artista palestinese; e le studentesse del dipartimento di design tessile del Shenkar College di Ingegneria, Design e Arte; faremo anche diverse attività educative, come una masterclass con gli studenti dell’Accademia Bezalel, grazie al Rywkind Ben Zour Grant for Art, Education and Community, tra i sostenitori di questo bellissimo progetto insieme all’Italian Council (XII edizione) e all’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv. Poi, se tutto va bene, il che significa niente allarmi, vorremo portare dall’Italia la luminaria A Blend of Common Humanity.
Per me è importante, quando è possibile, che gli artisti stranieri interagiscano con la società israeliana e con le sue unicità, senza una ricetta prestabilita; penso sia più interessante e stimolante produrre le opere qua piuttosto che pagare per spedire cose prodotte altrove. Gli stendardi sono un ottimo esempio mentre se con Jonathan Monk la sfida fu trovare opere di artisti da lui amati, perlopiù stranieri, da Piero Gilardi a Louise Lawler, da Michelangelo Pistoletto a Allan McCollum, in collezioni private a Tel Aviv e dintorni, con Augustas Serapinas si trattò di capire a quale membro del mio staff il suo progetto si sarebbe ispirato; con Irma Blank, tedesca trapiantata in Italia, fu il Bauhaus a Tel Aviv».

Qual è la visione che hai per il futuro di CCA?
«CCA non è un’istituzione che mira ad espandersi, nella mia visione vorrei semplicemente consolidare ciò che c’è già, rimanendo un’istituzione piccola, agile, con budget limitati ma facili da erogare, senza burocrazia; se avessi più soldi non amplierei il mio staff ma lo terrei com’è ora pagandolo meglio, non vorrei gallerie e uffici più spaziose ma ristrutturerei quelle che ho adesso. Di sicuro farò di tutto per mantenere la nostra visione che vede la presentazione di artisti viventi nati in Israele, che vivono in Israele e artisti stranieri, senza filtri e senza sconti. Se possibile, vorrei dare più spazio agli artisti palestinesi nati e cresciuti in Israele, come ho fatto con Sharif Waked e Karam Natour, che si è da poco trasferito in Italia. È importante far capire che Israele è costituita da tante voci ed è essenziale che questo emerga, soprattutto nel conteso artistico».