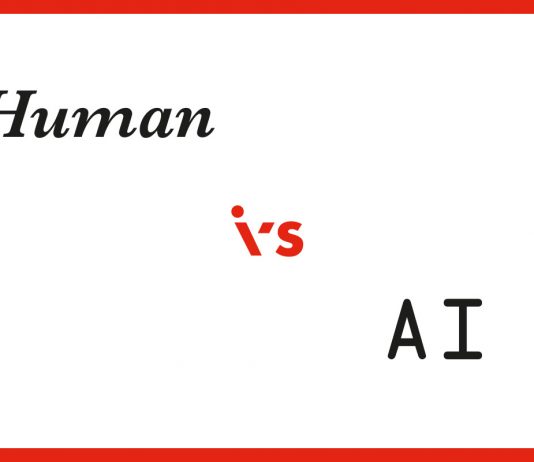-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
Ciò che noi europei abbiamo sempre invidiato ai musei americani sono le cospicue donazioni provenienti da privati a fronte di un esiguo finanziamento statale. È esattamente il contrario da noi dove la maggior parte dei musei è pubblica, finanziata (seppur con poche risorse) dallo Stato e i soggetti privati e/o aziende preferiscono aprire le proprie fondazioni che portano il loro nome o il nome dei propri brand. In qualche caso usufruendo loro stessi di fondi pubblici per lo più europei.
Spesso negli USA quegli stessi supporter risiedono nei prestigiosi CDA delle istituzioni. Non è inusuale, nel visitare un museo americano, accedere ad alcune sale, o a interi piani, e vedere la targa dei “donors” in bella vista. Di recente il caso di Leon Black, finanziere legato a Jeffrey Epstein — condannato per reati sessuali e traffico internazionale di minorenni — che, sotto pressioni su più fronti (artisti, operatori dell’arte, attivisti) si è dimesso dalla carica di presidente del MoMA di New York, ha dato il via a un dibattito, che però, con forme diverse, ha radici lontane.
Venerdì scorso, alcuni manifestanti, organizzati da un gruppo chiamato International Imagination of Anti-National Anti-Imperialist Feelings, hanno sfilato in segno di protesta da Columbus Circle fino ad arrivare di fronte al MoMA, cercando di forzare l’accesso, per chiedere, in maniera radicale, di eliminare la filantropia privata al museo. Gli stessi organizzatori di quello che è stato ribattezzato Strike MoMA hanno scritto al direttore del museo Glenn Lowry — si legge sulle pagine del “Guardian” — definendo l’istituzione “un sistema di potere e ricchezza che danneggia le persone”. Su uno dei cartelli mostrati durante la manifestazione c’era scritto “Questa è una de-occupazione di uno spazio pubblico di proprietà privata” e uno degli organizzatori di nome Amin Husain ha affermato: “Vogliamo rilevare queste istituzioni. Non appartengono agli oligarchi”. Lo stesso Husain aveva in precedenza contribuito a organizzare nove settimane di protesta al Whitney Museum, conclusesi con le dimissioni di un membro veterano del consiglio, un certo Warren B. Kanders, perché secondo quanto ha scritto il “The New York Times”, “gli attivisti sostenevano non fosse idoneo a servire come trustee perché la sua società, la Safariland Group, aveva venduto forniture per forze dell’ordine e militari, inclusi gas lacrimogeni”.

Il dibattito oltreoceano è acceso e sta facendo il giro del mondo, soprattutto all’interno del piccolo ma globale sistema dell’arte internazionale. Anche perché a questo si aggiunge la questione intorno all’opportunità, sempre negli Stati Uniti, di vendere o meno opere delle proprie collezioni per mantenere il personale, sostenere le spese e finanziare programmi, dopo le enormi perdite del lungo blocco a causa della pandemia. I biglietti d’ingresso ai musei americani sono spesso piuttosto salati. Un biglietto intero per entrare al Whitney ammonta a 25 dollari.
Questo “sciopero” ha sollevato numerose questioni. In un modello consolidato (da una donazione iniziale di otto stampe e un disegno nel 1929, il numero delle opere nella collezione del MoMA ammonta oggi a 200 mila) per cui un museo ha visto crescere e arricchire le proprie collezioni, organizzare mostre importanti grazie quasi esclusivamente alla filantropia privata ha senso auspicare l’interruzione di quel supporto, sostanzialmente vitale? No. Esistono finanziatori di serie A e di serie B? Sì. È compito degli amministratori dei musei assicurarsi da chi provengano i finanziamenti. Facciamo un esempio concreto. Se un’azienda è sensibile all’ambiente, adotta politiche di salvaguardia delle risorse e ha un approccio “green” alla produzione e al suo sviluppo rientra nella serie A.
Se un’azienda produce armi, alimenta guerre, sfrutta il lavoro minorile, ha una politica di gestione del personale discriminante verso razza e/o genere, ricicla denaro sporco, occulta ingenti capitali nei paradisi fiscali… non può che essere considerata di serie B. Alcuni artisti, come Hito Steyerl, Michael Rakowitz o Nan Goldin, hanno recentemente sollevato la questione. Andrea Fraser, anni fa, in un atto di critica radicale, ha fatto un accordo con la sua galleria e ha deciso che le sue opere possono essere vendute solo a musei pubblici e non a collezionisti privati. Fraser ha anche scosso il sistema del mercato realizzando una performance controversa in cui offriva sesso per un’ora a un collezionista in una stanza d’hotel. La “performance” è stata ripresa ed è diventata un video, poi esposto al pubblico.

Ma tornando alla questione del finanziamento privato incondizionato o eticamente consapevole ai musei, alla luce di quanto sta succedendo, c’è un altro fattore che non dovrebbe essere sottovalutato. Sebbene l’arte contemporanea sia generalmente disinteressata alla politica, a parte rari e autentici casi di artisti o curatori che lavorano attivamente nel sociale, quando un artista riceve una commissione da parte di un finanziatore privato — lo stesso vale per un curatore nell’organizzare mostre — non dovrebbe accertarsi su chi lo sta finanziando? Lo sciopero del MoMA è emblematico perché avviene in un momento storico in cui in tutto il mondo si sta cominciando a mettere in questione il modello capitalista che vede ormai la forbice tra i sempre più ricchi e i sempre più poveri allargarsi enormemente. Jason Hickel, antropologo della Goldsmiths University of London, collaboratore del “Guardian” e di Al Jazeera, ha pubblicato di recente il volume Siamo ancora in tempo! (in Italia per il Saggiatore) in cui immagina modelli alternativi, assolutamente perseguibili, per un’economia post-capitalista.
Nel 2017 un giovane studente americano, Trevor Hill, in un dibattito TV sulla CNN, ha fatto una domanda molto diretta a Nancy Pelosi, a quel tempo leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il ragazzo sottolineava che secondo alcuni sondaggi autorevoli le nuove generazioni, dai 18 al 29 anni, pensano a un modello alternativo e mettono in discussione il concetto di capitalismo, e chiedeva quale fosse la posizione dei Democratici. La risposta, non senza qualche imbarazzo, è stata altrettanto chiara. Pelosi ha esordito dicendo “siamo capitalisti, è così e basta”, ma poi ha parlato del capitalismo degli stakeholder. E di quanto sia aumentata la disparità negli ultimi vent’anni fra CEO delle aziende, azionisti, e lavoratori. L’arte, gli artisti, gli addetti ai lavori non possono più esimersi da questioni urgenti che riguardano il pianeta, il nostro futuro e quello delle nuove generazioni. È arrivato il momento di mettere in discussione e rivedere certi modelli e cominciare, ad esempio, a fare la differenza tra finanziatori di serie A e finanziatori di serie B. Il modello “whatever it comes è cosa buona e giusta” non è più condivisibile!