Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
14
febbraio 2014
Nei primi giorni di quest’anno ho riportato Giulia, mia figlia di 11 anni, a L’Aquila. C’eravamo stati alla fine del 2010 con Giuseppe Stampone. L’impressione di quella visita fu enorme per tutti noi. Giulia naturalmente si spaventò per la possibilità che il terremoto potesse avvenire anche da noi a Roma, e che la nostra casa potesse finire allo stesso modo. Noi, oltre ciò, oltre ad accusare la terribilità della potenza della natura, oltre la pena per i morti, eravamo ancora più spaventati dal nostro stesso Paese (da noi stessi) che aveva(mo) abbandonato a se stessa una città, anzi che l’aveva(mo) e l’avrebbe(mmo) cannibalizzata con un cinismo impressionante.

Ricordo bene il silenzio e la rabbia che mi saliva dentro, e non so dire quale delle due cose mi fece più impressione. Camminavamo e Stampone, abruzzese di Teramo, che aveva passato nottate in macchina durante quei giorni, ci raccontava di quando era in Accademia, della vita che aveva vissuto in quelle strade. A me, mentre ascoltavo e guardavo, tornavano alla mente le immagini e le angosce del 1980, di mio padre che corse all’alba a Caserta e che al ritorno ci raccontò la necessità di quel “fate presto” con gli occhi velati di lacrime. Con Stampone cominciammo da subito a ragionare e a parlare: – Qualcosa dobbiamo fare. Dobbiamo dire, far vedere… Lo so, tutti sanno, il G8, le promesse, le new town, le pentole in cucina, gli psicofarmaci e i suicidi, ma comunque dobbiamo aggiungere, far vedere, dire ancora e cercare di rendere inequivocabile… Dobbiamo.
Due giorni e qualche pezzo di notte portarono alla definizione del progetto “Saluti da L’Aquila”: libro, sito web, foto, cartoline con le immagini della città abbandonata, silenziosa, vuota, ingabbiata nel legno e nel ferro, spedite a tutti i potenti del pianeta. Una di quelle cose che non sai bene come riuscirai a fare, ma che ti cresce sotto le mani e che concludi mentre ancora ti stai domandando come.
Giulia mi dice mentre camminiamo di nuovo quattro anni dopo per l’Aquila, stavolta fuori dalla zona vietata: – Babbo, ma è uguale all’altra volta. Non hanno fatto niente. Dove vivono tutti? Dove vanno a scuola i bambini?
– Credo che qui non vivrà più nessuno.

Quando Stampone mi ha mostrato il video Saluti da L’Aquila 5 anni dopo, mi è sembrato chiaro che ormai sia lui che tutti noi avevamo trasformato L’Aquila nel simbolo perfetto (e lo so che la parola sembra inadeguata) dell’Italia di questi anni, qualcosa che era l’esemplificazione di uno stato delle cose molto più ampio e per molti versi non meno tragico. Il video inizia carico di promesse, impeccabile nell’intro Paramount in alta definizione con le stelle che sfiorano l’acqua e vanno ad incoronare la montagna, il grande sasso. E anche se sai che tanta artificiale perfezione durerà poco, non ti aspetti comunque quel buio che arriva all’improvviso, quel nero accompagnato da un suono bianco che per ventitré secondi, gli stessi della durata della scossa principale e micidiale, ti lascia sospeso (ma che succede?). E poi l’elenco dei protagonisti che scorre, che traccia il solco fondo e definitivo dell’accaduto e della responsabilità che non ha scadenza. Questo video di Stampone è inesorabile, fa collidere dolore e rabbia in un rigurgito interiore muto che ti lascia solo un sapore ferroso nella bocca sabbiosa. L’Aquila è diventata un simbolo, e precisamente è il simbolo dell’inganno che tutti noi abbiamo subito, non esentandoci naturalmente dall’avervi partecipato e contribuito. Perché bisogna ormai e senza pudori riconoscere che l’inganno è qualcosa che ha deciso la nostra cultura degli ultimi venti, trent’anni, e che per la precisione ha preso inizio nella prima metà degli anni Ottanta nell’inedito studio televisivo di Drive In, insinuandosi nel quotidiano casalingo con la richiesta del numero esatto dei fagioli contenuti nel barattolo di vetro. Immagini e condizioni di falsificazione riconosciuta ma accettata, che hanno avuto la forza di rimodellare la realtà sui parametri dell’inganno come modalità necessaria del vivere moderno, inteso senza prefissi. Dobbiamo riconoscere che il nostro Paese corrisponde sempre più al corpo sul tavolo autoptico dello scienziato Debord: «Nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso» (G. Debord, La società dello spettacolo, 1967).

Da questa pratica dell’inganno come condizione culturale, e naturalmente esistenziale, è derivata quella sistematica mistificazione alla quale abbiamo assistito e partecipato, nonché subito, in questi decenni in Italia, passando per stragi senza colpevoli, depistamenti, corruzione e accordi inconfessabili. Qualcosa che non subì alcun perturbamento di fronte al terribile “Io so” di Pasolini del 1974, e che oscenamente invece trovò spazio e autentica persino negli atti parlamentari, quando nel 1993 Craxi tentò di salvarsi almeno dal giudizio della storia rivelando l’inganno in cui tutti erano. Un passaggio a vuoto, quest’ultimo, che rese paradossalmente ancora meno negoziabile la necessità dell’inganno nel nostro paese e che naturalmente raggiunse l’apoteosi nel ventennio berlusconiano, di cui L’Aquila appunto rappresenta il drammatico e ultimo capolavoro. La parola che più mi spaventa tra le ultime non è capolavoro, che pure è causa di un certo fastidio, ma quella precedente e cioè ultimo. La scrivo con malcelata speranza, ovviamente, perché sono consapevole che la questione è tutt’altro che in questi termini. Il rischio infatti è che da ventennio si sia costretti a parlare di venticinquennio o addirittura che si giunga ad un raddoppio, quarantennio o cinquantennio che sia, grazie al subentro dei nuovi e raffinati interpreti dell’inganno plastificato in veste aggiornata da fiction. “Che fare?” dice ancora il neon acceso, facendo dell’interrogativo di Lenin l’epigrafe di un’epoca che ha attraversato la soglia del secolo. Quello che penso con Stampone è che prima di tutto è necessario riconoscere la realtà, l’evidenza della sua verità, e condividerla. E L’Aquila è oggi l’esempio della nostra realtà, così come lo sono le terre contaminate del casertano o anche gli operai cassintegrati, le carceri sovraffollate e il controllo del territorio e dell’economia da parte delle mafie. Un elenco di fatti, di esempi, che per quanto saranno “fictionati”, rimarranno ben presenti nella nostra realtà, diventandone addirittura l’emblema, appunto il simbolo dell’inganno. E questi sono gli inevitabili e più ampi saluti dall’Italia di oggi.





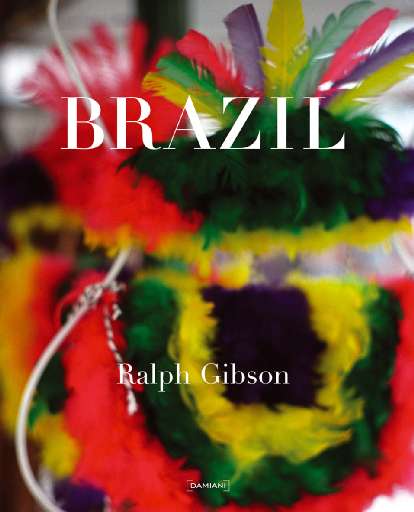

















Salve, trovo l’articolo interessante, fino al penultimo capoverso sono anche d’accordo, mi è piaciuta la descrizione dell’opera e il racconto della nascita del progetto “Saluti dall’Aquila”,la descrizione e il ricordo poi di una città distrutta…..
Non trovo però poi il nesso,di tutto ciò con Berlusconi,,,perchè non facciamo il parallelismo di ciò che succede a Roma o nel mondo dell’arte dove “lavorano” e manovrano sempre i soliti pochi ma non buoni.??Perchè non diciamo che il sindaco dell’Aquila non si sà che cosa abbia combinato e quante volte ha minacciato di dare e ritirare le dimissioni da sindaco? Perchè non parliamo della Melandri?Perchè non diciamo che sono ormai tre anni che non abbiamo un governo legittimato dal popolo, la cosìdetta DEMOCRAZIA? Non mi pare che Renzi sia come Berlusconi…poichè ROnzie non è stato votato da nessuno mr.B è stato voluto dagli italiani…
Voi radical chic romani di sinistra o presunta tale è predicate bene ma razzolate malissimo…