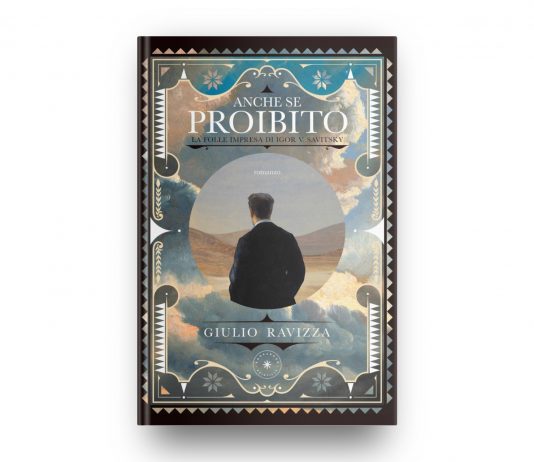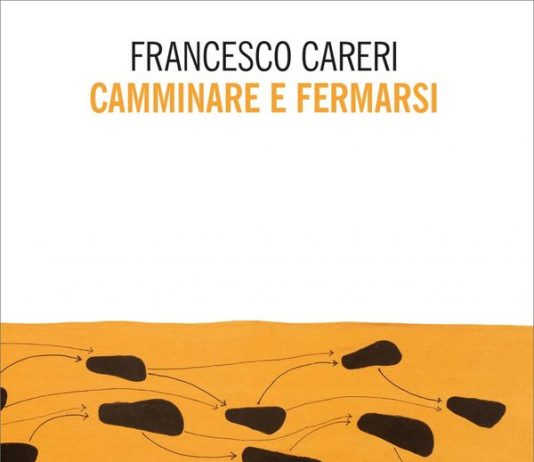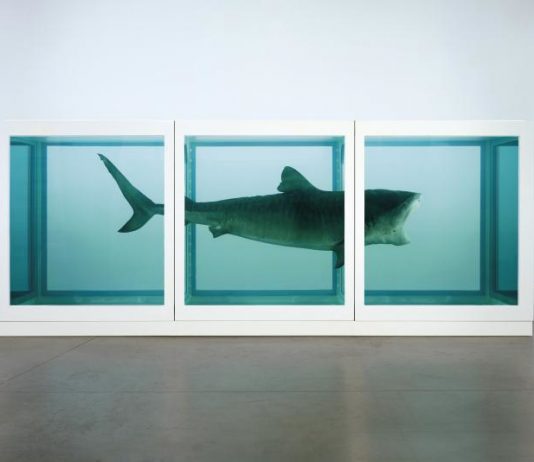-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
Conversazione con Lina Pallotta, la fotografa dell’attivista trans Porpora Marcasciano
Libri ed editoria
Porpora era il colore delle vesti dei senatori romani, dei sovrani bizantini e dei cardinali. Di tutti loro indicava la dignità, l’alto ruolo che stavano a rappresentare, l’importanza della funzione pubblica. Porpora Marcasciano, dunque, quella dignità che spesso hanno cercato di toglierle se la porta stampata addosso, e il trentennale racconto fotografico realizzato da Lina Pallotta ne è la puntuale e accurata riprova. Quel racconto nel 2023 si è fatto libro (Porpora, Nero Edizioni) e progetto espositivo (Volevo vedermi negli occhi, Centro Pecci, a cura di Michele Bertolino ed Elena Magini), per narrare la lotta, la quotidianità, le amicizie della storica attivista trans, presidente del MIT (Movimento Identità Trans) fino al 2016 e consigliera comunale per le pari opportunità di Bologna.
Il rapporto tra Porpora Marcasciano e Lina Pallotta è in primo luogo quello di un’amicizia di vecchia data e successivamente quello di un sodalizio artistico che dura ancora oggi, forte dello scambio umano prima ancora che di quello intellettuale. Alla base del “Progetto Porpora” sta la voglia del soggetto di raccontarsi attraverso la lente fidata di un’amica e l’intento dell’artista di assecondare quel racconto, scegliendo di diventarne interprete e custode privilegiata. Si è parlato di politica, di corpi e di diritti in conversazione con Lina Pallotta nel quartiere Pigneto di Roma, dove l’artista vive e lavora.

Tu conosci Porpora a Napoli negli anni Settanta. Ci parli delle lotte che vi unirono in quel periodo? Che anni erano?
Erano per entrambe gli anni del movimento studentesco, un movimento ampio che partiva dall’università per poi avere delle specificità, nel nostro caso del femminismo. Naturalmente a quel tempo la definizione dei diritti trans era ancora agli esordi, quindi per Porpora la scelta di militanza nel mondo LGBTQIA+ si è delineata in un secondo momento. È difficile paragonare quel movimento a quello di oggi perché all’epoca c’era una componente marxista molto forte e, in generale, una concentrazione di direttive molto più legate alle ideologie. Oggi invece ci sono movimenti più specifici, concentrati per esempio sull’ecologismo, sul transfemminismo: questa è stata un’evoluzione successiva.
Da donna che ha lottato in tempi molto diversi dagli attuali, ritieni che le manifestazioni, i cortei, le proteste che ci sono oggi – in particolare penso all’ondata alzatasi dopo la morte di Giulia Cecchettin – sono in qualche modo simili a quelle cui hai partecipato? C’è qualcosa che manca alle nuove generazioni oppure, al contrario, queste hanno qualcosa che i manifestanti del passato non avevano?
Io sono una delle poche della mia generazione a dare molta fiducia ai movimenti di oggi. Essendo anche insegnante, ho un rapporto diretto con i giovani e, pur notando in loro una generale mancanza di critica, nelle situazioni in cui riconosco una loro consapevolezza nei confronti del sistema, ripongo grande fiducia in queste ondate, che analizzano e articolano molto bene le varie istanze. Forse quando ero giovane c’erano degli eccessi, nel senso che erano tutti “contro”, il che a volte si traduceva in atteggiamenti superficiali. Una grande diversità sta naturalmente negli strumenti: oggi i social, nonostante io sia cosciente dei danni che possono provocare, sono estremamente importanti – basti pensare per esempio alle Primavere arabe –.

Parlando del “Progetto Porpora”, le tue fotografie sono estremamente intime e personali. Mi chiedevo se il forte legame che condividi con il soggetto ha mai rappresentato per te un ostacolo, un “bagaglio emotivo” difficile da gestire.
No, anzi, è stato l’opposto. La libertà che il rapporto con Porpora mi concedeva – dal momento che Porpora non mi ha mai posto limiti – l’ho sempre vista come un’agevolazione. Sicuramente ha influito anche il mio approccio fotografico: a me non interessa l’oggettività, che è distanza, ma muovermi in un terreno emozionale fatto di spontaneità, con tutti i limiti del caso perché la spontaneità non è sempre necessariamente positiva. C’è un confine che tutti ci portiamo addosso.
La dimensione corporea di questi scatti è molto forte e pronunciata. Il tuo occhio cerca qualcosa di diverso quando fotografa il corpo di Porpora rispetto a quando, per esempio, ne esegue dei ritratti?
Il mio modo di fotografare Porpora non è mai molto cosciente, la dimensione in cui mi muovo è quella di sospensione del pensiero, direi che il pensiero diventa parte del mio inconscio, quasi. Il discorso sulla corporeità per Porpora è ovviamente centrale. Non serve parlare di “teoria del corpo” perché è il corpo stesso che si svela quotidianamente, e il corpo trans porta sempre in sé dei segni. Il “Progetto Porpora” è stato esposto in mostra al Centro Pecci di Prato, dove le foto sono molto grandi e poste al centro dello spazio con strutture autoreggenti, una foto per lato: sono corpi che vivono una solidarietà tra loro, non sono isolati. Possono essere apparentemente sconnessi, ma la comunità in qualche maniera c’è, insieme alla riconoscibilità e a momenti di scambio e comunione.

Volevo vedermi negli occhi è il titolo della mostra al Centro Pecci di Prato. Chi pronuncia questa frase? Tu o Porpora? L’artista o il soggetto?
È una frase reinterpretata da una poesia di Kae Tempest, non c’entra Porpora direttamente. Sono arrivata a questa soluzione dopo essermi confrontata molto col curatore, Michele Bertolino. Il titolo nasce dal mio modo di fotografare: cercare delle connessioni emozionali con le persone. Se c’è una connessione significa che c’è qualcosa di te in quello che vedi. Inoltre è una storia lunghissima quella che ho fotografato, quindi questi scatti rappresentano sicuramente un atto di rivedersi attraverso i percorsi di vita. C’è da dire poi che il confronto con il curatore mi ha aiutato a mettere a fuoco tutto il progetto, ed è stato per me essenziale perché fino a quel momento era più simile a un soliloquio: lo scambio con Porpora non è mai stato nello specifico sugli scatti, si parlava in generale della mia fotografia, del suo scrivere e del suo attivismo.
Più volte hai rimarcato come la sfera personale di Porpora sia inscindibilmente legata a quella collettiva e politica. Non credi che “portarsi addosso la politica” possa talvolta essere vissuto come un peso? Lottare per ottenere i diritti più basilari toglie il diritto a rivendicare una sfera personale che non appartiene a nessun altro? È il caso di Porpora?
Io vengo dalla teoria del femminismo degli anni Settanta, per cui il personale è politico, perché nasce dalla critica di una dimensione femminile che è stata sempre giocata nel privato. Tirare fuori il personale non significa tirare fuori la specificità di un individuo. Io penso che più cose si inseriscono nel discorso pubblico, più si allarga la comprensione dei diritti. Porpora rappresenta una dimensione politica in quanto soggettività, non in quanto soggetto fotografico. Le persone trans, inoltre, appartengono a una categoria che secondo me, il più delle volte, viene risolta con narrative di spettacolo o di strada. Invece deve esserci una dimensione che comprenda la quotidianità, la dignità e i bisogni affettivi. Non voglio fare vampirismo sulle tragedie, però l’hai menzionata tu Giulia: quella è una dimensione privata che dovrebbe essere sempre pubblica, nel senso che si dovrebbe avere la forza di tirarla fuori per chiedere aiuto.

A proposito di quotidianità e autenticità, si parla molto oggi dell’importanza di definirsi – nella propria identità e nella propria sessualità – attraverso una serie di termini che prima non si usavano. Questo innervosisce molte persone oggi, secondo te perché?
Sicuramente c’è un eccesso di terminologia che, per chi non ha familiarità con questi discorsi, può creare smarrimento. Ad ogni modo è la comunità che decide queste cose, non le possiamo decidere noi. Penso che queste siano problematiche molto giovani anche se sembrano durare da anni, ma la storia è molto più lenta: partiamo da secoli di patriarcato in cui il linguaggio binario era l’unico possibile. L’unica convinzione che mi sento di condividere è che c’è un fuggire la propria messa in discussione, perché i nuovi termini mettono in discussione il binarismo. Sento molti uomini dire che le donne stanno bene, eppure io ho letto per la prima volta sui giornali critiche al concetto di patriarcato solo dopo la morte di Giulia. C’è ancora gente che dice che il patriarcato non esiste. Diventa quasi normale che qualcuno dica “cosa sono questi termini basati sul nulla?”, così si evita di andare in profondità della comprensione di secoli di abuso.
Nel 2023 è uscito con Nero Edizioni il libro Porpora che contiene circa 100 dei tuoi scatti. Considerando che il progetto inizia negli anni Novanta, questo catalogo rappresenta circa trent’anni di vita: possiamo considerarlo una sorta di punto d’arrivo di questo percorso artistico? Cosa le ha dato, in termini sia umani che professionali, questo progetto così intenso?
In termini umani ovviamente tantissimo. In questo progetto, più che in altri, ci sono degli elementi essenziali della mia filosofia di fotografa. Sicuramente è un punto d’arrivo, insieme alla mostra al Centro Pecci, ma devo dire che non so se il progetto è da considerarsi finito, perché io continuo a fotografare Porpora. Vorrei specificare che per me questo non è un lavoro sulla transessualità, e che questo libro non ha un intento di editorializzare quella condizione, sono le figure interne a doverla commentare, mentre io, da esterna, non ritengo di avere i mezzi o la percezione giusta. Un lavoro così lungo automaticamente mette in ballo la temporalità, lo scorrere del tempo, che è un concetto su cui la mia fotografia si è sempre concentrata poco. Ho imparato ad avere pazienza – che non è la mia qualità più rilevante – nel senso che le cose poi col tempo possono prendere delle forme inaspettate e maturare.