Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
22
novembre 2007
libri_presentazioni Lo spazio e la sua disciplina (electa 2007)
Libri ed editoria
Mentre al capitolino Palazzo delle Esposizioni è di scena la grande retrospettiva di Mark Rothko, per i tipi di Electa esce la prima monografia italiana dedicata al pittore americano. A presentarcela è l’autore del libro...
Difficile dimenticare il momento in cui ho sentito la necessità di scrivere un lavoro organico sull’opera di Mark Rothko: rileggendo ovvero il modo in cui l’artista veniva presentato al pubblico italiano in occasione della sua retrospettiva a Roma nel 1962. Vi si leggeva che, davanti ai suoi dipinti, la presenza dell’uomo nella realtà è “supremo equilibrio, calma infinita”; che lo spazio “rientra nell’unità, nella imperturbabile calma dell’essere” ed è immenso “come il cielo d’una notte estiva”; che il colore “ha bisogno delle grandi e tranquille distese, delle distanze infinite del passato e del futuro” e così via. Come conciliare questa omelia poetico-pagana –affatto isolata nel panorama nazionale– con il fatto che Rothko, pochi anni prima, credeva di essere il fautore della pittura più violenta d’America?
Scrivere in Italia di arte contemporanea è del resto stato –e in parte lo è ancora– un’attività serale, da fare con la mano sinistra: di giorno uno studio sui pittori senesi del Trecento, di notte un articolo su Burri. È per questo che, a indirizzare le mie ricerche, sono stati due autori lontani dalla galassia degli storici dell’arte: il poeta Emilio Villa e il regista Michelangelo Antonioni. In un periodo in cui si disquisiva sulle squisitezze degli accostamenti cromatici delle sue tele, Antonioni scriveva una lettera all’artista in cui parlava, singolarmente, dell’acciaio di New York, di panico e di angoscia, di “quadri fatti di niente” o di “quadri sul niente”. Del resto, quando Rothko penetrò nel vestibolo della biblioteca Laurenziana di Michelangelo a Firenze, provò un senso di imprigionamento, di oppressione e di claustrofobia. Sono le stesse reazioni suscitate dalle sue opere, con quelle più grandi installate negli spazi più angusti, in modo da saturare lo spazio espositivo, annullare ogni distanza tra le loro superfici e gli spettatori, far perdere ogni senso della distanza e ogni possibilità d’evasione.
Tener fede a queste indicazioni è diventata per me una priorità, soprattutto oggi che le rare occasioni di vedere il lavoro di Rothko remano nella direzione opposta: grandi spazi ristrutturati, dipinti isolati, illuminazioni drammatiche, disposizione cronologica (un uomo, un artista, un’opera) secondo la logica più classica del capolavoro. Ho articolato così il materiale di questa monografia critica come si trattasse di una retrospettiva ideale quanto immaginaria del suo lavoro, servendomi di tre addensatori concettuali, ovvero di tre percorsi tematici più che cronologici, concentrici più che lineari: “spazio-plasticità”, “spazio-parete” e “spazio-esperienza”.
Ho articolato così il materiale di questa monografia critica come si trattasse di una retrospettiva ideale quanto immaginaria del suo lavoro, servendomi di tre addensatori concettuali, ovvero di tre percorsi tematici più che cronologici, concentrici più che lineari: “spazio-plasticità”, “spazio-parete” e “spazio-esperienza”.
Sinteticamente, per la pars destruens, ho evitato di: incedere sulla bellezza magnetica che le opere di Rothko suscitano ma che è paralizzante e, in definitiva, fuorviante; limitarmi alle opere classiche, dileguando quanto le precede –la metà della sua produzione complessiva– come una premessa disorganica. Ho provato inoltre a evitare di considerare la fase classica come un blocco indivisibile, secondo l’idea che l’artista avrebbe dipinto sempre la stessa opera, variazioni di un tema che resta tuttavia sconosciuto; considerare le Multiforms, secondo una lettura evolutiva, come opere di transizione, presto riassorbite dalle distese di colore, quando si tratta di un tentativo tra i più radicali dell’epoca di liberarsi da ogni associazione, narrazione, disegno preparatorio, composizione e riferimento al mondo esterno; leggere gli eventi biografici dell’artista (leggasi suicidio) attraverso gli scuri cromatismi delle sue opere, fedele all’idea che l’esperienza si consuma tra il quadro e l’osservatore e non tra l’artista e l’osservatore.
Al contrario, mi è sembrato più vantaggioso insistere sulla dimensione arcaica della mitologia, di cui Rothko sottolinea non l’aspetto apollineo ma il lato oscuro, illogico e feroce, brutale e bestiale; sulle diverse strategie di “ridurre in polvere l’identità familiare delle cose”; sul dispositivo (un termine che non mi stanco di utilizzare) spaziale e scenografico messo in atto dalle opere in serie, nonché sugli accorgimenti espositivi che combattono la tradizione della pittura da cavalletto e l’istituzione museale; sulla capacità di creare spazi, insistendo sulla sequenza piuttosto che sulla presenza delle opere, contro il mito della singolarità del dipinto. Ho inoltre insistito sulla disciplina che l’artista si è auto-imposto, circoscrivendo la pittura a pochi elementi e articolandoli in modo inesauribile, ma anche sulla disciplina dello sguardo esercitata sullo spettatore e sul suo inevitabile aspetto coercitivo; sull’accecamento e l’oscurità piuttosto che sulla visione e la vigilanza, propri alle opere mature; sulla tattilità e la plasticità delle superfici piuttosto che sulla loro impalpabile diafanità, spostando così l’asse dall’otticalità alla gravità; sul dialogo con artisti quali Barnett Newman, nei cui scritti ho spesso trovato le risposte alle domande sollevate dai dipinti di Rothko; sulla dibattuta eredità della sua opera negli anni ‘60, su cui non è stata ancora scritta la parola definitiva.
Ho inoltre insistito sulla disciplina che l’artista si è auto-imposto, circoscrivendo la pittura a pochi elementi e articolandoli in modo inesauribile, ma anche sulla disciplina dello sguardo esercitata sullo spettatore e sul suo inevitabile aspetto coercitivo; sull’accecamento e l’oscurità piuttosto che sulla visione e la vigilanza, propri alle opere mature; sulla tattilità e la plasticità delle superfici piuttosto che sulla loro impalpabile diafanità, spostando così l’asse dall’otticalità alla gravità; sul dialogo con artisti quali Barnett Newman, nei cui scritti ho spesso trovato le risposte alle domande sollevate dai dipinti di Rothko; sulla dibattuta eredità della sua opera negli anni ‘60, su cui non è stata ancora scritta la parola definitiva.
Mi sono insomma sforzato di capire come funzionano le opere di Rothko, convinto che i suoi siano meno dipinti di qualcosa che dipinti indirizzati a qualcuno, meno raffigurazioni di scene drammatiche che ricreazione delle stesse condizioni tra l’artista e lo spettatore, meno la resa di un’esperienza che un’esperienza à part entière. Ma non posso nascondere la speranza che queste pagine possano, nel loro piccolo, contribuire a rilanciare in Italia un modo militante e rigoroso, esclusivo e non sussidiario di esercitare la critica d’arte contemporanea. In questo senso, il lavoro da compiere è enorme.
Scrivere in Italia di arte contemporanea è del resto stato –e in parte lo è ancora– un’attività serale, da fare con la mano sinistra: di giorno uno studio sui pittori senesi del Trecento, di notte un articolo su Burri. È per questo che, a indirizzare le mie ricerche, sono stati due autori lontani dalla galassia degli storici dell’arte: il poeta Emilio Villa e il regista Michelangelo Antonioni. In un periodo in cui si disquisiva sulle squisitezze degli accostamenti cromatici delle sue tele, Antonioni scriveva una lettera all’artista in cui parlava, singolarmente, dell’acciaio di New York, di panico e di angoscia, di “quadri fatti di niente” o di “quadri sul niente”. Del resto, quando Rothko penetrò nel vestibolo della biblioteca Laurenziana di Michelangelo a Firenze, provò un senso di imprigionamento, di oppressione e di claustrofobia. Sono le stesse reazioni suscitate dalle sue opere, con quelle più grandi installate negli spazi più angusti, in modo da saturare lo spazio espositivo, annullare ogni distanza tra le loro superfici e gli spettatori, far perdere ogni senso della distanza e ogni possibilità d’evasione.
Tener fede a queste indicazioni è diventata per me una priorità, soprattutto oggi che le rare occasioni di vedere il lavoro di Rothko remano nella direzione opposta: grandi spazi ristrutturati, dipinti isolati, illuminazioni drammatiche, disposizione cronologica (un uomo, un artista, un’opera) secondo la logica più classica del capolavoro.
 Ho articolato così il materiale di questa monografia critica come si trattasse di una retrospettiva ideale quanto immaginaria del suo lavoro, servendomi di tre addensatori concettuali, ovvero di tre percorsi tematici più che cronologici, concentrici più che lineari: “spazio-plasticità”, “spazio-parete” e “spazio-esperienza”.
Ho articolato così il materiale di questa monografia critica come si trattasse di una retrospettiva ideale quanto immaginaria del suo lavoro, servendomi di tre addensatori concettuali, ovvero di tre percorsi tematici più che cronologici, concentrici più che lineari: “spazio-plasticità”, “spazio-parete” e “spazio-esperienza”. Sinteticamente, per la pars destruens, ho evitato di: incedere sulla bellezza magnetica che le opere di Rothko suscitano ma che è paralizzante e, in definitiva, fuorviante; limitarmi alle opere classiche, dileguando quanto le precede –la metà della sua produzione complessiva– come una premessa disorganica. Ho provato inoltre a evitare di considerare la fase classica come un blocco indivisibile, secondo l’idea che l’artista avrebbe dipinto sempre la stessa opera, variazioni di un tema che resta tuttavia sconosciuto; considerare le Multiforms, secondo una lettura evolutiva, come opere di transizione, presto riassorbite dalle distese di colore, quando si tratta di un tentativo tra i più radicali dell’epoca di liberarsi da ogni associazione, narrazione, disegno preparatorio, composizione e riferimento al mondo esterno; leggere gli eventi biografici dell’artista (leggasi suicidio) attraverso gli scuri cromatismi delle sue opere, fedele all’idea che l’esperienza si consuma tra il quadro e l’osservatore e non tra l’artista e l’osservatore.
Al contrario, mi è sembrato più vantaggioso insistere sulla dimensione arcaica della mitologia, di cui Rothko sottolinea non l’aspetto apollineo ma il lato oscuro, illogico e feroce, brutale e bestiale; sulle diverse strategie di “ridurre in polvere l’identità familiare delle cose”; sul dispositivo (un termine che non mi stanco di utilizzare) spaziale e scenografico messo in atto dalle opere in serie, nonché sugli accorgimenti espositivi che combattono la tradizione della pittura da cavalletto e l’istituzione museale; sulla capacità di creare spazi, insistendo sulla sequenza piuttosto che sulla presenza delle opere, contro il mito della singolarità del dipinto.
 Ho inoltre insistito sulla disciplina che l’artista si è auto-imposto, circoscrivendo la pittura a pochi elementi e articolandoli in modo inesauribile, ma anche sulla disciplina dello sguardo esercitata sullo spettatore e sul suo inevitabile aspetto coercitivo; sull’accecamento e l’oscurità piuttosto che sulla visione e la vigilanza, propri alle opere mature; sulla tattilità e la plasticità delle superfici piuttosto che sulla loro impalpabile diafanità, spostando così l’asse dall’otticalità alla gravità; sul dialogo con artisti quali Barnett Newman, nei cui scritti ho spesso trovato le risposte alle domande sollevate dai dipinti di Rothko; sulla dibattuta eredità della sua opera negli anni ‘60, su cui non è stata ancora scritta la parola definitiva.
Ho inoltre insistito sulla disciplina che l’artista si è auto-imposto, circoscrivendo la pittura a pochi elementi e articolandoli in modo inesauribile, ma anche sulla disciplina dello sguardo esercitata sullo spettatore e sul suo inevitabile aspetto coercitivo; sull’accecamento e l’oscurità piuttosto che sulla visione e la vigilanza, propri alle opere mature; sulla tattilità e la plasticità delle superfici piuttosto che sulla loro impalpabile diafanità, spostando così l’asse dall’otticalità alla gravità; sul dialogo con artisti quali Barnett Newman, nei cui scritti ho spesso trovato le risposte alle domande sollevate dai dipinti di Rothko; sulla dibattuta eredità della sua opera negli anni ‘60, su cui non è stata ancora scritta la parola definitiva. Mi sono insomma sforzato di capire come funzionano le opere di Rothko, convinto che i suoi siano meno dipinti di qualcosa che dipinti indirizzati a qualcuno, meno raffigurazioni di scene drammatiche che ricreazione delle stesse condizioni tra l’artista e lo spettatore, meno la resa di un’esperienza che un’esperienza à part entière. Ma non posso nascondere la speranza che queste pagine possano, nel loro piccolo, contribuire a rilanciare in Italia un modo militante e rigoroso, esclusivo e non sussidiario di esercitare la critica d’arte contemporanea. In questo senso, il lavoro da compiere è enorme.
articoli correlati
Rothko a Roma
Rothko a Bilbao
video correlati
La mostra al PalaExpo
riccardo venturi
*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 44. Te l’eri perso? Abbonati!
Riccardo Venturi – Lo spazio e la sua disciplina
Electa, Milano 2007
Pagg. 222, ill. a colori, € 29
ISBN 8837055013
Info : la scheda dell’editore
Per approfondire
Mark Rothko, L’artista e la sua realtà, Skira, pp. 216, € 24
Mark Rothko, Scritti sull’arte, a cura di Riccardo Venturi, Donzelli, pp. 252, € 23,90
Jackson Pollock, Lettere, riflessioni, testimonianze, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita, pp. 152, € 13
Annie Cohen-Solal, Americani per sempre, Johan & Levi, pp. 498, € 31
La Scuola di New York, a cura di Viviana Birolli, Abscondita, pp. 98, € 12
[exibart]




.gif)



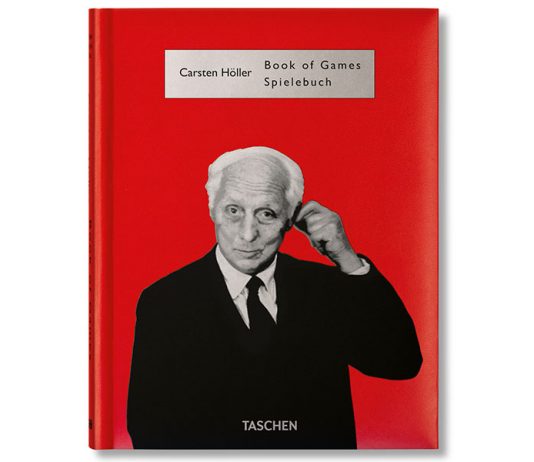


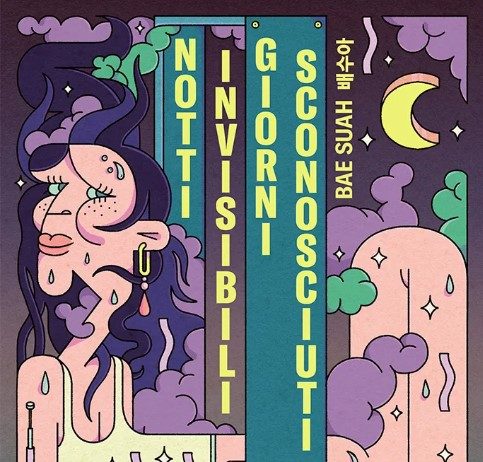



















convengo con questa lettura scomoda dell’opera di rothko. è un artista difficile, molto profondo e conflittuale: dotato di straordinaria ambizione, forse il suo disegno è fallito: le campiture di colore e sopratutto le zone finitime tra di esse parlano di una tragedia umana e universale destinata a essere difficilmente compresa, anzi, esposta a equivoci di segno opposto: per esempio a letture filosofiche di segno orientaleggiante. Invece credo che l’uomo e l’artista siano profondamente inscritti nella cultura e nella storia del pensiero occidentale, in quel filone fortemente individualista e rigoroso di cui rothko stesso assieme a pochi altri detta le estreme coerenti e cocenti conclusioni.
Consiglio la lettura del capitolo a lui dedicato ne ‘Il Potere dell’Arte’ di Schama.