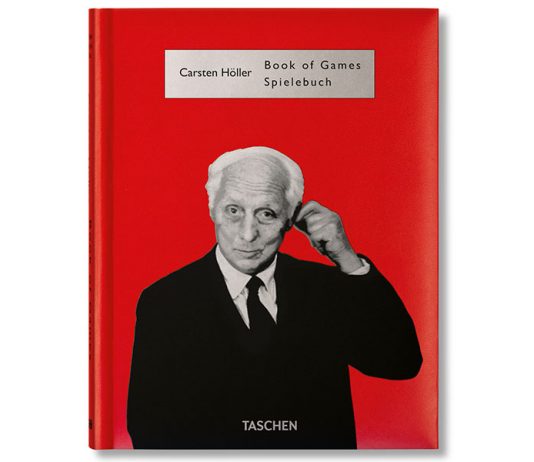Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
20
febbraio 2019
READING ROOM
Libri ed editoria
La radicalità dell’avanguardia
di Ernesto Jannini
di Ernesto Jannini
C’è una risposta a cui non possiamo sottrarci, in relazione ad una domanda cardine, che interessa la sfera dell’arte: il rapporto che intercorre tra quest’ultima e la dimensione socio-politica della realtà. È quanto sembra suggerirci Stefano Taccone con La radicalità dell’avanguardia, pubblicato nella collana cartografie da Ombre Corte: una raccolta di saggi del triennio 2013-2016, presentati al pubblico in svariate occasioni.
Attraverso una sua personale lente d’ingrandimento, l’autore da corpo ad un tessuto riflessivo di indubbia attualità partendo dai contributi critici di ricercatori che si sono interrogati sugli stessi temi. Si parte da Mario Perniola, Lea Vergine, Peter Bürger, per arrivare a Martin Damus. Un “viaggio dialogico”, quello di Taccone, che tocca le sponde della terra della radicalità, una terra dura dove molti artisti hanno faticato a lungo per piantare il seme del rinnovamento: radicaliltà, appunto, poiché il discrimine sta proprio in questa presa in carico della globalità dell’esistenza e non soltanto dell’innovazione linguistica dell’arte che troppo spesso pare correre per conto suo. E dunque il saggio indaga quel concetto di “unitarietà” caro ai situazionisti, che con il loro radicalismo pensarono al superamento dell’arte da parte del “proletariato maturo”, forse eccessivamente abbagliati dalla luce dal maggio parigino. Un concetto di unificazione vita-arte che sembra essere una delle ultime utopie del secolo breve, contraddetto dal crudo realismo dell’economia a cui fa da pendant l’inarrestabile avanzata del capitalismo. Una grande antitesi tra economia e arte, come sottolinea Taccone mentre rilegge il Perniola de L’alienazione artistica del 1971, in cui il filosofo e saggista scomparso un anno fa, metteva bene in evidenza la scissione avvenuta nel corso della storia, tramite “tre processi di separazione”, in cui l’arte verrebbe a configurarsi come attività alienata, un residuo, una forma di ‘passività reale’. Un’antitesi, quindi, che sembra inconciliabile, alla cui base giocano in maniera differente i pesi e le misure dell’una e dell’altra. All’economia – imprescindibile nella sua cogente necessità – l’indubbio primato d’incidere sulla realtà, ma lontana dal “significato”; all’arte l’‘amara’ conquista del “significato”, ma lontana dalla realtà. Se alla necessità dell’economia non si affianca la libertà dell’arte si avrà, come risultante dei due vettori, una società scissa, lontana da qualsivoglia possibilità di fiorire in senso “unitario, reale, significativo e qualitativo”. A fronte di tale spaccatura profonda all’artista consapevole non resta che agire “esemplarmente”, addivenendo, tra l’altro, ad una pratica di teoria critica costante e radicale nei confronti del contesto socio politico e culturale in cui viene a trovarsi e ad operare. Ed è quanto poi iniziarono a fare i situazionisti fino al culmine del Sessantotto e, a seguire, tutti quegli artisti di alcune neoavanguardie che incominciarono a vivere in prima persona la crisi della civiltà attraverso la presa di coscienza dell’inadeguatezza dei loro mezzi creativi. Da ciò il continuo ‘sconfinamento’ in altre aree di ricerca, di frenetico sondaggio verso altre possibilità espressive, ma lontani dall’autoreferenzialità; tentativi di saldatura con la vita unitaria, la stessa che la logica strumentale del capitalismo compromette con la pressa del suo determinismo costante. Dagli anni Sessanta in poi l’arte si muove in questi interstizi di possibilità, – come si evince dalla disamina del testo di Taccone -, alle prese dei due corni del problema in cui, o salvare sé stessa chiudendosi nel caldo tepore dell’autonomia, ma lontana dal mondo reale, o battersi per operare una rivoluzione; locuzione, quest’ultima, che non può essere più identificata con la ‘semplice’ rivoluzione linguistica.
Taccone prosegue con le lucide analisi dei testi di Lea Vergine, quel suo Attraverso l’arte. Pratica politica/pagare il ’68, dei suoi ‘tormenti’ e dubbi, ma in particolare analizza gli scritti taglienti di Martin Damus, Peter Bürger, e di Donald Draw Egbert: autori, questi ultimi, che concordano pienamente, anche se con percorsi differenti, sulla fine della dimensione sovversiva delle avanguardie. E a ben vedere ci si accorge che anche tra le neoavanguardie sussiste il germe delle contraddizioni. In fondo – ci dice Taccone, citando Andrea Frazer –, anche Hans Haacke, uno dei fondatori riconosciuti della ‘Institutional critique’, non è esente da incoerenze: “L’apparente radicalismo della critica istituzionale delle origini verrebbe così finalmente ricondotto alla sua autentica dimensione, che poi è quella che gli stessi suoi protagonisti avrebbero chiara fin dall’inizio – ‘chiunque conosca il suo lavoro deve ammettere che, lungi dal voler abbattere il museo, il progetto di Haacke è stato un tentativo di difendere l’istituzione arte dalla strumentalizzazione degli interessi politici ed economici’-, e lascerebbe conseguentemente spazio ad un dichiarato quanto pressoché obbligato – e, a mio parere, un po’ malinconico – riformismo.
Ma la rivoluzione dell’esistente – come suggerisce il duo Negri-Hardt – non si gioca più all’interno di una dialettica dentro-fuori. Le stesse spinte originarie, autenticamente radicali sono state assorbite col sorriso sulle labbra dall’establishment. Il rischio consolatorio dell’arte relazionale, della public art è davanti a noi, ancorché quello di trasformarsi in un ‘lubrificante sociale’ – per dirla ancora con Haacke.
Ernesto Jannini
Stefano Taccone,
La radicalità dell’avanguardia
Ombre Corte editore, 2017
ISBN 9788869480744
Euro 11