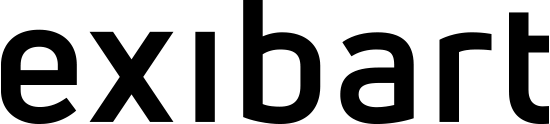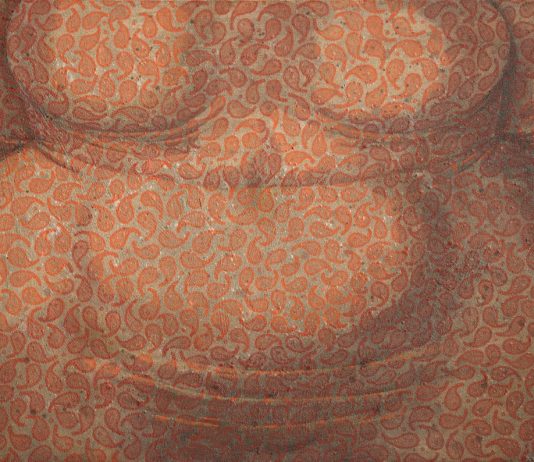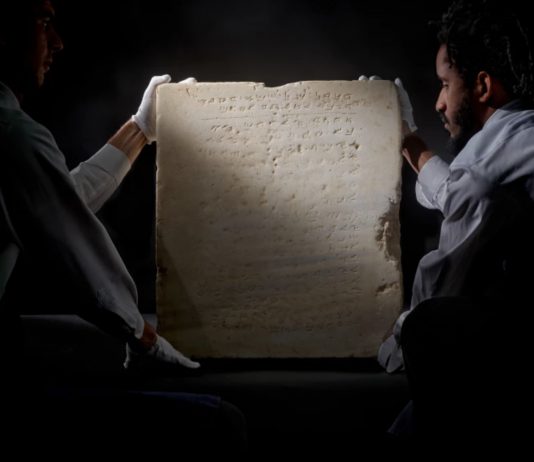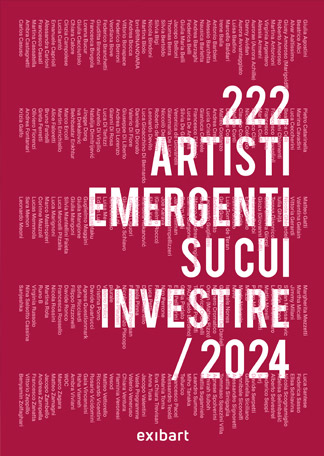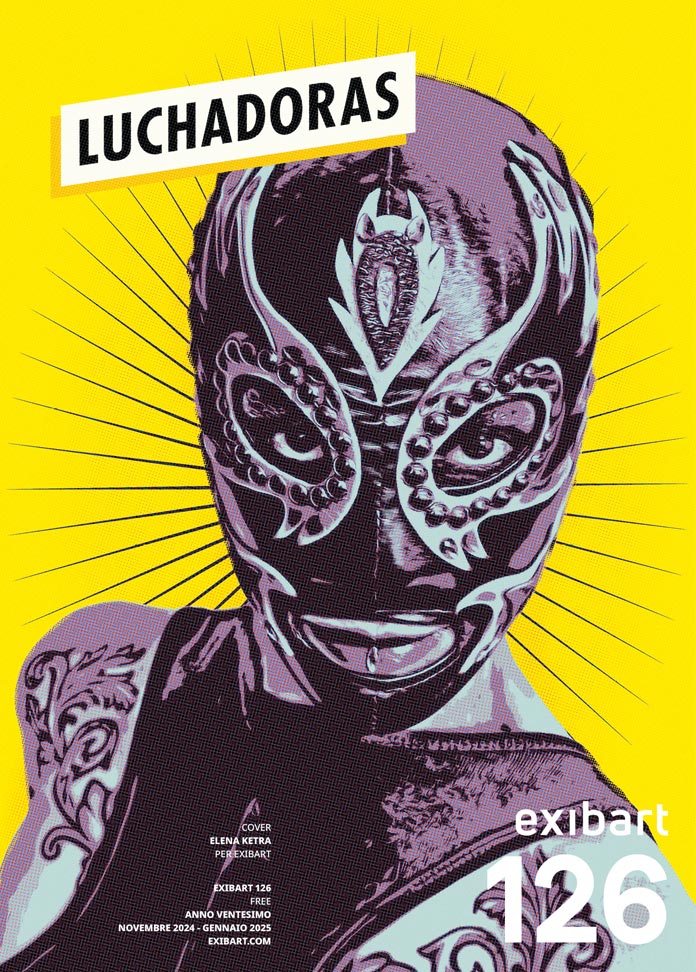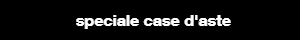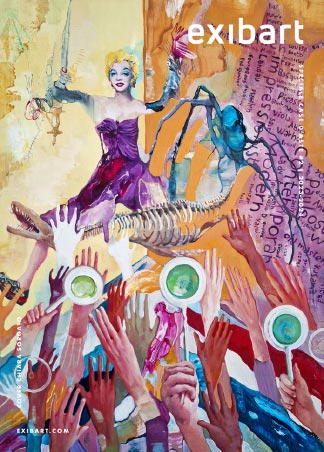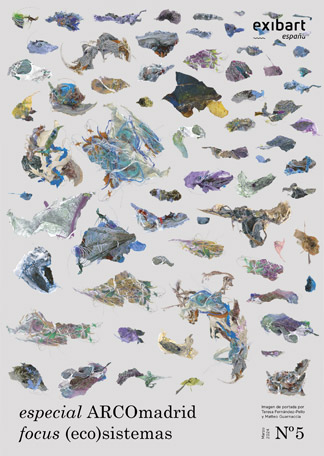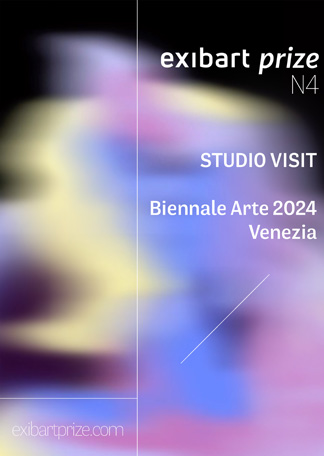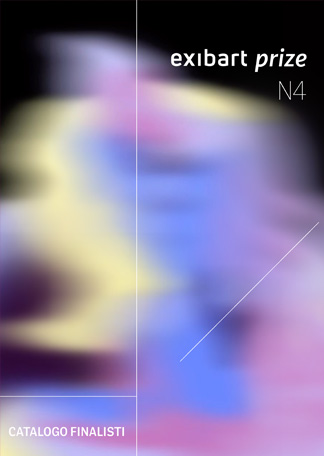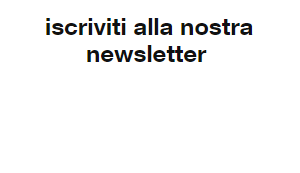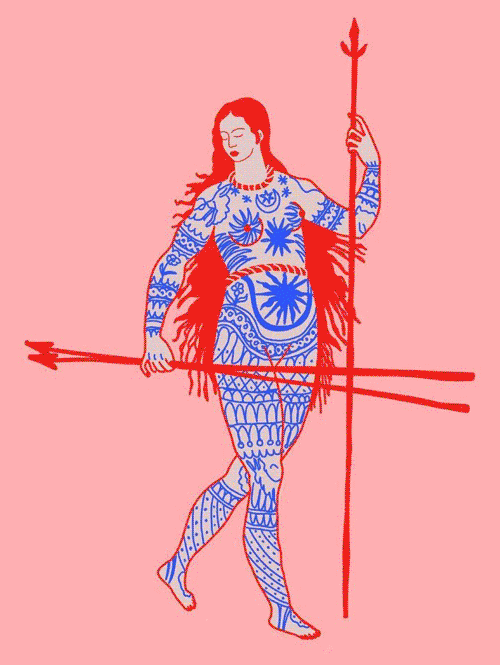-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Galleria Canesso compie 30 anni!
Mercato
Anno 1994, Parigi. Maurizio Canesso apre la sua prima galleria d’arte al 26 di Rue Lafitte. Al primo piano, senza vetrina, dichiaratamente lontana dal trambusto cittadino. Ha già lavorato per Piero Corsini, prima di allora, a New York. Ma è nella Ville Lumiére, nel IX arrondissement, che Canesso può condividere senza limiti il gusto per i vecchi maestri – Barocco e Rinascimento italiano in primissima linea. Passano i giganti per le sue mani: Alessandro Magnasco, Bernardo Strozzi, Guido Reni, Giulio Cesare Procaccini. E attraggono acquirenti altrettanto blasonati, dal Metropolitan agli Uffizi al Musée du Louvre. Il suo mantra? «Bisogna saper conservare l’opera, valorizzarla prima di volerla cedere», rivela. «Ci vuole una grande forza per non privarsene troppo rapidamente, la difficoltà del mestiere è tutta qui». Nel frattempo, i nuovi approdi della galleria: nel 2010 l’apertura di una sede a Lugano, nel 2021 inaugura quella di Milano, in zona Brera, sotto la direzione di Ginevra Agliardi. Adesso, a trent’anni esatti dall’inizio dell’avventura, Galleria Canesso festeggia con una doppia mostra tra Parigi e lo spazio meneghino (fino al 28 giugno). L’occasione perfetta per uno sguardo al passato, e al tempo che verrà.
Intervista con Maurizio Canesso
La prima domanda è d’obbligo: com’è cambiato il mercato dell’arte antica dal 1994, anno di nascita della galleria?
«Enti e fondazioni bancarie locali, fino al 2008, sono stati interlocutori fondamentali per l’arte. Con le loro acquisizioni, queste istituzioni riportavano opere di grandissima qualità nei luoghi dove erano nate, tutelandole. Poi c’è stata la crisi e le fondazioni hanno quasi del tutto smesso di acquistare in modo prioritario i beni locali. Sono stati coinvolti a catena moltissimi altri soggetti: in primo luogo i collezionisti privati che hanno perso importanti riferimenti istituzionali, ma anche gli storici dell’arte e, ovviamente, i mercanti. Questo ha influito in generale sul mercato: validissimi pittori, la cui opera era considerata di forte importanza per la costruzione delle identità culturali delle comunità, faticano oggi ad avere il giusto riconoscimento. Il mercato internazionale privilegia nettamente i grandi nomi e tende a tralasciare ciò che non è già celebre, spesso indipendentemente dalla qualità».

Dati alla mano, l’ultimo report di ArtTactic rivelava che «il mercato degli Old Masters ha generato vendite per $ 313 milioni nel 2023, con un calo del 4% rispetto al 2022. Tuttavia, il numero di lotti venduti è aumentato del 19% rispetto al 2022, e così anche il tasso di vendita». Combacia con la sua esperienza? Qual è la salute del mercato dei “vecchi maestri”?
«Credo vada sottolineata la differenza tra la fascia alta del mercato, che non ha mai davvero sofferto, e quella medio-bassa, che è oggi più debole. Il mercato degli Old Masters oggi premia opere di pittori celebri e con soggetti iconici, rigorosamente in ottimo stato di conservazione. In questi casi, si arriva a cifre mai raggiunte prima».
Sempre meno tesori antichi in circolazione, sempre meno occasioni di accaparrarsi capolavori già riconosciuti. E in termini di educazione, a che punto siamo? I collezionisti di arte antica studiano, finanziano la ricerca?
«Rispetto a qualche decennio fa, la presenza dei social e il continuo bombardamento di immagini riempiono il nostro tempo e la nostra testa col risultato che c’è una tendenza a leggere molto meno che in passato. Nonostante questo, in galleria continuiamo a scrivere e produrre pubblicazioni: per i musei e per i clienti privati la serietà scientifica è fondamentale, imprescindibile perché ci sia un solido rapporto di fiducia».

A proposito di collezionisti: qual è oggi l’identikit dell’acquirente-tipo di Canesso? Quanti anni ha, che cosa fa nella vita, dove e perché compra Old Masters?
«Direi che è un self-made man (o woman!), un imprenditore o un’imprenditrice della prima generazione, che a un certo punto ha avuto una folgorazione per l’arte antica. Scattata la passione poi c’è lo studio, questi collezionisti sono spesso autodidatti appassionati e coltissimi. Tra i nostri principali acquirenti ci sono però anche i musei che, ogni anno, rappresentano circa un terzo – e qualche volta anche metà – del totale delle entrate della galleria».
E i giovani comprano in galleria? Qual è il rapporto dei Millennials con Canesso?
«I collezionisti giovani storicamente sono sempre stati una minoranza. L’avvicinamento all’arte antica richiede tempo. Siamo felici di fornire ai giovani appassionati occasioni di incontro con le opere che, nelle gallerie, si vedono più da vicino, più intimamente che in tanti musei. Magari qualcuno diventerà un collezionista, in ogni caso condividere la bellezza di un oggetto antico è sempre un valore aggiunto – anche per noi che, con le domande e le osservazioni dei visitatori, spesso scopriamo nuovi modi di guardare un’opera».

Questa domanda, nell’ambito dell’arte antica, genera sempre risposte contrastanti: si può parlare di trend in riferimento agli Old Masters? Di artisti, generi e peculiarità che, di volta in volta, vanno più o meno di moda?
«Senza dubbio! Negli ultimi anni c’è stata tantissima attenzione per le artiste donne, ad esempio. Sono state riscoperte pittrici dimenticate e i prezzi delle opere di quelle già celebri sono tendenzialmente saliti di molto. Più recentemente poi è cresciuto l’interesse per quei dipinti che ci raccontano delle minoranze e che sono legati ai temi considerati di “global interest”: così sono tornati in voga pittori come il Maestro della tela Jeans, anonimo artista del Seicento sul quale con la galleria ho lavorato molto fin dal 2010, quando gli abbiamo dedicato una mostra a Parigi».
Parlavamo prima del rapporto con i musei internazionali. Ricorda ancora la prima grande acquisizione registrata dalla Galleria Canesso?
«È stata indimenticabile. Avevo ventidue anni e avevo comprato un quadro incompiuto di Carlo Portelli (ca. 1508-1574). L’avevo portato a Firenze per proporlo a uno dei più grandi mercanti dell’epoca, Piero Corsini (1938-2001), che però lo rifiutò e mi consigliò di lasciarlo in deposito da un amico antiquario per godermi il resto della giornata fiorentina a mani libere. Poche ore più tardi, davanti alla vetrina dell’antiquario dove l’avevo depositato passò per caso Luciano Berti (1922-2010), allora direttore delle Gallerie degli Uffizi. Berti comprò immediatamente il Portelli per il museo».
In tempi più recenti, invece? Un’opera che le stava particolarmente a cuore e che ora vediamo esposta in una collezione museale?
«Forse direi Venere e Adone di Luca Cambiaso al Louvre. Un dipinto che dimostra la grande influenza del pittore sul barocco italiano, ma anche su Rubens e sugli sviluppi del gusto europeo».

Restiamo in area ricordi: qual è stata la scoperta più emozionante nel corso di questi anni? Un’attribuzione, un ritrovamento, uno studio che abbia portato a risultati importanti…
«Uno dei casi più memorabili rimane per me quello di un dipinto di Domenico Marolì (1612-1676), un pittore siciliano attivo a Venezia. Arrivò in galleria privo di attribuzione e ci sono voluti anni prima di riconoscerne l’autore e decodificarne il soggetto. Davanti a una biblioteca piena di libri, carte e strumenti, un uomo in abiti femminili indica il paesaggio fuori dalla finestra alle sue spalle. L’enigma è stato risolto riconoscendo la tela nell’inventario di una collezione veneziana del Seicento: Euclide di Megara che si traveste da donna per andare ad ascoltare le lezioni di Socrate ad Atene, sfuggendo al divieto di accesso in città per i megaresi. Il soggetto simboleggia la difficoltà di raggiungere il sapere e per questo è stato acquisito per l’ingresso dell’organizzazione filantropica americana Bloomberg Philanthropies, a New York».
E arriviamo così ai fatidici 30 anni. Come state festeggiando?
«Abbiamo allestito una mostra nelle due sedi della galleria, Parigi e Milano, che propone al pubblico una selezione di opere significative passate dalla Canesso e giunte nelle raccolte di grandi collezionisti privati. È un’occasione per vedere dipinti di altissima qualità, alcuni dei quali rarissimamente esposti al pubblico, e sono felice del riscontro che questa iniziativa sta avendo. Intanto, con lo staff della galleria ci siamo rimessi al lavoro: abbiamo progetti per i prossimi trent’anni almeno!».