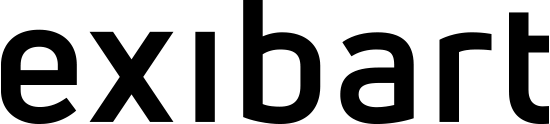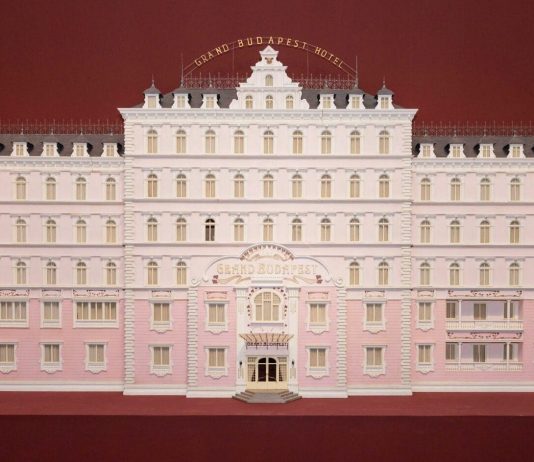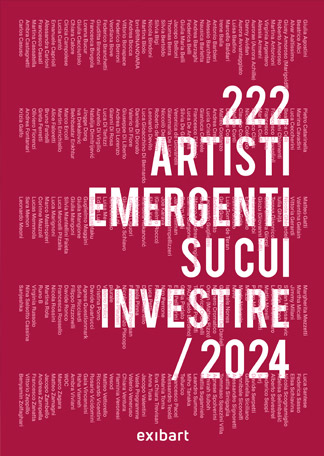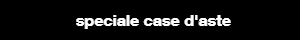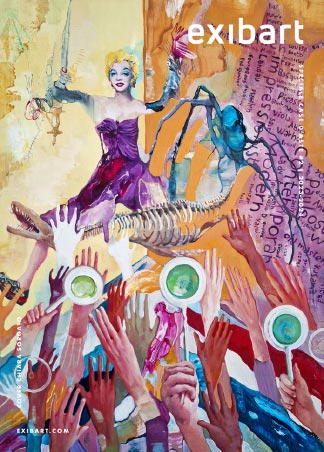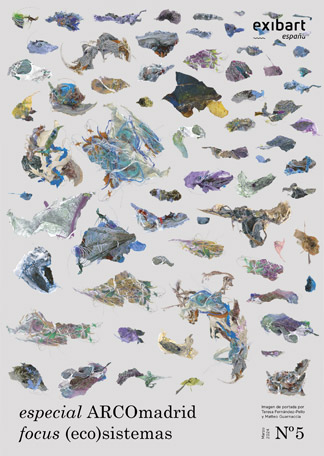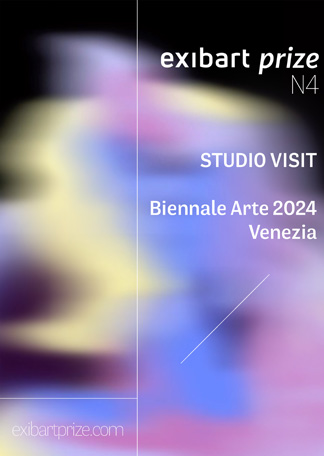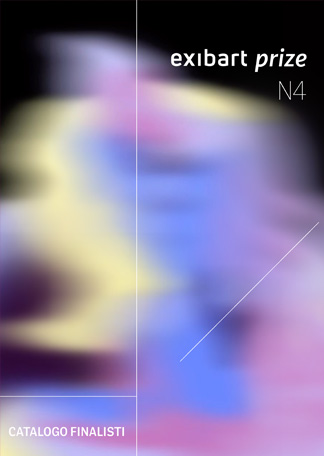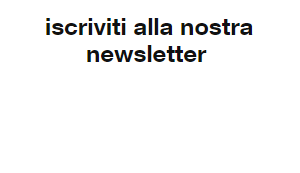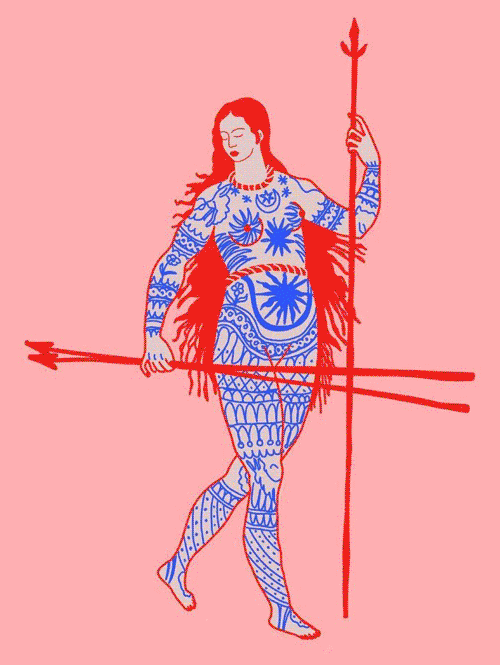-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
Nel corso dei secoli, probabilmente nessun soggetto è stato osservato, analizzato, replicato e performato quanto il corpo umano. Anche oggi, nel pieno di un’epoca dominata dalla sua smaterializzazione — tra avatar, metaversi, AI e accelerazioni postumane — il corpo rimane un nodo ineludibile per comprendere il nostro tempo. Tutti ne possediamo uno, e, forse, solo sondandone le trasformazioni possiamo intuire le logiche culturali che lo circondano.
È da questo presupposto che si sviluppa la nuova mostra delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Manieri Elia. L’esposizione ci invita, però, a compiere un gesto controintuitivo: non accelerare verso il futuro, ma tornare a quel momento storico in cui l’ossessione per il corpo prese forma — letteralmente — come paradigma del sapere e della visione.

Intitolata Corpi Moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione, la mostra identifica infatti la fine del Quattrocento come un momento di svolta nella comprensione scientifica ed artistica della corporalità umana. Se, da un lato, l’indagine scientifica svela l’anatomia, portando la propria ricerca sotto l’epidermide, dall’altro lato il corpo viene velato: diventa una vera e propria costruzione culturale, una maschera per la vera personalità dell’individuo in questione.
Tutto ciò viene indagato attraverso una moltitudine di capolavori del Rinascimento italiano, a partire dalla prime sezione, dedicata agli studi anatomici portati avanti nelle università —in particolare a Padova— e incorporati nelle opere dei grandi artisti dell’epoca. Da accurati modellini a incisioni e disegni, questa prima parte del percorso espositivo dimostra come l’approccio, alla fine del Quattrocento, si fa più rigorosamente scientifico.

Viene esposto qui, dopo sei anni dalla sua ultima presentazione al pubblico, anche l’Uomo vitruviano (circa 1490) di Leonardo da Vinci, icona non solo delle collezione delle Gallerie dell’Accademia, ma dell’intero patrimonio culturale globale. Dal Metropolitan Museum of Art arriva invece lo studio per la Silbilla libica (1510 – 1511 circa) di Michelangelo: un preziosissimo foglio in cui il disegno in pietra rossa delinea la celebra donna muscolosa della Cappella Sistina.
Il secondo capitolo dell’esposizione si focalizza invece sulla concezione di corpo quale oggetto di desiderio: non solo morbidi Veneri sdraiate su prati idillici o in stanze dai ricchissimi decori, ma anche il corpo maschile, lirico e anti-eroico di santi ed eroi greci ritratti all’antica.
Infine, la terza e ultima sezione —intitolata Il corpo costruito: rappresentarsi— indaga il corpo come spazio di trasformazione e rappresentazione culturale attraverso vestiti, trattati di chirurgia, oggetti di cosmesi e persino alcuni primi esempi di protesi corporee. Questi elementi presentano perciò il corpo come in continua metamorfosi e come luogo di sperimentazione, una superficie su cui si inscrive il potere, il genere, la bellezza: un’idea, questa, estremamente contemporanea.