
Tra qualche amena avventura in discoteca, un nuovo saggio di Caspar Henderson su “fragori, scoppi, bisbigli, ronzii”, un’esecuzione plurisecolare, l’approccio della Gen Z all’ascolto frenetico e un’immersione nella muzak che ci circonda. La forbice dell’ascolto: un approfondimento in tre puntate sul culto del suono, dalle nuove pratiche di fruizione ai vecchi tabù.
Parte III
«“Mettiamo Musik rilassante” disse il Dottor Denkmal, schiacciando un pulsante. Da tutti gli angoli della sala si sprigionò un brano polifonico, un’insipida versione per orchestra di qualche popolare musica operistica italiana, Verdi o Puccini; Hnatt non sapeva quale…Il Dottor Denkmal chiuse di scatto un interruttore, fischiettando felicemente tra sé l’aria d’opera. La terapia E degli Hnatt era cominciata» (da Le tre stimmate di Palmer Eldritch di Philip K. Dick, Fanucci Editore, 2003, pag. 93).
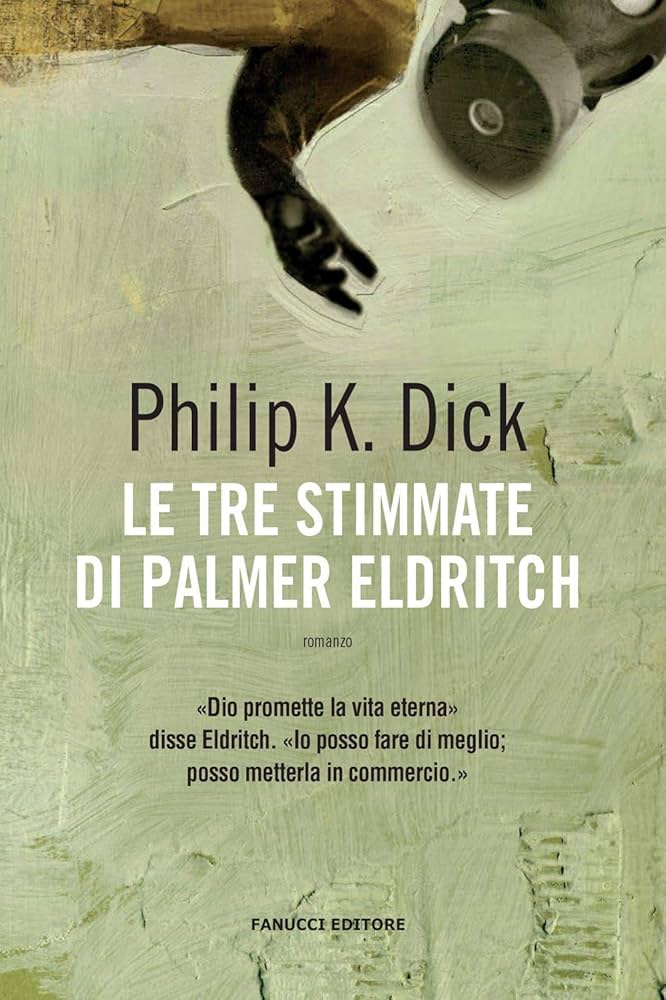
Le tre stimmate di Palmer Eldritch può essere considerato un capolavoro psichedelico della fantascienza, non certo un trattato di musicologia. Ma nel passaggio del racconto che abbiamo riportato, Philip K. Dick, maestro di letteratura fantastica, mette in scena una situazione che ha invece a che fare non con immaginifiche previsioni future ma con la realtà contemporanea, non con il filo rosso di una storia aliena ma con la musica. O meglio con i sottofondi più o meno opportuni, la cosiddetta muzak, con cui si è deciso di arredare gli spazi pubblici e privati della nostra vita metropolitana. Con queste sonorizzazioni distratte si sono ammorbati infatti aeroporti, ospedali, segreterie telefoniche, metropolitane, sale d’aspetto, musei.
Se è vero come credo, che ogni occhio “vede” quello che “ascolta”, i danni di una muzak sconsiderata potrebbero aver provocato reazioni paradossali in luoghi come i supermercati, gli spazi espositivi, i belvedere, le terrazze panoramiche, le hall degli aeroporti, i bar.
Ecco, i bar. Qualche settimana fa mi trovavo in Romagna, per un weekend rigenerante nel natio paesello. Lì, ho vissuto l’esperienza di una muzak profonda. Stavo facendo colazione in un bar, leggevo un quotidiano, quando ho cominciato a far caso allo strano effetto stereofonico che avevano innescato nelle mie orecchie due canzoni che “circolavano” in quell’ambiente. A sinistra, un maxischermo televisivo trasmetteva in diretta una messa: i fedeli di una parrocchia di Cuneo si prodigavano nell’interpretare quelle orrende nuove melodie liturgiche che fanno da soundtrack ai testi sacri del libretto domenicale e che hanno sostituito quasi ovunque l’inarrivabile canto gregoriano: «Signore ti rendiamo grazie…Gloria nell’alto dei cieli…», eccetera. A destra, due potenti diffusori pompavano il refrain di un martellante pezzo di Raf: «Sei la più bella del mondo/la più bella per me/ed era tutta la vita che/non aspettavo che te…», eccetera.
L’effetto era insieme straniante e seducente. In equilibrio perfetto, amalgamati dal brusio del locale e da qualche noise involontario – la macchina del caffè, il jingle di un video giochi, lo sproloquio in dialetto di un paio di avventori – i due brani diventavano uno e la musica si faceva ambiente, unificando lo spettro sonoro come i colori di un quadro impressionista. Il cadenzato Padrenostro, arrangiato per due chitarre acustiche da due chierichetti di scuola “cionfoliana” (da Giuseppe Cionfoli, Erchie, 18 ottobre 1952, cantautore italiano, ex religioso francescano, noto al grande pubblico nei primi anni Ottanta con il nome di Fra’ Cionfoli), e il tormentone pop veicolato da una radio privata che va per la maggiore in Romagna, si rimandavano segnali sonori, significati semantici e vibrazioni, ora similari ora contrastanti. Una muzak profonda, appunto.
Muzak è il nome di un’azienda fondata negli Stati Uniti nel 1934, con sede a New York, «Specializzata nella produzione e nella diffusione di musica di sottofondo, destinata ad alberghi, uffici, sale d’aspetto di stazioni e aeroporti, officine, scuole, e perfino mattatoi». Lo scopo prefissato di questa produzione musicale era quello di coprire rumori fastidiosi o comunque indesiderati, facendo in modo che la gamma delle frequenze non si estendesse oltre gli 8000 Hz.
90 anni dopo, è il caso di dire che la sua diffusione è amplificata in misura esponenziale. In un’epoca affetta da fobia del silenzio, la background music invade le nostre orecchie a ogni angolo di spazio pubblico (che si tratti di bar, ascensori, bus, aerei, uffici, convention, raduni, gallerie d’arte, perfino di mattatoi…) o per ingannare l’attesa al call center. Allo stesso tempo la muzak, soprattutto quella delle origini e in particolare quella del precursore Erik Satie – la musique d’ameublement, la musica d’arredamento, espressamente concepita per una fruizione distratta ed eseguita per la prima volta l’8 marzo 1920, alla Galerie Barbazanges di Parigi – intendeva creare un generale senso sonoro di euforia, talvolta paragonabile a quello di un blando raptus estatico. A pensarci bene, lo stesso raptus che ho provato io nel bar del paese, grazie alla messa di Rai Uno e all’ugola “evangelica” di Raf.
Ci sono 165 gallerie da 35 Paesi al Brussels Expo, per la 41esima edizione della fiera, inclusa un'ampia selezione di protagonisti…
Attraverso più di cento opere, BAROCCO GLOBALE alle Scuderie del Quirinale esplora la Roma del Seicento e i suoi legami…
Una ex prigione diventa un hotel raffinato, succede a Charlottenburg, storico quartiere di Berlino, che ospita due mostre da non…
Alla Galleria delle Arti di Roma, le fotografie di Domenico Flora: tra souvenir, itinerari fotocopia e place grabbing, va in…
Universo Factory ospita le opere di quattro artisti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia in una mostra che esplora la…
Da Yves Klein a Mimmo Paladino, 120 artisti in mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro, a Napoli, per…