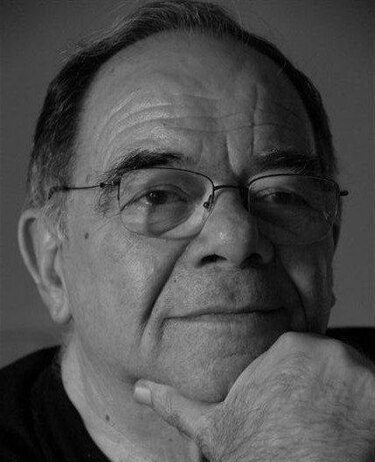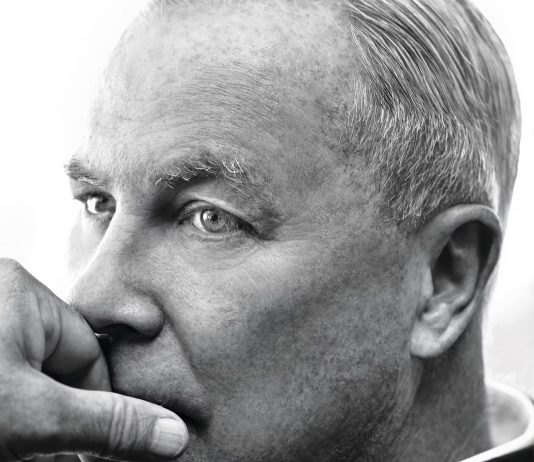-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
L’intervista/Evgeny Antufiev Vedere il mondo con lenti di smeraldo
Personaggi
Si apre domani alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia la prima personale italiana di Evgeny Antufiev. Artista russo che pesca dalla ritualità sciamanica, attratto dalla musica e che poi realizza raffinate installazioni in cui cuce, ricama, intaglia materiali più disparati, dai denti agli insetti e il marmo. Dove la manualità è molto forte e disegna un percorso archetipo. Perché, sostiene lui, la sacralità dell'immagine ha perso la sua aura
Difficile pensare che le opere di Evgeny Antufiev possano essere contenute nella dimensione di una galleria d’arte: non per dimensioni monumentali, ma per la vibrazione che da esse si sprigiona.
Antufiev proviene dalla Repubblica di Tuva, territorio della regione siberiana al confine con la Mongolia, dove la tradizione sciamanica è ancora palpabile e dove si pratica il canto Xöömej, il canto trifonico liturgico che richiama alla mente i mantra tibetani. Il lavoro dell’artista nasce e si sviluppa in una terra dove il rapporto degli individui con la natura è ancora quotidiano e la prospettiva culturale radicalmente altra rispetto a quella dell’Occidente odierno. Antufiev però non è un “bon sauvage”, un soggetto esotico da analizzare sotto la lente di un microscopio antropologico, bensì un artista visivo raffinato in grado di coniugare con interessante efficacia la matrice originale della cultura nativa con le elaborazioni linguistiche contemporanee.
Nelle sue opere, simboli e archetipi vengono declinati attraverso una sensibilità estremamente attuale, senza perdere forza. L’artista accosta oggetti apparentemente disparati e li trasforma attraverso un processo di elaborazione che presuppone pratiche eterogenee, tutte realizzate da lui in prima persona: le stoffe vengono cucite e ricamate, gli elementi organici come le ossa di animali utilizzate come parti di nuovi manufatti, gli oggetti fabbricati e assemblati. Tutte queste attività compongono un rito, di cui l’artista è l’officiante. Antufiev, chiamato a realizzare un progetto site specific per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia intitolato Twelve, wood, dolphin, knife, bowl, mask, crystal, bones and marble – fusion. Exploring materials e per la prima volta in Italia con una personale, riassume così la sua visione del rito e della scena mitica che si staglia dietro le sue performance: «In the wake of the general collapse of the space of myth, the knowledge of myth becomes the basis for creativity and the perception of reality» («sulla scia del generale collasso dello spazio del mito, la conoscenza del mito diviene la base per la creatività e per la percezione della realtà» n.d.r).
Lo abbiamo intervistato, parlando del rapporto tra la cultura nativa e l’arte contemporanea:
Sei nato a Tuva, nel cuore dell’Asia, un terra celebre per il patrimonio del canto trifonico e dove la tradizione sciamanica è molto forte e ancora presente. Qual è il tuo rapporto con questa tradizione?
«Si, effettivamente sono nato in un luogo dove sono molto forti queste tradizioni sciamaniche e sono tuttora praticate. Ma non posso dire che la mia conoscenza di queste pratiche sia strettamente connessa alle mie opere. Spesso più che il loro contenuto mistico mi interessano gli oggetti che impiegano. Gli sciamani sono stati i primi artisti e musicisti. Prima che nascesse la figura dell’artista, esisteva la figura dello sciamano che assolveva anche questa funzione. Semplicemente perché inizialmente incarnava un ruolo magico. Grazie a questo si poteva trasformare il mondo. Ad esempio uno sciamano non disegnava un animale solo per il piacere di disegnarlo, ma per avere un dominio su di lui. L’oggetto e la sua immagine erano connessi a questo».
Come può rapportarsi e in che modo può essere messa in relazione questa esperienza con la pratica dell’arte contemporanea?
«È una questione di ottica, del modo in cui si guarda. C’è una fiaba russa che assomiglia alla storia del Mago di Oz in cui in un paese di smeraldo, pieno zeppo di ricchezze, si poteva entrare solo con occhiali con lenti fatte di smeraldo. In assenza di questi occhiali, si poteva perdere la vista. Si scoprì che lo smeraldo era falso, ma che solamente grazie agli occhiali tutto poteva essere percepito come vero».
La tua cultura nativa si basa sull’oralità, sul suono e la musica. Come ti relazioni a questo patrimonio?
«Per me il suono e la musica sono molto importanti. Prima di tutto per la loro simmetria: ogni musica ha la forma di un cristallo. Parlo della musica tonale. In Tuva abbiamo questo tradizionale modo di cantare: un canto di gola in cui lo strumento è il corpo umano. Il canto a volte assomiglia al canto di un uccello, a volte allo sfregamento di due pietre oppure al ruggito animale».
Il tuo lavoro è potente e spesso evoca una dimensione di trascendenza. In qualche modo è fuori dal tempo. L’arte contemporanea occidentale mi sembra nella maggior parte dei casi meno incisiva, forse a causa della ipertrofica produzione di immagini da cui siamo soverchiati. Quale può essere una strada per ridare vigore all’arte?
«Spesso non capisco l’arte attuale, specialmente quella ancorata al progresso tecnologico perché tutto cambia molto velocemente e ogni arte che si basa sulla tecnologia diventa vecchia in cinque anni. Mi vengono in mente le installazioni con le vecchie televisioni a tubo catodico che adesso sembrano antiquariato. Non possiamo lavorare con internet e la nuova tecnologia quando all’interno dell’Iphone ci sono già tutti gli strumenti per creare arte attuale. Non ho paura che le mie opere invecchino, perché sono invecchiate tempo fa.
Non credo che si possa tornare indietro perché ogni tempo ha la propria arte. Risulta molto difficile credere che all’inizio del XX secolo la poesia avrebbe potuto avere avuto un ruolo così importante. Sembrava che la parola, come nel primo giorno della Creazione, potesse cambiare il mondo, ma ora la forza di queste parole è scomparsa e il suo potere è passato alla visualità. Andando avanti, credo che si indebolirà anche il potere della visualità e non sappiamo ancora cosa ci riservi il futuro. La visualità assomiglia a un re morente, senza eredi».
Il tuo lavoro è complesso, è composto da oggetti, immagini ma è da una parte rituale e performativa. Pensi che questa parte “rituale” possa essere compresa dal pubblico contemporaneo?
«Non ha importanza capire questa parte. Non ha importanza capire come funziona un cellulare per usarlo. Certo che se riesci a farlo, tutto si apre dall’altra parte… Mi piace però quando ci sono diversi livelli di comprensione».
C’è qualcosa di disturbante nel tuo lavoro, qualcosa di non addomesticato. Quale è a tuo avviso la differenza tra gli elementi che generano sgomento e inquietudine profonda, presenti nel tuo lavoro, e gli elementi “horror” che sono rinvenibili nella produzione artistica occidentale, apparentemente più innocui?
«Non mi è chiaro. A me sembra tutto organico perché il momento della cultura “pulita” è finito. Anche se può sembrare banale, se la cultura è forte e da questa unione nasce una terza cosa ancora più forte. Mi è difficile spiegare cosa è una cultura forte: forse “molto potere in un tocco sottile”».