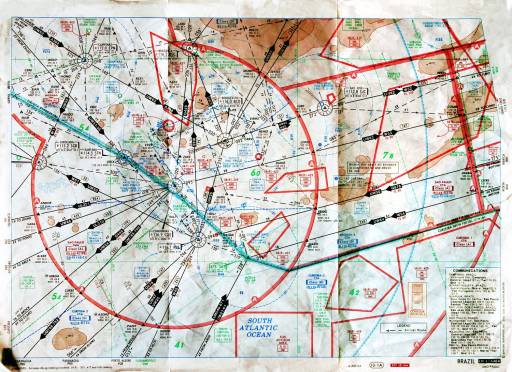-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
RACCONTI DI CITTÀ
Personaggi
Quest’anno la Spagna ha invitato il Brasile come paese ospite per Arco08. Per questo motivo, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ha proposto a Francesco Jodice di presentare São Paulo. Un film girato nel 2006, come capitolo e parte integrante di un più ampio progetto: City Tellers. Exibart ne ha parlato con l’autore...
di Marta Silvi
Come spesso capita, non ho potuto scegliere io stesso di lavorare sul Brasile, in Brasile, ma è stato un invito. Lisette Lagnado, la curatrice della XXVII Biennale di São Paulo, mi ha invitato a esporre alla Biennale e mi ha inoltre proposto una residenza per artisti, ovvero la possibilità di rimanere in città per un periodo più lungo e di lavorare su ciò che sostanzialmente si chiama un site specific. Questo ha cambiato completamente le possibilità perché ha significato avere tempo e un’economia a disposizione, ma soprattutto avere l’occasione di accedere a luoghi e fenomeni altrimenti inaccessibili. Contemporaneamente stavo tentando di avviare questo progetto che si chiama City Tellers, ossia una serie di docu-film sui cambiamenti dei modelli di vita, in particolare nelle grandi conurbazioni; quindi ho messo insieme le due cose. L’ho proposto alla curatrice, che ha accettato ed è nato questo lavoro. São Paulo_Citytellers è stato il prototipo di una serie di film.
Le prossime tappe del progetto?
Adesso stiamo preparando il film su Stoccolma, che gireremo a giugno per il Museo di Arte Moderna della città e per la televisione svedese. Questo progetto è sostanzialmente un film, che è a sua volta un’opera d’arte, ma, oltre al contenuto, che è quello di investigare i nuovi modelli comportamentali nelle grandi metropoli con una particolare attenzione ai fenomeni di autorganizzazione da parte delle comunità, c’è un aspetto formale per me molto importante. Questo lavoro, che è un progetto d’arte, è di fatto l’equivalente di una scultura e di un quadro, ha però sul piano formale un’altra intenzione, un altro interesse ovvero quello di instaurare delle dinamiche di disassamento di quello che è il tradizionale iter progettuale ed espositivo dell’opera d’arte.
Questo aspetto mi sembra molto interessante. La diffusione dell’arte è meno rigida di una volta e questo permette di inserirla a più livelli di fruizione e di lettura. In che modo la tua operazione s’insinua nel classico percorso che un’opera d’arte compie, scardinandolo dall’interno?
Quando si progetta un’opera d’arte, si può decidere di occuparsi di arte politica, per cui si parla di fenomeni che socialmente interessano milioni di persone mentre poi il lavoro viene esposto in una galleria dove lo vedono in cinquanta. Questa forma di imbuto è di fatto per me insensata. A me interessa sempre poter rompere questo sistema producendo delle opere d’arte che portano con loro un sistema di autoveicolazione e quasi di autoinstallazione. Detto questo, il progetto nasce con l’idea che ogni volta che un film della serie City Tellers viene mostrato in uno spazio dell’arte, che sia in un museo, in una galleria, in una fondazione, simultaneamente deve essere installato in un luogo di massima veicolazione, il web, la televisione o quant’altro. Per rompere o invertire il suddetto imbuto. Perciò, in occasione della vernice di São Paulo, il film era proiettato in un cinema costruito dentro l’edificio della biennale, in forma di opera d’arte, ma la stessa sera, alla stessa ora dell’apertura, era su Rete Globo (che è la tv pubblica brasiliana) a potenziale fruizione di chiunque volesse intercettare quell’oggetto. Per me è fondamentale permettere che l’opera d’arte esca dal museo e diventi intercettabile da utenti qualsiasi, non predestinati. La stessa cosa è accaduta quando il film è stato presentato alla Tate Modern di Londra: nel giorno in cui il film era esposto alla Tate in una mostra che si chiamava Global Cities, era anche sul web-site del museo. Quindi, in rete e accessibile. C’è sempre questa simultaneità, questi vasi comunicanti. 
Per quanto riguarda il contenuto, qual è il tuo sguardo e il tuo approccio verso questo paese, il Brasile, e come mai hai deciso di trattare e indagare problematiche inerenti la legalità, le formazioni paramilitari e quella giustizia autorganizzata che i substrati della popolazione di una città estesa e importante come São Paulo, è costretta a crearsi in mancanza di un apparato statale efficiente e presente?
Il progetto City Tellers non si occupa sempre di queste problematiche, se n’è occupata nel caso di São Paulo. Infatti, quando arrivo in un posto, la maggior parte del lavoro, diciamo l’80%, non è formale ma è di ricerca: mi fermo in un luogo e comincio letteralmente a comportarmi come un investigatore privato, cioè a indagare, attraverso vari sistemi, quali sono gli aspetti, i casi studio, le storie che voglio raccontare; non tanto perché la storia è eclatante, ma perchè secondo me diventa indicativa di un fenomeno, magari anche piccolo, ma assolutamente peculiare di quel luogo. Non m’interessa l’eclatanza, l’extra-ordinarietà, né la quantità del fatto, quanto è percepito e quanto impatta sul territorio. Mi interessa una storia puramente vernacolare, che ha una sua genesi “locale”, un suo perché. Mi interessa il fatto che a un certo punto le città diventino dei laboratori e evidenzino dei modelli che sono locali perché generati dalla condizione contestuale ma anche ipoteticamente imitabili. Si pensa sempre che i modelli imitati e imitabili siano solo quelli “politicamente governabili e governati”, la tolleranza zero di Rudolph Giuliani o il ticket di Londra. Si pensa sempre che i modelli che si possono copiare siano quelli impressi dall’alto. Al contrario, si ritiene che i modelli autoctoni, quelli generati dal basso, che sono i sommovimenti tellurici che le comunità producono, siano sbagliati. Questo è il motivo per cui City Tellers si occupa dei fenomeni generati dal basso, di autopoiesi da parte delle popolazioni.
E nel caso di São Paulo?
Sicuramente uno dei grandi fenomeni di São Paulo è l’illegalità, l’insicurezza. Io l’ho trattato in modo molto critico perché, venendo da una città, Napoli, non particolarmente sicura, so cosa vuol dire vivere in un luogo dove esiste un vero fenomeno di malavita organizzata. Sono arrivato a São Paulo con tutte le paure trasmessemi -non portar nulla, non far nulla, ti tagliano le orecchie, ti tagliano via i piedi- poi mi sono accorto di trovarmi in una città, sicuramente piena di problemi, difficile, ma per certi aspetti meno pericolosa di quanto non siano Napoli e Palermo, o quanto sia dialogare quotidianamente con la ‘ndrangheta o quant’altro. E ho capito che il Brasile stava affrontando una questione diversa, un problema legato piuttosto alla borghesia. Infatti, dal mio punto di vista, personale e forse sbagliato, il grande problema non è tanto la violenza, ma la paura della violenza, la paura di un fenomeno che è più raccontato che sostanziale e che viene spesso sbandierato perché utile durante le elezioni o perché potentissimo strumento coercitivo (l’ha usato perfettamente anche Bush negli Stati Uniti) nei confronti di un popolo tutto sommato poco attento alle informazioni come quello brasiliano.
Questo discorso vale a tutti i livelli?
Qui entriamo in un’altra problematica: il fatto che in Brasile in realtà non esista la borghesia. Quella che dovrebbe essere la borghesia, l’intellighenzia, lo strato della società paolista in grado di discernere informazioni, di fatto non lo è. Per cui davanti a dei fenomeni, sicuramente, di illegalità diffusissima, di rapine, violenze, uccisioni che sono in numero allarmante se confrontate con Lugano, normale se confrontate con altre città difficili, la reazione è sempre sbagliata, non è affacciarsi e risolvere i problemi ma chiudersi dentro. Per questo tutti girano con le auto blindate, si spostano con gli elicotteri per non dover toccare terra, vivono nei condomini per non esporsi all’esterno, è un continuo autorecintarsi. Ovviamente più ci si reclude dentro con la propria ricchezza, più chi sta fuori ha la tentazione di valicare questo limite e accedere nel territorio altrui, ma questo è un fatto logico. Il film tratta la violenza e il senso di giustizialismo come pretesto per parlare di un’idea sbagliata che si ha dell’illegalità e di conseguenza di un’idea sbagliata che si ha della legalità. Il fatto che la polizia a São Paulo in Brasile svolga un servizio pubblico e privato contemporaneamente, per cui un poliziotto pubblico alle sei stacchi e diventi un poliziotto a disposizione di privati, per me rappresentava il pretesto per parlare di un Paese che reclama tanto il bisogno di giustizia, ma che in realtà favorisce dei fenomeni al limite di una non democrazia. Immaginare che un poliziotto fino alle sei protegga tutti e due, e alle sei e un minuto protegga te contro di me perché tu gli paghi un servizio, esercitando un potere di violazione dei miei diritti, tra l’altro utilizzando manette, armi avute in dotazione dalla polizia, è sconcertante. 
Diventa una società schizofrenica, in cui non è più possibile riconoscere le singole identità e riconoscersi a sua volta in nessuna di esse. Una società che genera una discrasia inaccettabile…
Esattamente. Infatti, tutta la parte del film dedicata all’illegalità e al desiderio di giustizialismo, in realtà è una sorta di riflessione e di critica su quella che è oggi la borghesia brasiliana.
Una classe sociale che rimane piuttosto chiusa nelle sue posizioni, trincerandosi in roccaforti fittizie e irreali…
In realtà, la borghesia non esiste in Brasile perché la dittatura militare l’ha quasi cancellata. Il Paese è sostanzialmente diviso in tre fasce, di cui però una è illusoria. C’è una fascia altissima e numerosissima di ricchi, che spiegano i 23mila voli in elicottero al giorno a São Paulo altrimenti inaccessibili, c’è un numero smisurato di poverissimi, considerando che circa 3 milioni di persone vivono ancora nelle favelas in condizioni sub-umane, e poi c’è uno strato che esiste solo in teoria, ovvero la borghesia. Questa è stata non solo impoverita economicamente dal periodo della dittatura militare, ma anche culturalmente. Per cui, di fatto, quella che manca realmente è la borghesia. La società brasiliana si trova a vivere questa sorta di feudo di iper-ricchi, insieme a masse per noi inimmaginabili di immigrati, ex-nativi, neri poverissimi, e alla borghesia che non ha un potere economico, né uno politico, né uno intellettuale. Inoltre, la dittatura aveva tolto l’informazione dalla televisione pubblica, dai giornali, che ancora oggi rimangono di una qualità piuttosto… Certo non dovremmo dirlo proprio noi italiani… diciamo al pari nostro.
M’incuriosisce il fatto che tu nasca come architetto. Il modo di rapportarti all’architettura dei luoghi, al contesto in cui si vive, è un elemento che ti aiuta e ti permette di avere occhio critico e consapevole nei confronti dell’ambiente, dove gli eventi e gli incontri di persone hanno luogo. Rapportare l’architettura ai comportamenti e alle problematiche sociali, cogliere nella forma spaziale un indizio della presenza umana e rilevare la trasformazione del luogo in base alle abitudini e agli atteggiamenti di chi vi abita è un elemento che mi pare ricorra spesso nei tuoi lavori. Come ha influito la tua formazione sul tuo percorso artistico e di ricerca?
Sì, di formazione sono architetto, ma come indirizzo urbanista, che sono due cose molto diverse. Infatti, l’urbanistica ti porta a guardare il sistema articolato della città e dei territori. Poi, nel tempo, ho coltivato un interesse verso l’aspetto antropologico e sociale, in modo particolare di antropologia urbana; mi sono interessato a come i vari consorzi sociali, quindi il singolo, la coppia, la famiglia, il clan, l’azienda, la comunità, il quartiere, la città sviluppino consensi e scelte alternative rispetto a quelle che sono le scelte politiche. Di conseguenza è nato un interesse improvvisato, empirico di sociologia e antropologia urbana, dove non ho avuto studi alle spalle, e queste cose hanno finito per incrociarsi. È di fatto impensabile oggi studiare l’architettura di una città senza controllare e visionare i movimenti della cultura sociale e, viceversa, è impossibile pensare alla società intesa come figure senza pensare a quanto la forma dei luoghi condizioni la nostra vita, il nostro quotidiano. Un esempio banale, che non ha a che fare con São Paulo, ma che rispetta il tema della violenza, è ciò che dice sempre Mancuso, uno dei grandi magistrati anticamorra italiani: il vero problema di Napoli non è la camorra ma la forma dell’architettura, perché la città, e in particolare l’hinterland napoletano, è un luogo ingovernabile. E un luogo ingovernabile e quindi incontrollabile, automaticamente porta a un’abitudine all’illegalità. 
Ritornando ad alcuni tuoi lavori precedenti, come What We Want. Un paesaggio come proiezione dei desideri, mi chiedevo se non fosse presente un aspetto “situazionista” nel processo. Proiettare nel paesaggio un proprio desiderio, uno stato d’animo, una volontà specifica e viceversa ricevere dall’ambiente determinati stimoli, potrebbe far pensare a un ricorso alla psicogeografia come forma di approccio al contesto urbano…
No, non c’è nessuna vicinanza col Situazionismo, sebbene questa osservazione ricorra spesso. C’è invece il tentativo di un approccio molto lento e molto scientifico alla geografia sociale. In What We Want, che è un progetto formalmente diverso, perché è un lavoro fotografico, ma di fatto culturalmente vicino a City Tellers, perché guarda alla capacità di autorganizzazione delle persone nei territori, si lavora sull’osservazione attraverso la comparazione di fenomeni simili in distinte parti della terra. Per cui ritraggo Tokyo, New York, Singapore, l’Uruguay, Vancouver e via dicendo. Sia What We Want che City Tellers sono due progetti senza interruzione, degli archivi che continuano ad accumulare materiali nel tempo. Tra l’altro, in questi giorni alla galleria Marta Cervera di Madrid verrà esposta una parte del secondo libro di What We Want, e non è del tutto una coincidenza. Un altro elemento che accomuna molto i due lavori è una sorta di lentissima ruminanza nella ricerca delle informazioni prima della messa in atto. Alle spalle di tutte queste operazioni, che una volta partite diventano molto fluide, c’è innanzitutto una sorta di ossessione a definire che cosa il progetto voglia raccontare. Nel caso di City Tellers si tratta prevalentemente dei nuovi fenomeni di autorganizzazione spontanea come conseguenza alla iperdimensione delle metropoli e quindi alla naturale ingovernabilità. Dentro e dietro What We Want c’è, tant’è vero che è diventato il sottotitolo del progetto, il paesaggio come proiezione dei desideri della gente, che non vuol dire quindi “organizziamoci perché le cose altrimenti non funzionano”, ma semplicemente “questo luogo non è l’espressione dei miei desiderata. Come faccio a far sì che questa forma della città, nel suo piccolo casa mia e nel suo grande le mie piazze e i miei parchi, si pieghi e si deformi a immagine e somiglianza del mio desiderio, dei miei bisogni e della mia volontà?” È come se City Tellers parlasse delle necessità e What We Want dei desideri. Tutto sommato, anche nelle situazioni critiche, ritengo che i desideri siano sempre più forti delle necessità, e soprattutto più violenti e più immediati. Per cui alle spalle di questi progetti c’è una ricerca molto lunga e molto metabolizzata, più che sui luoghi, su cosa i luoghi oggi ci raccontino. A me non interessa definire che cosa andrò a fotografare, ma che cosa sta accadendo realmente, e di conseguenza capire quali sono i luoghi che stanno cambiando. Ecco perchè poi le mie foto trattano di Cina o di Giappone e magari meno di posti dove c’è molta storia, Londra, Parigi, Roma. Perché ci sono luoghi dove c’è una specie di cristallizzazione della storia e c’è pochissima contemporaneità. Dunque, in questi progetti c’è scarsissimo Situazionismo, ma molta ruminanza nel definire qual’è l’idea che li tiene coesi. Le foto di What We Want sono, infatti, formalmente diversissime -un’immagine di topografia, un reportage, un dettaglio- ma ciò che le tiene insieme è proprio l’idea.
D’altra parte, i situazionisti erano interessati principalmente alla casualità della promenade, mentre il tuo lavoro mantiene una progettualità molto forte, una razionalità d’indagine priva di sbavature “romantiche”.
Non sono un flâneur, non sono uno spiritualista, per cui non sento nulla quando cammino. Anzi, se non ho studiato bene prima, divento un semplice turista. Il mio è un lavoro molto razionale, molto freddo e soprattutto fatto a tavolino. Ognuno fa l’arte che vuole, col massimo rispetto per tutti, però nel 2008, nella situazione mondiale politica in cui siamo, per me sarebbe veramente difficile, poco interessante e forse un tantino irresponsabile non occuparmi di arte e politica, ma nel senso vero della parola, cioè di cose che ci riguardano in senso allargato. E non si può che farlo studiando, leggendo i quotidiani, non i nostri ma quelli degli altri Paesi, capendo, viaggiando, comparando. L’osservazione dello stato politico delle cose è una condizione sine qua non.
Il tuo lavoro viene presentato a Madrid, dove hai già da anni intrapreso una collaborazione con la galleria Marta Cervera. In Spagna hai esposto anche al Musac di León, che vanta in collezione alcuni tuoi lavori, il Reina Sofía ha appena acquistato il film São Paulo, il museo di Valencia possiede anch’esso alcune tue opere e parteciperai quest’anno alla mostra Post-it City al Cccb di Barcellona. Quello con la Spagna sembra un rapporto idilliaco. È con l’Italia che si fa sempre fatica?
Non te lo so spiegare. Il rapporto con la Spagna è una storia felicissima fin dall’inizio. È il Paese dove lavoro meglio. L’Italia è poco entusiasta dell’arte contemporanea in generale, poco entusiasta verso le novità, i cambiamenti. Mi sembra che in Spagna sia tutto più facile, e non credo che sia una fortuna solo mia. Inoltre, in Spagna mi sono capitate un gran numero di esperienze diversissime che non mi sono successe in nessun altro posto: ad esempio, un giorno sono stato contattato dal direttore artistico di Canal Plus, una tv iper-commerciale, che mi ha chiesto di produrre dei piccoli film d’artista da inserire al posto della pubblicità. La Spagna è un Paese fantastico: la totale noncuranza verso la provenienza degli artisti, la facilità e la tolleranza eliminano il problema della xenofobia, almeno sul piano della creatività. Per il resto non so perché non ci vivo.
Sebbene sia stato reso noto il dato che ad Arco si compri molta arte spagnola, se non unicamente questa…
Essendo presente coi miei lavori in una decina di musei spagnoli, proprio non posso sostenere questa tesi. E spesso è capitato che mie opere esposte dalla mia galleria ad Arco venissero acquistate da musei. Perciò non posso essere io il caso. Il rapporto con la Spagna mi sembra meritocratico, non direi che vi siano massonerie. E poi c’è anche una notevole versatilità. Ad esempio, in altri luoghi ho avuto grandissime difficoltà e ho impiegato parecchio tempo prima di farmi recepire, oltre che come fotografo, come artista che fa mappe, che collabora con gruppi quali Multiplicity e Zapruder, o a far capire che adesso mi dedico anche ai film. Questa cosa in Italia è impensabile. Per dire, nel mio Paese poche collezioni acquisiscono miei film perché il film è una forma d’arte troppo recente. In Spagna questa comprensione è stata immediata: percepire che un artista che usa un certo tipo di medium può usarne anche altri. Il caso di Canal Plus è emblematico: chiamare delle persone considerate in Italia inadatte a fare televisione e pensare che l’arte può sposarsi benissimo col prodotto televisivo.
In effetti, l’arte contemporanea nella televisione italiana non ha alcuno spazio.
No, se non in RaiSat o in quei documentari noiosissimi su Boccioni e sul Futurismo che non fanno che allontanare i giovani dall’arte. Diciamo che la Spagna è un posto strano, per fortuna.
articoli correlati
Madrid, per la fiera Arco l’Istituto Italiano di cultura si fa vetrina per artisti e gallerie
Francesco Jodice con Gabriele Basilico da V.M. 21 a Roma
a cura di marta silvi
[exibart]