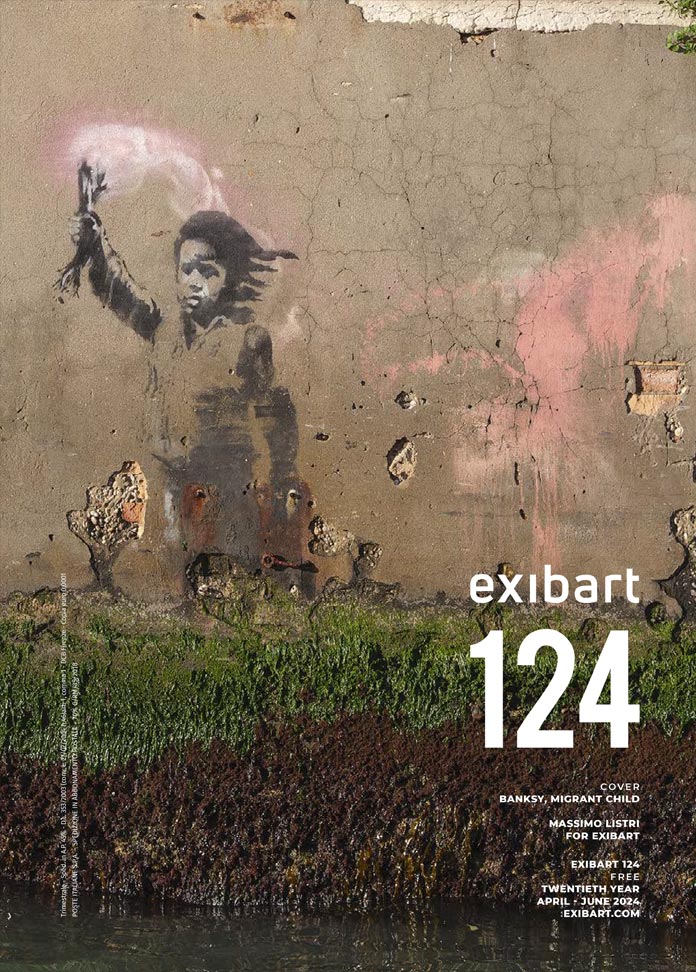Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
14
ottobre 2015
L’installazione, qui e ora
Progetti e iniziative
Pubblichiamo un estratto del bel saggio di Zuliani comparso su Arshake. Dove si mette a fuoco la problematicità di questo dispositivo tra dinamismo e simultaneità
Non so se davvero, come sosteneva qualche anno fa Ilya Kabakov, «L’installazione continua a rendere molte persone nervose. Talvolta è percepita come un ultimatum: “Arrenditi e mettiti di fronte al plotone di esecuzione”», ma se non è proprio di fronte ad un gruppo di fuoco che l’installazione pone lo spettatore, certamente non gli si mostra indulgente e tantomeno permissiva: nessuna distrazione è consentita nel suo separato recinto, all’interno del quale è richiesta non soltanto attenzione ma incondizionata adesione alle regole stabilite dall’artista, non sempre facili da comprendere e interpretare. Un’imposizione anche fisica, fatta talvolta di gesti e di percorsi obbligati che contraddice la giusta distanza modernista e costringe il pubblico ad oltrepassare la zona di rispetto della spectatorship per avventurarsi in un territorio sconosciuto, dai funzionamenti autonomi e dai confini incerti. In maniera più radicale di quanto proposto dal Minimalismo, dove pure, rispetto alla riduzione del visitatore a puro occhio imposta dalla lezione formalista, lo spettatore aveva conquistato un ruolo decisivo nell’attribuzione del significato dell’opera, l’installazione è dunque un ambito di necessario confronto (di scontro, persino) tra il progetto dell’artista e l’esperienza dello spettatore, un incontro che s’inscrive inevitabilmente sotto il segno dell’obliquità attuandosi, ogni volta, qui ed ora, in una specifica e comunque irripetibile condizione di spazio e di tempo.
Che l’installazione, in quanto medium che utilizza come supporto e materia lo spazio, sia comunque site specific, ovvero per sua complessa natura sia opera connessa in maniera inestricabile al sito in cui – in maniera temporanea o permanente – si offre al pubblico, è dato persino ovvio, di cui non ci sarebbe forse neppure ragione di discutere se oggi la site specificity (e quindi la site specific art) non fosse diventata una categoria curatoriale talmente estesa e comprensiva da non essere più criticamente efficace, una banale parola d’ordine – un mottampon – che non definisce più una precisa modalità di creazione, di produzione e di fruizione del lavoro ma ne indica una più o meno vaga ambientazione, avendo a tal punto perduto la propria capacità eversiva da diventare secondo Hal Foster un vero e proprio, assolutamente istituzionale, «evento da museo», quasi una condizione necessaria perché l’opera venga riconosciuta nel contemporaneo circuito espositivo.
In realtà, quando non viene ridotta a vuota formula, la site specificity è, innanzitutto, ricerca e sperimentazione, è una pratica (e un pensiero) di trasformazione, un processo, insomma, e non una definitiva asserzione che partecipa dell’infinita modificazione degli spazi i quali, lo ha sottolineato Michel de Certeau, rispetto ai luoghi, in cui «gli elementi vengo distribuiti entro rapporti di coesistenza», hanno natura dinamica, in quanto sono « incrocio di entità mobili». Se la site specific art può essere identificata da Nick Kaye con «un lavoro che tiene assieme la produzione, la definizione e la performance di un “posto”» è appunto perché lo spazio rispetto al luogo è – e cito de Certeau – «ciò che diventa la parola quando viene parlata, ovvero quando è colta nell’ambiguità di un’esecuzione, mutata in un termine ascrivibile a molteplici convenzioni, posta come l’atto di un “presente” (o di un tempo) e modificata attraverso le trasformazioni derivanti da vicinanze successive. A differenza del luogo non ha dunque né l’univocità né la stabilità di qualcosa di circoscritto».
Di questa instabilità, l’installazione, che è appunto spazio praticato, mette alla prova equilibri e tensioni, prendendo in carico il corpo culturale dello spettatore, che ogni volta ridisegna i dati modificandoli grazie alla sua stessa presenza di osservatore che ha, comunque, valore e potere performativo. Laboratorio di prossemica, l’installazione funziona dunque come un dispositivo costantemente attivo e in movimento, in un continuo e mutuo scambio con lo spazio e con l’esperienza del visitatore, quest’ultima condizionata anche dalla eventuale presenza di altri spettatori, il cui accesso viene regolato talvolta dallo stesso artista per esigenze che non sempre rispondono a semplici ragioni di sicurezza, ma che in molti casi corrispondono a intenzioni di poetica, alla necessità di offrire un’esperienza emotivamente più coinvolgente ed esclusiva. Il pubblico viene così nuovamente sottoposto all’autorità indiscussa dell’artista-demiurgo che, una volta reso privato lo spazio pubblico con un gesto di chiusura che delimita i confini e i funzionamenti dell’installazione, può scegliere poi di aprire quello stesso spazio secondo le modalità più disparate, nella consapevolezza che, in ogni caso, non si sanerà mai la frattura fra il proprio progetto d’installazione e la sua significazione, frutto ogni volta diverso della narrazione (dell’itinerario) di cui il visitatore è artefice.
Come ha chiarito Miwon Kwon nel suo seminale saggio One place after another. Site-specific art and locational identity, le relazioni tra l’arte e il suo sito costituiscono infatti «un predicato inconcluso», articolandosi secondo paradigmi che non definiscono né una cronologia né una gerarchia. Poco importa che a prevalere nell’interpretazione dell’artista, e quindi nell’organizzazione dell’opera, siano le dimensioni geometriche o le coordinate storiche e sociali del sito, esso ha in ogni caso carattere culturale, sia che si collochi all’interno del tradizionale sistema espositivo – musei, gallerie, fiere…- sia che appartenga al più ampio orizzonte urbano o al paesaggio naturale, frutto anch’esso, del resto, di un processo di riconoscimento e di costruzione culturale. (…).
Al di là, comunque, di ogni distinzione relativa alla sua collocazione e alla sua durata (…) e qualsiasi sia la sua configurazione, che abbia carattere prevalentemente teatrale o che segua piuttosto il modello, oggi molto diffuso, della collezione e dell’archivio, l’installazione è sempre un racconto, un itinerario più che una mappa, un’azione sempre specificamente situata, nello spazio come nel tempo: hic et nunc, appunto.
Where are we now? Questo era il titolo della quinta biennale di Marrakech, una domanda che è, naturalmente, un programma di lavoro, un’indicazione di metodo che ben corrisponde all’inquietudine del nostro presente, allo smarrimento vertiginoso che nasce da uno spazio indeterminato che ha bisogno di frontiere e ponti, zone di contatto che congiungano e oppongano, e da un tempo senza storia, una sorta di eterno presente privo di direzioni, una esasperata contemporaneità in cui tutto è incondizionatamente sincronico. Quella in cui siamo immersi è, per dirla con Bruno Latour, una mostruosa «Era della Simultaneità», uno stato di allucinante «presentismo» senza ombra e senza spessore a cui corrisponde un’estemporaneità irresponsabile e abbagliante, frutto avvelenato della crisi della modernità e dell’«esaurimento dello storicismo». Un’ebbrezza che cancella responsabilità e giudizio, potenziando all’estremo l’immediatezza sensoriale, con cui l’arte contemporanea ha dovuto fare i conti, proponendo strategie diverse per elaborare la diffidenza nei confronti del tempo e della storia che ha segnato la seconda metà del Novecento.
Di questa faticosa riflessione in opere e in azioni sulla temporalità e la sua crisi, l’installazione si è rivelata uno degli strumenti (e delle soluzioni) più efficaci in quanto la sua intrinseca attualità, legata all’esperienza presente dello spettatore, non può non misurarsi con la temporalità critica implicita nell’operazione di prelievo e di messa in forma di oggetti e di pensieri, oggetti e pensieri non rappresentati ma effettivamente presentati e, quindi, tradotti dall’orizzonte dell’uso quotidiano al recinto speciale dell’arte.
«Un’installazione è una presentazione del presente» ha detto Boris Groys dove però, ed è questione tutt’altro che secondaria, vengono a confluire i significati e i tempi composti di cui sono portatori, per nulla innocenti, i singoli elementi che trovano nuova collocazione nel dispositivo connettivo dell’installazione. Come ha chiarito Walter Benjamin, la citazione – nel caso dell’installazione, il prelievo – implica necessariamente un’interruzione comportando una frattura del contesto d’origine certo non priva di conseguenze rispetto alla tradizione e alla storicità. Si tratta di una rottura, un gesto distruttivo che è però presupposto di nuove verità.
(…) Nell’installazione l’artista opera una discontinuità nel tessuto della storia dell’arte, una rottura (uno spostamento, in realtà) nella tradizione che consente di problematizzare il passato e di istituire con esso non «un decorso», ma una relazione indiretta e attiva. Quello che si viene a creare nell’installazione è dunque un campo di forze, un movimento dialettico (…); l’infinita teoria di oggetti – davvero naturalia artificialia mirabilia – che s’incontrano e si relazionano nella scrittura dell’installazione, come pure gli immateriali elementi di linguaggio – i suoni, gli odori, le luci e le temperature – che ne delimitano il microcosmo avventuroso sono tutti portatori di un tempo specifico, di un passato spezzato e di un presente che continuamente si rinnova ed è libero dall’urgenza della cronaca anche quando ne riporta temi e frammenti. Citazioni, appunto, che in quanto tali hanno carattere eversivo, interrompono il flusso della storia e lo riscrivono in altri discorsi, in configurazioni a cui lo spettatore attribuisce senso ulteriore irrompendo con il proprio tempo soggettivo in una temporalità che, proprio come accade per l’archivio, porta in sé, lo ha sottolineato Derrida, un incessante cominciamento: «Arché, ricordiamocelo, indica assieme il cominciamento e il comando». Perché quando non cede alle lusinghe di un’istantanea adesione alle emergenze del presente, assecondando l’ingenua (e talvolta opportunistica) ambizione, in ogni caso destinata a venire prima o poi delusa, di essere ad ogni costo up to date, anche l’opera che più sembra nutrirsi dei fermenti dell’attualità politica e sociale non vive mai soltanto dell’immediato presente, il suo tempo, che non è, vale la pena sottolinearlo, quello della sua permanenza, è un tempo inconcluso, denso, più lento o più veloce, comunque imperfetto. Anacronistico, persino…
Estratto da S. Zuliani, Senza cornice. Spazi e tempi dell’installazione/Without a frame. Spaces and times of the installation, Arshake, Roma 2015. Critical Grounds #04, collana a cura di Antonello Tolve e Cristian Caliandro (www.arshake.com/senza-cornice-spazi-e-i-tempi-dellinstallazione/)
Foto in home page: Philippe Parreno’s ‘H{N)YPN(Y}OSIS’, Park Avenue Armory, NYC
In alto: Christian Boltanski, Personnes, HangarBicocca, Milano