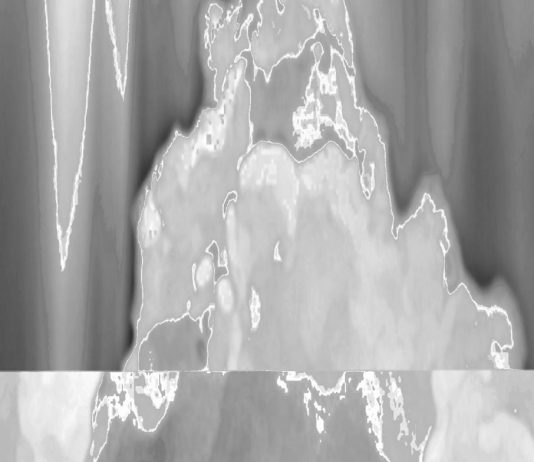Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
-
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
-
26
luglio 2017
Raccontare i migranti? Si può solo con l’arte
Progetti e iniziative
Dopo la “Grande Madre”, a Milano è la volta della collettiva sui nuovi Dannati della Terra. E se l’arte è serena, le inquietudini sono tutte per noi
Dopo l’apertura della mostra di Massimiliano Gioni, “La Terra Inquieta”, la Triennale ha ospitato la seconda edizione del Festival dei Diritti Umani. Durante uno dei talk Michelangelo Pistoletto è stato invitato a rispondere alla domanda: A cosa serve l’arte se non cambia lo stato delle cose? Certi grandi interrogativi suggeriscono da subito l’impossibilità di giungere ad una risposta. Ma forse vale sempre la pena l’interrogazione, dal momento che proprio la domanda di quel breve incontro ritorna come un’eco sopra la grande collettiva dedicata alle migrazioni e ai rifugiati. Una mostra promossa da due grandi istituzioni, Fondazione Triennale di Milano e Fondazione Nicola Trussardi, apprezzata e premiata dal pubblico ma allo stesso tempo oggetto di una certa diffidenza da parte degli addetti ai lavori.
“La Terra Inquieta” è una mostra didattica, dalle aspirazioni quasi enciclopediche, un percorso lungo e non poco impegnativo. In scena più di sessanta artisti provenienti dai due emisferi del mondo che affollano le sale per raccontare la nuova ossessione occidentale: la crisi delle grandi migrazioni che sconvolgono il panorama geopolitico mondiale, lacerando i confini fisici e esacerbando la percezione sociale dell’Io e dell’Altro. Ma a cosa serve fare una mostra sulla crisi dei rifugiati? «L’arte offre nuove prospettive e punti di vista sulla realtà, restituendone una visione complessa – spiega Beatrice Trussardi – l’obiettivo di questa mostra è trovare un modo di parlare alle persone delle loro stesse preoccupazioni, offrire esperienze che si trasformino in conoscenza e consapevolezza».
Se nella puntuale introduzione del duetto Gioni-Trussardi, tutto riguardo alla mostra suona semplice e bello, dall’apertura ha aleggiato un clima di interrogazione e sospetto. Un po’ un processo alle intenzioni, su alcune questioni delicate da affrontare. Per cominciare, un obiettivo tanto sentimentale quanto ambizioso, una costosa macchina espositiva, un tema disgraziatamente di moda, il sempre facile sospetto di una vanesia strumentalizzazione da parte di organizzatori e artisti. Chi può dirlo, lo ha già detto: ci sono tutti i nomi e i cognomi più in vista, le grandi installazioni su commissione, i cavalli di battaglia delle gallerie. In un momento in cui ogni elemento di questo dramma diffuso porta con se un nuovo fattore di crisi, è forse giusto che anche l’arte subisca lo stesso processo, come sta succedendo alle Ong e ai programmi di soccorso e accoglienza? Non si scherza con i drammi della storia, ma bisogna poi ammettere che l’atteggiamento schizofrenico del mondo dell’arte nei confronti di se stesso svilisce e non aiuta. Non siamo forse stati noi a recriminare una certa frivolezza a questa Biennale di Venezia? L’aderenza dell’arte alla realtà e al presente è consapevolezza o strumentalizzazione? E poi, in fondo, chi altro più degli artisti è seriamente esperto nel valicare i confini?
ROKNI HAERIZADEH The Sun Shines on a Graveyard and a Garden Alike, And The Rain a Loyal Man From a Traitor Knows Not, 2016-17 Courtesy Rokni Haerizadeh and Gallery Isabelle van den Eynde, Dubai
Barconi, uomini, donne e bambini, corpi ammassati. Considerando il bombardamento mediatico a cui siamo sottoposti ogni giorno, come si può pensare di risvegliare la sensibilità del mondo attraverso le immagini? Eppure oggi siamo soliti credere che sia esattamente questo il ruolo dell’arte: trovare nuove modalità con cui rappresentare parti (iper)visibili e familiari della realtà, concedendoci punti di vista inaspettati. E nonostante tutto, le opere selezionate per questa mostra non vengono meno, per varietà e qualità, a questo presupposto.
La sensazione nelle sale de “La Terra Inquieta” è quella di entrare in un meccanismo inglobante, dove il vasto numero di opere garantisce ed esaspera la rappresentazione di un tema su molti livelli, come se nessun occhio – attento o meno che sia – possa uscire illeso da questo circuito di immagini dove la nostra sensibilità e capacità di immedesimazione può confrontarsi con prove più o meno difficili. Non è un caso che le fotografie di Aris Messinis condividano lo spazio con i disegni di Rokni Haerizadeh. Sulla parete, una carrellata di scatti di migranti stipati su precari barconi in attesa di essere soccorsi, immagini riconoscibili dal mondo del fotogiornalismo, scene che abbiamo visto milioni di volte, crude e reali, ma che abbiamo imparato a digerire. Nelle bacheche, invece, i disegni colorati e grotteschi dell’artista iraniano trasformano le figure di sfondo in creature misteriose. Come a seguire lo storyboard di un film di fantasia, lo sforzo visivo di riconoscere quali scenari si celino sotto il colore attiva in maniera immediata e leggera la partecipazione di chi guarda. È come nei giochi della Settimana Enigmistica: la curiosità di svelare cosa si nasconde aguzza lo sguardo al di là delle nostre stesse aspettative. Arriva solo dopo il senso di crudeltà e di violenza che riaffiora riconoscendo l’ambientazione: scene di guerra dal conflitto siriano.
BOUCHRA KHALILI The Mapping Journey Project, 2008-2011, foto © Gianluca Di Ioia – La Triennale
Su questo stesso registro, ogni opera in mostra raggiunge una nota diversa. Le grandi installazioni del piano superiore, come quelle di Hatoum, Attia e il barcone Abdessemed, ricorrono ad un lirismo drammatico per evocare negli oggetti muti la portata della propria sciagura. La serie di video Mapping Journey di Bouchra Khalili è invece uno snodo principale della mostra. Un’opera del 2008 dove, attraverso le voci e le mani dei migranti (ma non i loro volti), conosciamo le tappe improbabili dei loro lunghi viaggi. Un segno di inchiostro va su e giù su una mappa e racconta più di quanto le statistiche o le riprese di mille sbarchi riescano a fare. Niente sentimentalismi, si percepisce, invece, una sorta di distanza di rispetto dell’artista nei confronti dei suoi interlocutori.
T.J. Demos (il cui testo in catalogo ripercorre una ricerca decennale dell’arte, quella del rapporto tra gli artisti e l’esilio, la diaspora e la migrazione) le chiama immagini migranti. Ed è questo un altro assunto della mostra: il suggerimento di concedere spazio ad una rappresentazione informata, consapevole ma complessa, la cui comprensione richiede quindi il contributo e la condivisone di chi guarda per arrivare a definire un significato. E se Demos parla di negoziare il significato, Édouard Glissant, il poeta che da il nome a questa mostra, ci suggerisce invece la via dell’opacità, di considerare cioè il diritto di ognuno a non essere compreso totalmente e non comprendere totalmente l’altro. “Ogni esistenza ha un fondo complesso e oscuro, che non può e non deve essere attraversato dai raggi X di una pretesa conoscenza totale. Bisogna vivere con l’altro e amarlo, accettando di non poterlo capire a fondo e di poter essere capiti a fondo da lui”, spiegava Glissant a Claudio Magris in un’intervista del 2009.
RUNO LAGOMARSINO Mare Nostrum, 2016 Courtesy Francesca Minini, Milan and Collection Agovino, Naples
La macchina dell’informazione mediatica colpisce soprattutto grazie alla capacità di giocare su due opposte reazioni: immedesimazione o rifiuto. Anche l’arte è racconto per immagini, ma essa si concede passaggi a volte più complessi. Il lavoro di Francis Alÿs fa appello alla nostra capacità di interpretazione delle metafore. Le sue hanno la limpidezza di storie per bambini, la cui estrema semplificazione spoglia la cronaca del rumore contingente per ritornare ai suoi principi fondanti: noi/gli altri, dentro/fuori, aperto/chiuso. Più i concetti si fanno semplici, più denunciano la natura paradossale di questa condizione di crisi. Così, nella performance Don’t Cross The Bridge Before You Get To The River i bambini che abitano le due coste dello Stretto di Gibilterra si divertono a creare un cordone immaginario risvegliando il nostro ottimismo e un certo senso di umanità, ma il rumore incessante delle onde che si infrangono sul video non ci risparmia da un sottile sentimento di minaccia. Anche nei video di Isaac Julien i rifugiati si trasformano in performer e attori, che in questo caso esplorano luoghi desolati ma affascinanti, miraggi di terre bellissime come le coste della Sicilia. L’artista utilizza il suo potere per concedere una sublimazione estetica alla condizione del naufrago, ma solo con lo scopo di restituire ad una certa umanità il proprio posto nel regno della bellezza.
In questo calderone di storie e immagini più o meno toccanti (alcune forse esageratamente, come la collezione di oggetti ritrovati dopo la tragedia di Lampedusa e raccolti dal Comitato 3 Ottobre) ciò che dovrebbe portarci a ragionare è proprio la capacità degli artisti di trattare ogni tema con la stessa dignità. Che sia un argomento delicato come la crisi dei rifugiati, la propria biografia o il mondo pop, l’arte prende tutto per buono. È questa la cosa che ci fa arrabbiare? Eppure noi non siamo né più né meno innocenti, come ci ricorda Phil Collins nel suo video How to make a refugee (1999). Un making of dei profughi come li vogliamo noi, un vero e proprio set fotografico volto a costruire l’immagine perfetta di una famiglia di rifugiati del Kosovo per la stampa internazionale. Esercizio critico sul nostro modo di vedere, l’opera di Collins rivela quanto sia sfortunatamente impopolare il concetto di opacità, perché siamo forse troppo abituati ad accettare solo quello che ci somiglia, o che per lo meno rispetti i nostri canoni visivi.
STEVE MCQUEEN Static 2009, courtesy Steve McQueen, Marian Goodman Gallery Parigi & New York e Thomas Dane Gallery, Londra
La differenza tra i mezzi di comunicazione e l’arte è che quest’ultima dichiara le proprie strategie di rappresentazione, spesso consegnandone le chiavi del successo alla volontà del proprio pubblico. Possiamo indignarci davanti ad una rappresentazione troppo bella o troppo cruda dell’essere umano rifugiato, possiamo concederci di rimanerne suggestionati oppure denunciarne l’artificio e la strumentalizzazione. La verità non è univoca ma complessa, questo le opere almeno ce lo consigliano.
Quello sui cui vale forse la pena soffermarsi ancora un momento, è il fatto che abbiamo aspettato che fosse l’allarme, la paranoia mediatica, la dilagante xenofobia a risvegliare l’attenzione su una pratica artistica che, da almeno un ventennio (lo dimostrano le opere storiche in mostra) ha forse avuto la decenza e l’accortezza di porsi più domande, di dedicare più spazio, più tempo e umanità a quello che accadeva nel mondo.
Molti degli artisti presenti ne “La Terra Inquieta” vivono come stranieri in un altro Paese, provengono da luoghi attraversati dalla guerra, da territori occupati o confinati da muri. Qual è la loro identità? Quale la loro lingua?
Non a torto potremmo definire la nostra come l’epoca dell’identità in cui la crescente globalizzazione è accompagnata da continue rivendicazioni identitarie, e le guerre di faglia, cioè quelle che affondando le radici nelle identità dei popoli, continuano ad esistere. Secondo una certa corrente di pensiero, il concetto d’identità è un veleno di cui sarebbe consigliabile fare a meno. Essa definisce un noi che si distingue necessariamente da innumerevoli altri e che afferma la propria esistenza nella conservazione e nella chiusura rispetto a qualsiasi alterità. Sostituire il concetto di identità con quello di riconoscimento sposterebbe il nostro pensiero dalla logica delle entità a quella delle relazioni: ed è a questo spostamento di senso che molte delle opere in mostra tentano di accompagnarci. L’umanità descritta dagli artisti de “La Terra Inquieta” si costruisce attraverso la relazione, il riconoscimento in termini di universale umanità. Come scrive ancora T.J Demos, “Universalizzare la condizione umana del migrante è un impresa impossibile e per questo, pensabile solo attraverso l’arte”.
Roberta Palma