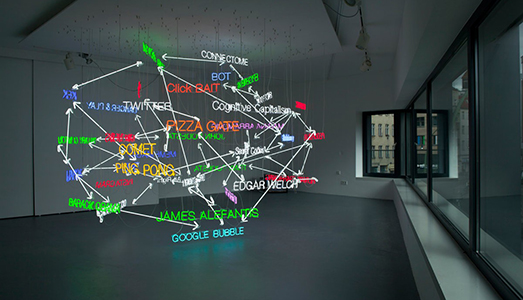Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
03
gennaio 2015
ALLONS ENFANT/7
rubrica curatori
Adelita Husni-Bey è l’artista che risponde alle domande di Andrea Bruciati nel settimo appuntamento con la rubrica dedicata ai giovani del panorama italiano
Ti propongo un alternativa che è distante da ciò che esiste. Tu rispondi: “molto interessante, ma è utopico”. Ti propongo qualcosa che è vicino a ciò che già esiste, e tu rispondi: “Possibile, ma banale”. E quindi nel corrente clima delle opinioni, tutto ciò che viene proposto sovente appare o utopico o banale. Avviene quindi una sorta di afasia programmatica, un disorientamento. Nasce dall’incomprensione della natura stessa della programmazione. La programmazione non è un progetto; è una successione; non è un architettura, è musica. Quello che distorce ancor di più questo falso dilemma è che abbiamo perso la fede in una visione storico- strutturalista. Non crediamo più nelle grandi narrative, come il Marxismo. Come risultato, questa nostra incapacità di capire cosa significhi il cambiamento strutturale, ci porta a una comprensione meticciata del realismo politico come equivalente alla prossimità all’esistente. Se quindi pensiamo che solo ciò che già assomiglia all’esistente è realistico, a cosa serve avere una visione?
Roberto Unger su Social Sound Bites
www.socialsciencespace.com/2014/01/roberto-mangabeira-unger-what-is-wrong-with-the-social-sciences-today/
Comincio la nostra conversazione con un frammento di una trasmissione radiofonica: vivendo con una valigia da 4 mesi mi mancano i miei libri, all’inizio volevo mandarti la definizione della parola “mancante”. Questa parola definisce il mio stato. Uno stato che pare all’inizio allettante, ma che è fondamentalmente dettato da una nostra condizione diffusa, il “precariato volante” come l’ha definita un amico, riferendosi al continuo spostarsi, sradicarsi degli “operatori culturali”, per portare a termine, a morsi, dei progetti. Mi chiedo perché?
Hai letto il volume il Radicante? Potrebbe essere una risposta.
«No, non l’ho letto ma ho ben presente Estetiche Relazionali. Devo dire che a suo tempo è stato formativo, ma forse lo sono stati ancor di più i testi di Claire Bishop che criticavano (e criticano) la “relazionalità” osannata da Nicolas Bourriaud. Una relazionalità che avviene nello spazio espositivo, esemplificata nei lavori di Rirkrit Tiravanija, dove lo spazio museale viene utilizzato come se fosse neutro ed aperto alla partecipazione, mentre non lo è».
Da dove proviene la tua formazione?
«Ho avuto una formazione accademica e ho studiato Belle Arti a Londra anche se mi sono presto convinta di ciò che pensava l’artista Douglas Huebler. “Il mondo è pieno di oggetti, più o meno interessanti, non desidero aggiungerne altri”, sosteneva, e sono d’accordo. Questa frase mi fece pensare alla funzione dell’arte e alla sua attualità; in fondo perché essere artista, adesso? Da qui sono poi passata a studiare sociologia alla Goldsmiths e mi sono trovata molto più a mio agio, anche perché potevo studiare campi cui ero istintivamente più attratta ed erano a me congeniali. Temi come le dinamiche strutturali, istituzionali, disciplinanti delle società occidentali contemporanee, l’insinuarsi dell’egemonia neoliberista, erano di estremo interesse. Vorrei aggiungere che la formazione proviene poi da talmente tanti eventi, che è riduttivo solo parlare di università o di luoghi specifici deputati».

Alcuni punti focali della tua ricerca.
«Mi interessa raccogliere dei momenti di negoziazione complessa, strutturare frame-work pedagogici per stimolare la coscienza critica, mia e di chi partecipa. La pedagogia anarco-collettivista è stata fondamentale per scoprire a adottare delle metodologie che mettessero in discussione la nostra idea di normatività in relazione all’autorità e al potere. In particolare mi riferisco al lavoro di Augusto Boal e Paulo Freire, ma anche a Francesc Ferrer y Guardia e Ivan Illich».
In che modo operi attraverso i lavori questa metodologia anarco-collettivista?
«Le metodologie educative anarco-collettiviste hanno lo scopo di stimolare la criticità dell’individuo, di stimolare le capacità di analisi delle dinamiche di potere insite nel rapporto tra autorità/ istituzione e individuo/ collettività. Sono “programmatiche”, nel senso inteso da Unger, non offrono architetture fisse ma programmi in divenire, scolpiti dalle operazioni delle loro varie incarnazioni. Ad esempio attraverso “l‘educazione integrale” di cui parlano inizialmente il teorico anarco-collettivista Bakhunin nel 1869, e poi Peter Kropotkin nel 1898, il cui scopo era “il favorire la sparizione della differenziazione perniciosa tra colletti blu e colletti bianchi”. Nella pratica ciò significava fornire scuole alternative dove si potevano apprendere sia nozioni tecniche (artigianali), sia nozioni intellettuali complesse. Così nei corsi serali, gratuiti, della Modern School di Francesc Ferrer y Guardia, nel 1914, si imparava il taglio e cucito mentre si ascoltava un seminario sulla composizione delle strutture sindacali. Attraverso il mio lavoro spero di operare secondo questi principi: la primavera scorsa ho condotto un workshop con 40 studenti di un liceo romano: dopo un mese di preparazione, attraverso incontri con giornalisti, economisti e politici i ragazzi hanno dovuto scegliere di appartenere ad una categoria fra giornalisti, banchieri, attivisti, politici o lavoratori. Le categorie chiaramente non rispecchiano la complessità insita in un sistema reale ma era responsabilità dei partecipanti complicare questa semplificazione. I ragazzi dovevano, all’interno delle loro categorie, negoziare una risposta ai vari scenari che gli venivano proposti, l’obbiettivo della simulazione era il raggiungimento del potere. Attraverso vari momenti di astrazione dal gioco e di riflessione, oltre ad aver appreso tecnicamente come operano varie istituzioni, abbiamo potuto comprendere la profonda interdipendenza dei vari gruppi e la debolezza dell’influenza dei lavoratori in questo particolare contesto sociale. Attraverso l’avvicinamento affettivo, emotivo e fisico, oltre che intellettuale, alle particolari dinamiche di rappresentazione/ rappresentanza che i vari gruppi incarnano mi auguro che l’esperienza ci ha donato maggiore lucidità, e maggiore capacità di negoziazione rispetto a queste tematiche. La rappresentazione dell’esperienza attraverso un film (in questo caso, Agency- giochi di potere), che produco a workshop concluso, vuole cercare di far si che il senso pedagogico dell’esercizio filtri e possa mettersi in relazione con un futuro spettatore .

Un’opera che ti ha colpito e che ritieni a te vicina
«Sicuramente The Last Silent Movie (2007) di Susan Hiller, non so quanto mi sia vicino nella pratica ma è un lavoro profondamente empatico. Lo schermo è nero, e dapprima si sentono suoni che appaiono indistinti, si avvicinano a cinguettii, fruscii, poi lentamente si capisce che il susseguirsi di questi suoni è un linguaggio strutturato, la ricorrenza ritmica, la cadenza, il tono, ci si trova difronte ad una sintassi in divenire. Appaiono i sottotitoli, che traducono queste frasi, non ricordo con esattezza le parole, ma il senso è sempre poetico. Nel film la Hiller ha raccolto tutte le lingue che stavano scomparendo nel 2007, che solo pochi ancora sapevano parlare. L’era dell’antropocene (coniata dal biologo Stoemer, e dal chimico Crutzen), ancora non accettata dalla nomenclatura geologica ma informalmente entrata a far parte della filosofia contemporanea è la nostra era geologica corrente. L’era è attualmente caratterizzata dall’estinzione e dal cambiamento climatico indotti dall’uomo: secondo questa teoria, è la prima volta nella storia billionaria del nostro pianeta che è la nostra specie a guidarne le sorti in modo irrevocabile.
Venendo sempre al dato cinematografico, ultimamente ho rivisto anche Nobody Knows (Hirokazu Koreeda, 2004), un film giapponese su quattro bambini che vengono abbandonati per anni in un appartamento, dove si ritrovano a dover sopravvivere creando dei piccoli sistemi di sussistenza: a razionare caramelle, costruire case con dei cartoni. Non c’e’ nulla di disperato nella loro vita, nemmeno quando uno di loro muore, c’è solo un grande senso di calma e responsabilità reciproca. Ho visto anche Nostalgia de la Luz di Patricio Guzman, che contrappone la ricerca di nuovi corpi celesti all’interno di uno dei più grandi centri d’osservazione mondiali, nel deserto di Atacama, alla ricerca dei resti dei desaparecidos cileni nello stesso deserto, da parte di un piccolo gruppo di madri che sondano il terreno passo per passo da decenni».
Il tuo lavoro si svolge su diversi media: ci sono differenziazioni di contenuto quando li scegli oppure è un fattore secondario?
«Chiaramente ogni mezzo ha la sua poetica, la sua tecnica, il suo modo specifico di veicolare. Ultimamente, essendomi interessata a rappresentare la negoziazione impiego spesso il video, oppure il sonoro. Cerco di cogliere il dialogo, l’espressione, il tono, le parole utilizzate quando cerchiamo di esprimerci in relazione a ciò che ci circonda, a ciò che percepiamo come istituzione rilevante».
Qual è il rapporto fa superficie dell’immagine e densità dell’autentico?
«Qui non so come risponderti. L’immagine è necessariamente solo superficie? E in che modo è solo l’’autentico ad essere denso? Intendi pregno di significato?
Non trovo che l’immagine sia necessariamente “superficie”, è significante, nonostante sia una rappresentazione. L’autentico, se ti riferisci all’esperienza, non è mediata, ma è perciò più densa? Ci astraiamo spesso nella superficie dei nostri cellulari, entra in un bar e dimmi cosa vedi? L’autentico o la superficie?»

Quindi che importanza dai alla rappresentazione e all’esperienza nel tuo lavoro?
«Sicuramente nei miei ultimi lavori l’esperienza, che viene solo in seguito rappresentata, ha un suo peso specifico. É la prima fase pedagogica, dove tutti coloro che partecipano, me inclusa, si sottopongono alle regole del gioco, riflettono e vivono la loro esperienza. Il momento dell’editing invece, è il mio sintetizzare l’esperienza stessa per renderla fruibile in futuro, richiede quindi che vengano fatti dei tagli, che vengano applicati dei filtri. La rappresentazione dell’esperienza vuole quindi produrre una seconda esperienza pedagogica, dove chi viene a contatto con il lavoro in un momento distante da quello “autentico” può comunque usufruire, anche se in modo diverso, delle criticità del lavoro. Detto questo essendo i workshop filmati, ed essendoci trasparenza nelle intenzioni sin dall’inizio, tutti i partecipanti sono consci della rappresentazione che avverrà, ed essi stessi quindi performano, proiettandosi all’interno del potenziale lavoro. Questo per me è un aspetto interessante: il rapporto che si crea con la telecamera, con lo specchio futuro delle proprie azioni, una sorta di coscienza materiale».
Cosa intendi per sincerità nelle relazioni?
«Quando ti ho parlato di sincerità nelle relazioni intendevo le dinamiche professionali che si stabiliscono spesso tra artisti e curatori/critici, in particolar modo in Italia. Vorrei sentire delle argomentazioni sul perché il lavoro di un artista è più o meno valido/urgente e necessario; vorrei che fosse più spazio e spessore dedicato all’arte contemporanea non in nome di un sistema fragile composto per la maggior parte da sottozero pagati, ma da un lavoro riconosciuto come culturalmente essenziale. Se così non è, la colpa è di tutti “noi”, che vi operiamo felicemente con poca trasparenza, accentandolo.
Accettando il nostro operato come qualcosa di non necessario alle città che abitiamo e non sapendo (o forse non avendo voglia di) come argomentare, come lottare perché le nostre attività abbiano un valore pubblicamente riconosciuto. O forse semplicemente non lo hanno?»
Adelita Husni-Bey: Hanno un valore le nostre attività? Per chi?
Andrea Bruciati: «Intendi mie e tue? Per quanto mi riguarda l’attività ha di certo un valore fondante per il mio stare al mondo, altrimenti perché dovrei impiegare qui un tempo prezioso… Per chi? Credo fondamentalmente per noi stessi ma in quanto soggetti in relazione con l’altro».
A.H.B: Intendo le “nostre” in quanto legati dal nostro operato culturale, tu come critico, io come artista, noi come operatori culturali. Trovi che sia un termine troppo generale? Certo, l’attività ha un valore in se, ma trovo che a volte questo valore esista in esclusiva funzione di un mercato, e non delle potenzialità critiche che la cultura dovrebbe/ potrebbe avere. Non che la criticità e il mercato non possano convivere ma trovo che la bilancia sia sempre spostata dalla parte del clientelismo.
A.B: «Comprendo la tua analisi e sono ovviamente d’accordo ma credo anche che il lavoro sia l’unica pratica capace di darci un’alternativa, per quanto laterale o apparentemente scalcinata. Mi auguro sempre di poter trovare ossigeno e far respirare gli altri…»
Adelita Husni-Bey è nata il 15 agosto 1985 a Milano. Attualmente è senza fissa dimora.